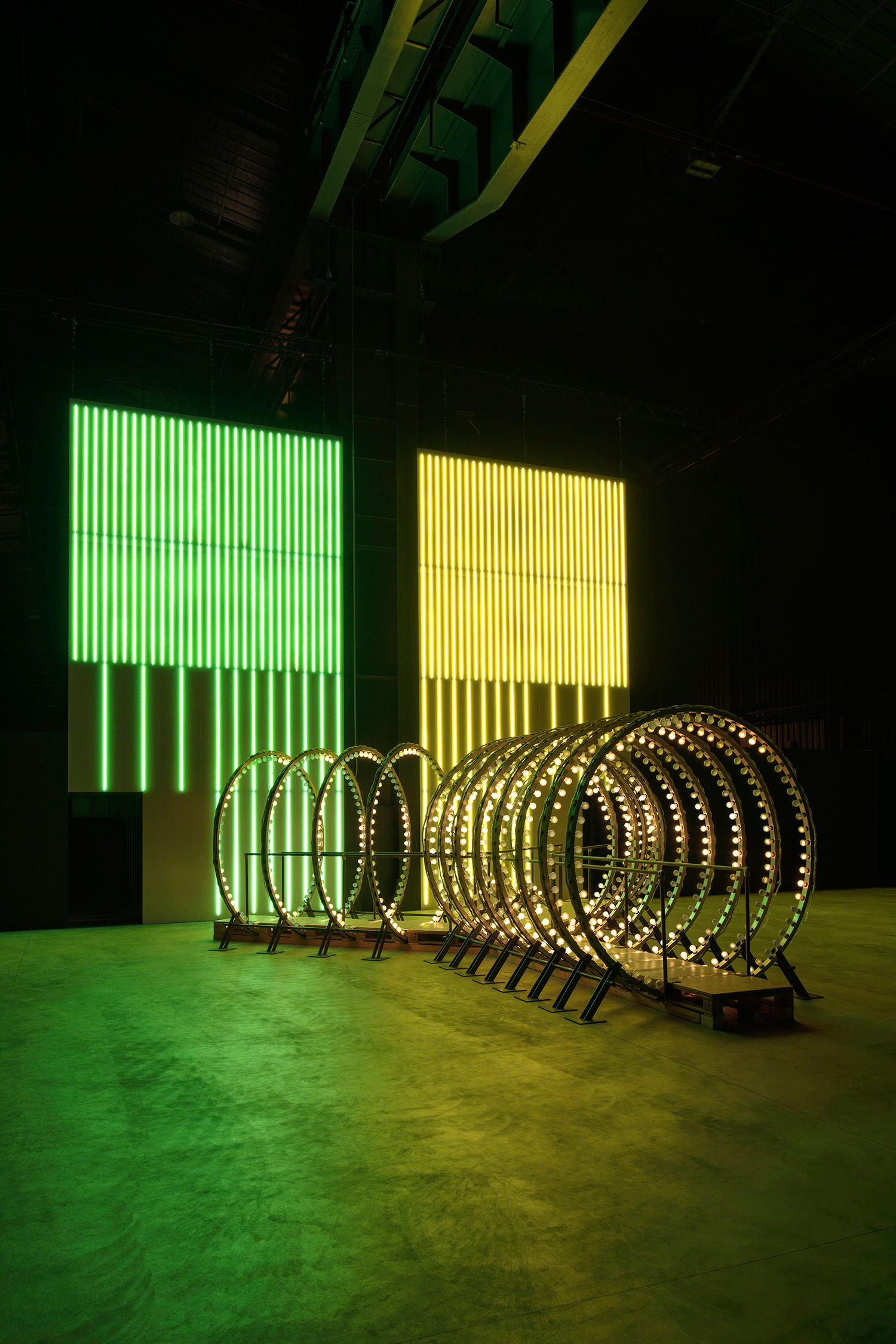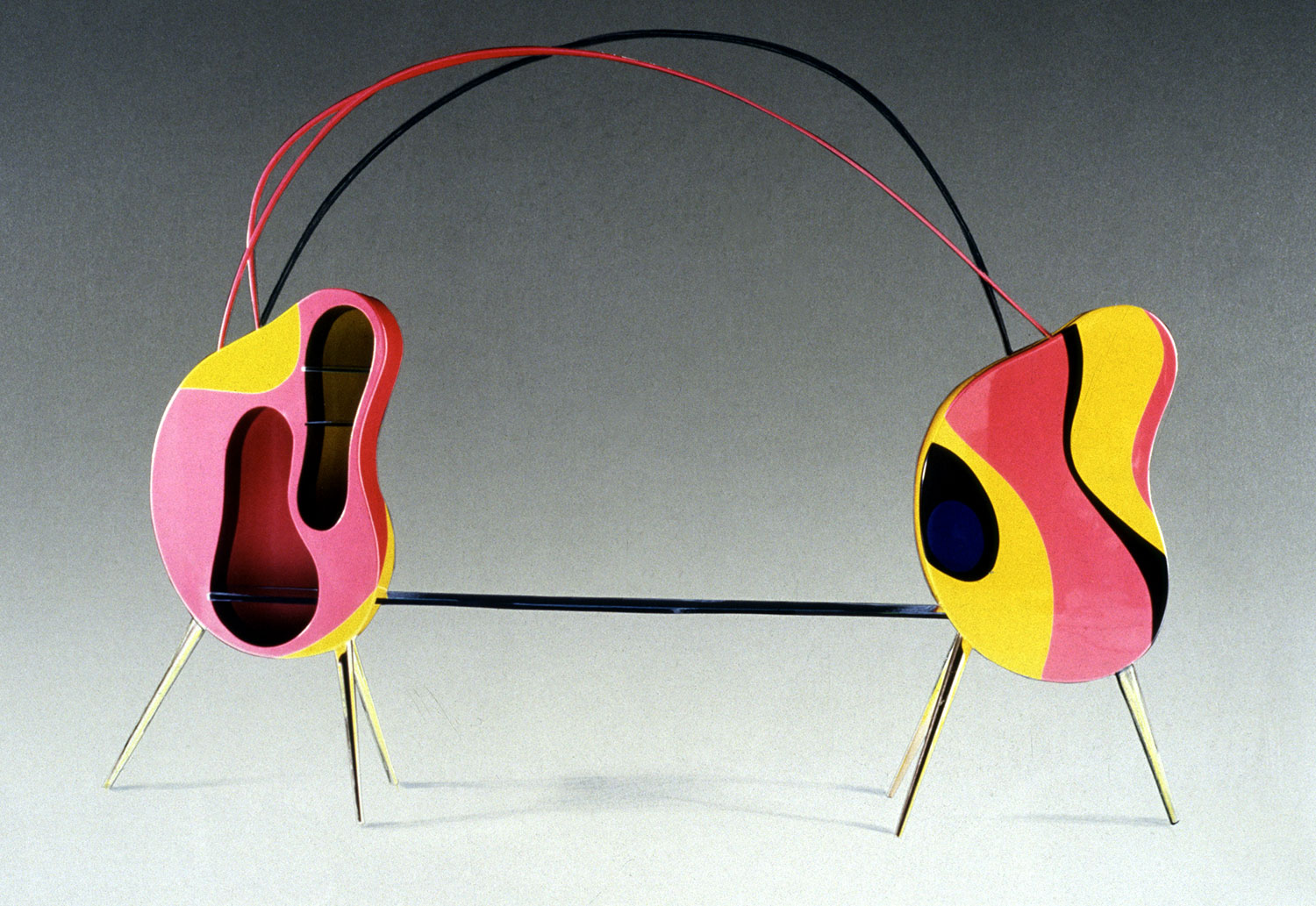Ogni volta che devo scrivere un saggio o preparare una qualche sorta di introduzione, e sono magari a corto di motivazioni o di ispirazione, se cosi vogliamo chiamarla, mi costringo a sfogliare il dizionario per controllare il significato di una o più parole. Essendo questa un’attività abituale, mi conduce sempre a qualche risultato. Questo atto apparentemente banale è, per me, sempre un atto di resistenza: leggo il significato della parola, i vari modi in cui essa può essere impiegata, le parole che precedono o che seguono il termine particolare che sto cercando. Un esercizio di vocabolario del genere assume, in se stesso, un’intima relazione con i temi o il tema che stiamo cercando di definire in questa sede, che è il problema delle divisioni del lavoro culturale.
Questo libro di definizioni, di regole, di significati “semplici” sembra comunque rivelare un consenso generale: una relazione sociale in cui, per puro caso, sembriamo vivere. Il dizionario, un libro apolitico che non ha nessuna agenda, un libro trasparente, un libro la cui unica, innocente funzione è quella di fare da punto di riferimento, da fonte per un’informazione neutra, precisa, un libro privo di legami con altri libri di letteratura, con la nostra oppressione, con il potere. Giusto?Questa divisione, questa distanza – come la divisione del lavoro, come la divisione fra pubblico e privato, come la divisione fra il femminismo e i salari inferiori delle donne, fra la crisi dell’AIDS e l’Associazione Medica Americana, fra le operazioni di salvataggio del Savings and Loan e il dibattito interno al National Endowment for the Arts – è una divisione preposta a servire a scopi molto precisi, uno dei quali è confondere; ovvero diffondere una qualsiasi formulazione di significato, una qualsiasi connessione, e forse, una qualsiasi azione. E dico solo “forse”. Ma un momento. Qual è il significato della parola “dizionario” nel dizionario stesso? Dunque, secondo il Merriam Webster, edizione 1974, che è quella in mio possesso, la definizione è la seguente:
“Dizionario: opera di consultazione che contiene parole, elencate di solito in ordine alfabetico, con le informazioni relative alla loro forma, pronuncia, funzioni, etimologia, significati, e agli usi sintattici e idiomatici”.
Ma, se mi è consentito chiederlo, dal punto di vista di chi? E quando? E perché? E chi era l’editore, o gli editori? Erano uomini o donne? Chi era il consulente editoriale? E qual è la storia di questo dizionario? I dizionari hanno sempre fatto parte della nostra vita? Il dizionario è un ulteriore atto di Dio? Chi ha fatto il primo dizionario e perché – perché ne nacque il bisogno? Forse per definire la lingua nazionale – la nazione? Per creare regole con cui mettere a confronto una nuova espressione? Oppure è semplicemente accaduto? Un bel giorno ci siamo svegliati e, voilà, ecco il dizionario.
Nel campo della cultura, tutto succede quando se ne sente il bisogno; quali che siano i mezzi con cui potremmo voler definire questo bisogno, anche se si tratta di oggetti e idee già a disposizione, questi vengono messi in primo piano solo quando la società sente che è arrivato il momento giusto. Ed è allora che emerge il bisogno. La divisione del lavoro, come la separazione ufficiale fra servizi pubblici e vita privata, è un contratto sociale a cui noi tutti aderiamo. Oppure, per dirla in maniera per noi più gratificante, è una divisione in cui siamo costretti a credere per riprodurre le regole della produzione e, in ultima analisi, per riproporre certe particolari forme di produzione e consumo: per far sì che il racconto prosegua. Non c’è dubbio, presto dovrò citare Louis Althusser.
Ma adesso torniamo all’innocente dizionario, pieno di sani, vecchi valori, e cerchiamo informazioni corrette sulla parola “praticare”, che è quella che ci interessa in questa sede.
“Praticare: eseguire, o elaborare ripetutamente, fino a raggiungere livelli di competenza; perseguire; applicare; fare o operare abitualmente; essere professionalmente occupati nell’esercizio di un lavoro; lavoro professionale”.
E per il momento basta così. Riformuliamo, per un attimo, il problema di fondo della discussione, ovvero: tu potresti forse considerare come certi tipi di produzione artistica costruiscano e rendano possibili determinati modi di impegno critico. Per esempio, la critica della storia dell’arte normativa, l’elaborazione di ideologie estetiche, la de- o la ri-codificazione della rappresentazione di genere delle identità etniche ecc., che possono in realtà scavalcare di buona misura gli attuali confini disciplinari della critica d’arte. E quindi, se l’arte può operare come una forma di “critica culturale”, non dovrebbe questo essere il compito anche di un discorso critico dell’arte? E inoltre: il riemergere della pratica dell’arte “attivista” apre la possibilità di una critica d’arte attivista? E questo è il punto finale del problema.
La crucialità di questi interrogativi sta nel fatto che essi sollecitano risposte specifiche, non generiche. E allora mi piacerebbe sfruttare quest’opportunità per riformulare la domanda: il significato di alcune parole, e quindi le risposte, o la risposta. Innanzitutto si devono fugare una serie di trappole ideologiche. E innanzitutto, spieghiamo che cosa è “l’ideologia”. Usiamo un testo politico come può esserlo un dizionario: un testo di Althusser. La sua definizione di ideologia recita: “L’ideologia è una rappresentazione della relazione immaginaria che l’individuo intrattiene con le condizioni di esistenza effettive”. Fra l’altro, mi piacerebbe anche esprimere la mia sorpresa sull’emergere dell’arte attivista. L’arte è sempre stata attivista. Resta da vedere solo al servizio delle attività di chi sia stata. Di quelli che vogliono tornare ai buoni vecchi tempi del maschio bianco, eterosessuale, monolitico, voce impostata; oppure, di quelli di noi che sono interessati a un po’ più di, dovrei dire, colore e struttura. Spero sinceramente che questo problema non si riferisse unicamente all’arte attivista, alla tipologia che ha a cuore l’inclusione, piuttosto che l’esclusione. Un tipo di arte che si preoccupa di dare a voci diverse la possibilità di essere udite e valutate; un tipo di arte che si sforza di rendere questo luogo un contesto migliore per un gruppo più ampio. Io credo che l’arte possa anche essere chiamata attivista. Ma stiamo attenti alle definizioni, e a chi le inventa, e a dove e quando le inventa. Non rendiamo facile a chi ci contesta inquadrarci e sezionarci così in fretta, così semplicemente, così “bianco e nero”, così “Hollywood”: buoni contro cattivi. In nessun modo dovremmo lasciar fuori dalla definizione di arte attivista quella produzione molto artistica, il cui impiego e la cui denominazione sortiscono il più dirompente effetto ideologico perché ci viene rappresentato come la norma, la regola, l’Arte con la “a” maiuscola: l’arte che si interessa solo dell’arte, il dizionario inerte dell’arte, la spiegazione normativa della buona arte. Questa produzione molto artistica è al servizio attivo di un altro ordine del giorno politico che può non coincidere col nostro, ma è senz’altro un ordine del giorno.
Come alcuni di voi sanno, la critica d’arte fu la prima categoria di finanziamento a essere eliminata, qualche anno fa, dal National Endowment for Arts. Non fu un caso, credetemi. Il genere di critica artistica che non si accordava con i gusti dei paladini culturali di destra era proprio di quel tipo che potrebbe, diciamo, ricontestualizzare l’oggetto d’arte entro un discorso sociopolitico di causa ed effetto. Un genere di critica d’arte che di colpo ha smesso di parlare dell’ispirazione frutto di una “passeggiata nei boschi”, perché ha compreso che un fatto simile non era possibile a questo stadio della storia, che nessuno vive in splendido isolamento, neppure l’artista. Questa nuova tipologia di critica d’arte, al momento attiva in altre direzioni, ha frantumato lo specchio ideologico in cui abbiamo riflesso la nostra immagine e l’oggetto d’arte, privo di ogni legame con la storia, gli eventi, le tematiche e le istituzioni che intercettano e influenzano il nostro modo di pensare e la nostra vita, persino nei suoi momenti più intimi.

Inoltre è il caso di sottolineare che la nuova critica d’arte è provenuta da moltissime donne e da alcuni giovanotti coraggiosi, che stavolta sono riusciti a includere preferenze generali e sessuali fra alcuni degli interessi che stanno dietro un certo modo di produrre e recepire l’arte. Precedentemente, suppongo, queste istanze erano state omesse per errore nei processo di stampa, non c’è dubbio! E ciò succede appunto perché un certo numero di artisti si stanno occupando di tematiche che si è sempre ritenuto di dover escludere. Dopotutto, nell’ottica della divisione del lavoro, agli artisti spetta eseguire cose molto specifiche, come per esempio produrre un’opera che possa completare l’arredamento di un’ambasciata. Lo Stato è totalmente fuori controllo: qualsiasi artista rappresenta al momento una minaccia; qualsiasi condanna a un artista è un attacco diretto alla spaurita famiglia americana. Grazie a Dio abbiamo ancora dei “padri difensori” che rivelano, a tutti noi, la verità. Basta guardare la TV e osservare gli spot elettorali: tutto ciò di cui abbiamo bisogno è lì. Appropriandoci di istanze come quelle della casa, dell’assistenza sanitaria, del diritti dei diversi, dei diritti delle donne, dell’ambiente, degli insabbiamenti del governo (e di molte altri atti non certo “familiari”), noi artisti, critici e storici dell’arte riorganizziamo, di fatto, la nuova divisione del lavoro culturale. Lo Stato esercita un controllo, non solo attraverso i metodi repressivi del suo apparato – come l’esercito, la polizia, la galera (per inciso, noi americani abbiamo il più alto numero di carcerati del mondo industrializzato), ma anche attraverso le sue diramazioni ideologiche – come le chiese, la famiglia, i media e, nella sua più recente incarnazione, attraverso il dibattito sul National Endowment for Arts. Quest’ultimo, tuttavia, non è un vero e proprio dibattito, ma piuttosto una presa di posizione retorica sulla libertà d’informazione. E il primo emendamento o la cosiddetta libertà di parola – che non è mai stata libera, ha sempre avuto un prezzo – riguardava la parola del bianco, maschio, eterosessuale, ovvero aveva alla base valori tradizionali. Non dobbiamo dimenticare chi sono quelli che hanno scritto la Costituzione “che protegge i nostri diritti”: per quanto sorprendente possa sembrare, la Costituzione non è stata scritta da ragazze madri di colore, né da operai inclusi in un piano di lavoro di tre giorni in qualche fabbrica di Chicago. No, è stata scritta da uomini bianchi liberi, con proprietà e titoli: è stata scritta da quello che io chiamo “l’Altro”. E allora se mai sarete invitati, o se sarete invitati ancora, a fingere che sia in corso un dibattito sulla libertà, e se siete produttori culturali, cercate di tenere a mente un paio di cose. Primo, non atteggiatevi ad “artisti”. Attenetevi scrupolosamente alla divisione del lavoro e non parlate di quanto sia importante per il vostro “io creativo” cospargervi il corpo di merda come metafora della lunga attesa prima dell’arrivo della metropolitana. No, dite piuttosto ai partecipanti – la famiglia americana – che forse bisognerebbe puntare l’indice su fatti come gli oltre cinquecento milioni di dollari stanziati dal governo per sostenere le orge degli anni Ottanta del Savings and Loan (per ogni dollaro speso in programmi sociali, ne spendiamo attualmente sei per salvare il S&L, per cui questo non è più il Welfare State, ma il S&L State). Attenetevi scrupolosamente alla divisione del lavoro, e snocciolate cifre e statistiche sull’aumento della mortalità infantile, sui nuovi casi di tubercolosi, sui tagli di spesa ai programmi di sostegno alle donne in gravidanza, ai neonati e ai bambini, effettuati da un’amministrazione che si suppone pro-famiglia, pro-ambiente, pro-istruzione.
Sì, attenetevi scrupolosamente alla divisione del lavoro e al vostro ruolo, alla divisione e ai ruoli che prescrivono come dovreste apparire e come dovreste agire; oppure, attenetevi alle cose che dovreste sapere in quanto artisti. Non date loro ciò che si aspettano da voi. Ristrutturate i termini della questione. Operate dei collegamenti. Stabilite delle priorità, e forse in questo modo saremo in grado di elaborare un nostro ordine del giorno, se abbiamo fiducia in noi stessi. Forse in questo modo, la nostra voce di opposizione sarà una voce più articolata, meno facile da sezionare e inquadrare in categorie. Una voce che esprime non solo una contestazione più diversificata, ma anche un’infiltrazione. Un’infiltrazione che sconvolge le aspettative del racconto, una voce, infine, che include noi tutti e che arriva a noi tutti. Una voce che sinceramente cerca la liberazione attraverso il significato e la ridefinizione, e attraverso una ristrutturazione delle cose secondo i nostri bisogni.