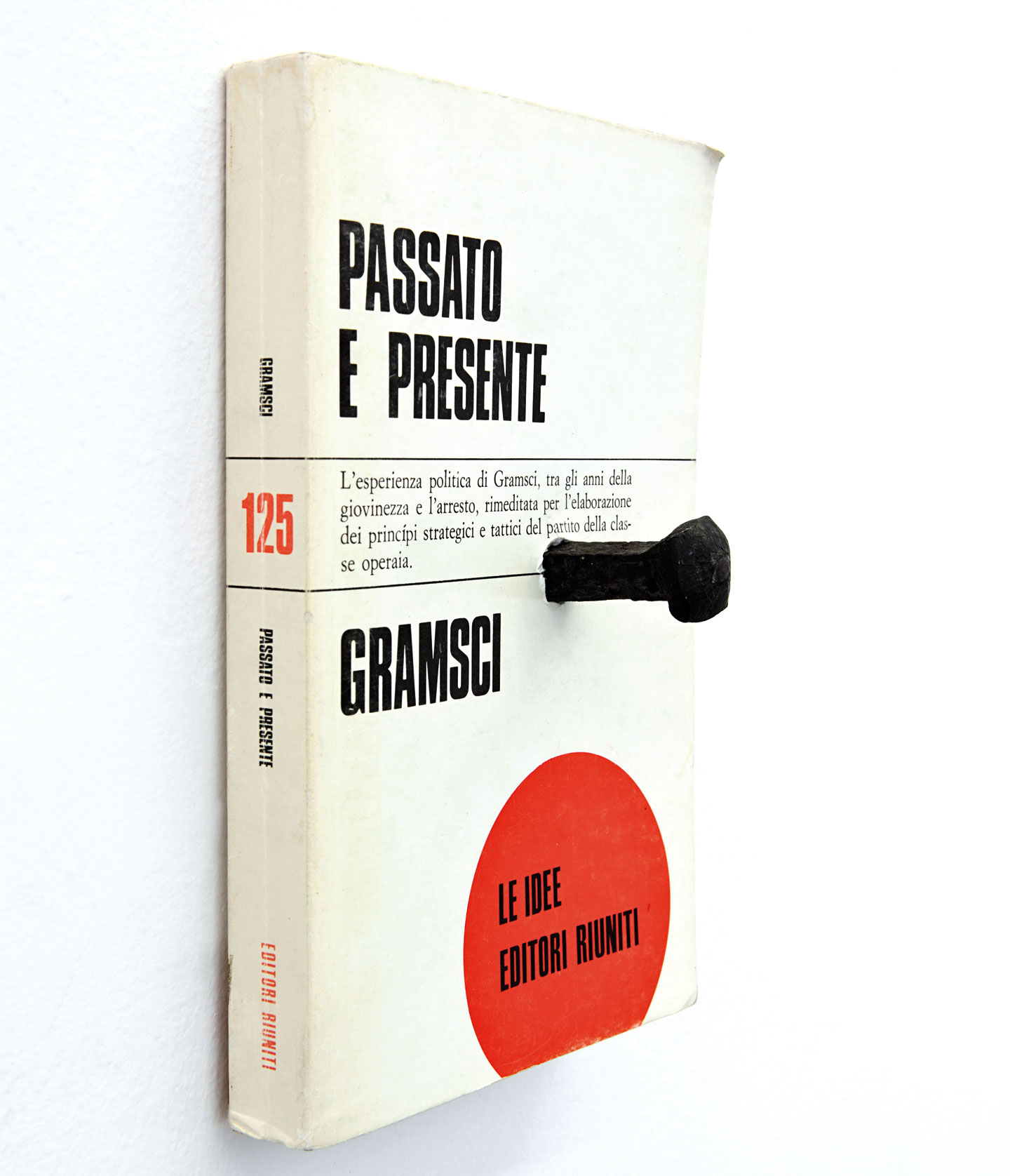Con “Schifanoia”, una recente personale presso Hester (New York), Daniele Milvio ha presentato una serie di lavori che attraversano il tempo secondo le modalità dell’impensato e del sintomo fondendo rimozioni e ritorni del rimosso, ripetizioni e rielaborazioni, tradizione e anelli mancanti. Il disegno anima dal profondo l’immagine, mentre il colore si dà come idea, espansione, gesto, servendosi di un oscillare di illusioni ottiche e di un cromatismo molto intenso. Ciò che in pratica viene messo in questione è una dialettica tra latenza e illatenza, apertura e chiusura, come la felicità e l’infelicità della pittura e il suo continuo processo di mutamento. Il titolo della mostra prende in prestito il nome del celebre palazzo eretto a Ferrara nel 1385 su commissione di Alberto V d’Este, voluto e pensato come luogo di ristoro in cui dedicarsi all’ozio — di fatto Schifanoia vuol dire letteralmente “schivar la noia”.
Delizia estense e non solo, gli affreschi del suo salone di rappresentanza, tra trionfi di divinità pagane, figurazioni di quotidiani affanni e dottrine astrologiche, sono uno degli esempi più alti raggiunti dall’arte rinascimentale profana nelle corti italiane del XV secolo. Eversivi e stravaganti, tormentati e stridenti, intrisi di ricerche erudite e di studi d’alchimia, vennero commissionati per volontà di Borso d’Este negli anni 1468-1470 e furono eseguiti dai rappresentanti della cosiddetta officina ferrarese. Schifanoia, alfabeti praticabili, un divertissment, uno stordimento del sé, ma anche un grado di concentrazione e autarchia assoluta, come dice lo stesso Milvio. — “Chi ben s’appoggia, cade di rado. Et esser costante non è altro, che stare appoggiato, & saldo nelle ragioni, che muovono l’intelletto à qualche cosa” — recita un passo dell’ Iconologia di Cesare Ripa che fa da chiosa alla mostra. In libero dialogo con la storia dell’arte, anche se poi è possibile che se ne perdano i possibili rimandi e la dimensione narrativa, quello di Daniele Milvio è un fare che, tra un certo gusto archeologico, forme arcaiche e clichè visivi, procede per accostamenti. Repliche in gesso, copie dozzinali di calchi di svariate epoche, echi di canti di guerra o di poemi eroici degli sciamani, fanno da supporto alla fisionomia morale del gesto.

Dettano un formicolio dei sensi che genera la struttura della rappresentazione e al contempo esprimono l’esperienza di una distanza dissolvendo l’immagine in un altrove atmosferico. Nella radicata convinzione che l’irrealtà renda più acuta la realtà, l’attenzione e la cura della pittura sono rivolte proprio verso un allontanarsi delle cose, verso una sparizione che è come un viaggio fuori dal nome. Trasformista e affabulatore, lo sguardo che si fissa su questa serie di lavori non si rivolge né all’autore né ad altri, non ammette né uno né molti punti di vista, ma riflette in sé la domanda della sua stessa presenza. Esso non coglie un vero e proprio oggetto della visione, piuttosto tende a illustrare l’enigma del suo stesso percorso. Distratta dal passaggio, l’immagine dichiara il disagio di non avere una dimora appropriata in cui stabilmente risiedere, ma la sua radice è paradossalmente questo strappo, in questa irriducibile mobilità va riconosciuta la sua dileguante essenza.