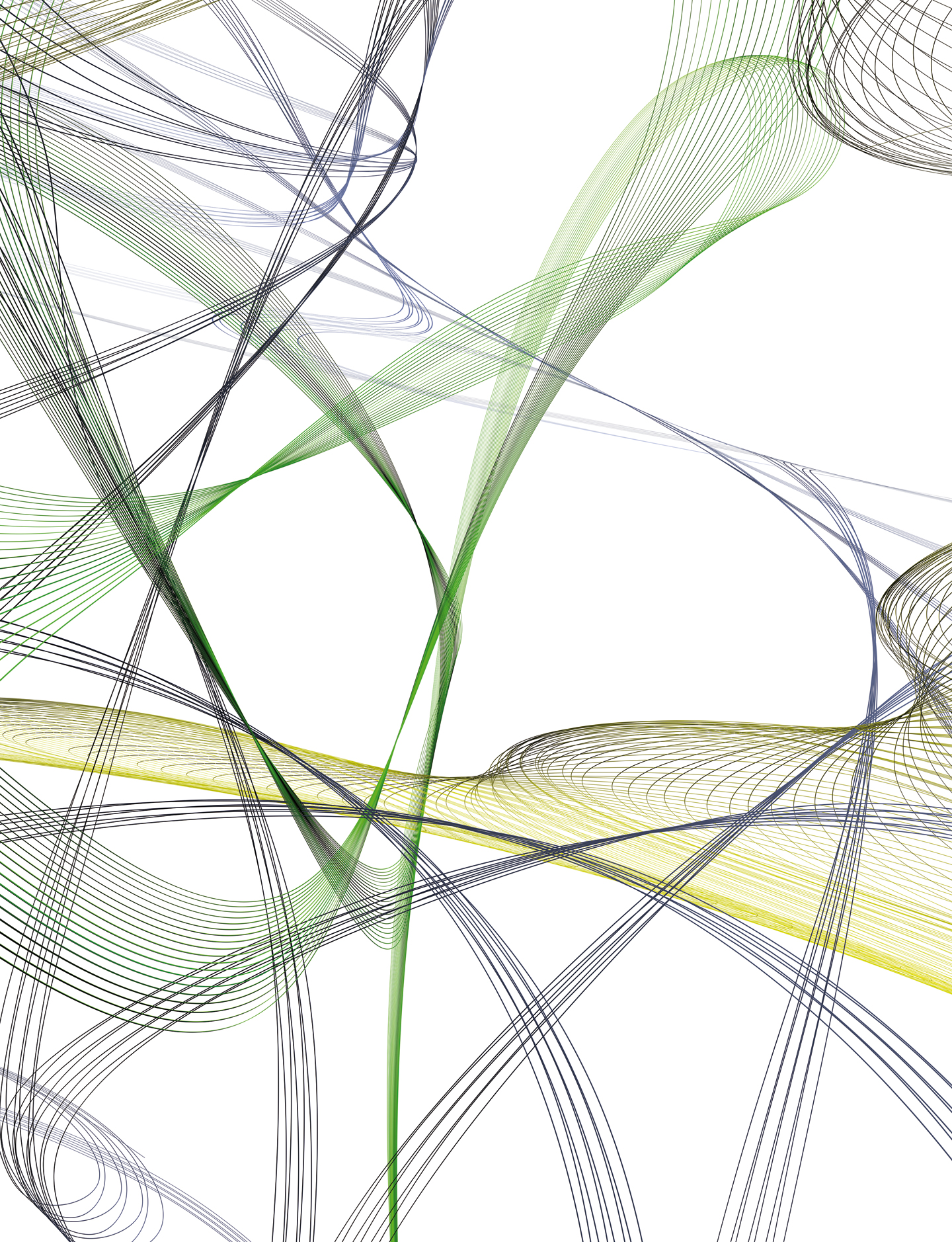I frati del Carmine di Siena, intorno al 1525, arrestarono il veloce pennello di Beccafumi a un passo dalla conclusione della grande pala con la Cacciata degli angeli ribelli, tuttora incompiuta e conservata presso la Pinacoteca Nazionale della città.
Si può ben immaginare fossero turbati dall’orda di corpi che ribolliva nel ventre della tavola; dagli ignudi che avanzavano slanciati ed energici verso di loro, ma se non ci fosse stato quel pudico rifiuto di certo non avremmo avuto il più poetico paesaggio d’inferno di tutta l’arte italiana, che Domenico espresse nel secondo assalto all’impresa, quella destinata alla chiesa di San Niccolò al Carmine.
Nello squarcio di vulcani e spelonche, nel labirinto di rocce aguzze, ponti vertiginosi e fondamenta di galere stazionano ombre malinconiche di uomini, colpite da riverberi e bagliori d’artificio. Non più le sagome affastellate di atleti urlanti, della precedente redazione, che scappano in ogni dove e fanno dell’inferno un’orgia muscolare, ma individui silenzosi che contemplano la desolazione, sotto la minaccia di un mostro e circondati da laghi bollenti di liquido giallastro.
Nel grande catino, che meglio suddivide la nuova composizione in tre fasce sovrapposte, la guerra civile degli angeli appare già conclusa, al loro posto sono le fonti luminose a continuare la battaglia: le truppe leali figurano beatamente assise attorno a Dio, il cui volto severo, deluso, appena si intuisce sotto una doccia di luce che lo oscura. Una pioggia che si irradia giusto alle ali, alla fronte e alle spalle dell’Arcangelo, inumidendo la spada e qualche lembo di panneggio con un lume di medusa. Non meno rilevanti sono i bagliori di fuoco che salgono dagli inferi, moltiplicati dai cunicoli e dagli specchi di acido. Un teatro inquietante e metafisico, che si fa grottesco solo nel boccascena, dove anche la buca del suggeritore diviene una fonte di zolfo e infiamma il ruggito recitato dal drago.
La prima versione precorreva tutta quella che sarebbe stata la retorica del Manierismo, gli schemi a incastro e la dominante fisica che porteranno a concepire immagini senza spazio, costruite unicamente dalle enfatiche torsioni dei corpi, come nei dipinti di Giorgio Vasari. La seconda invenzione, riducendo concitazione e traffico, rese invece molto più profonda la scena e in quella fascia mediana, tra paradiso e inferno, venne giocata da Domenico una carta di assoluta modernità poetica. Non è certamente un limbo, anche se la luce opalescente invita alla metafora, ma è quella parte di aria penombrina nella quale la caduta degli angeli ribelli potrebbe ancora fermarsi, se solo accorresse un pentimento. Alcuni volano nuotando sul lume vaporoso, uno sta rovesciandosi a precipizio, scomposto come una cavalletta sfuggita al becco di un falco. La luce crepitante ne profila le ali sfrangiate, d’inutile bellezza.
Prima di avvicinarsi all’altare, il secondo di destra nella chiesa senese, è l’intera parte inferiore della pala a sembrare un muso mostruoso d’animale, i cui globi oculari iniettati di luce diabolica vengono precisamente tracciati dalle arcate carcerarie e dal ponte di pietra. Allora acquista maggior senso anche lo sfoderare della lama da parte del San Michele e lo immaginiamo camminare in equilibrio sul grugno della gigantesca bestia. Forse la guerra intestina non è davvero conclusa, forse il dipinto ci ha descritto solo l’atmosfera di una tregua.