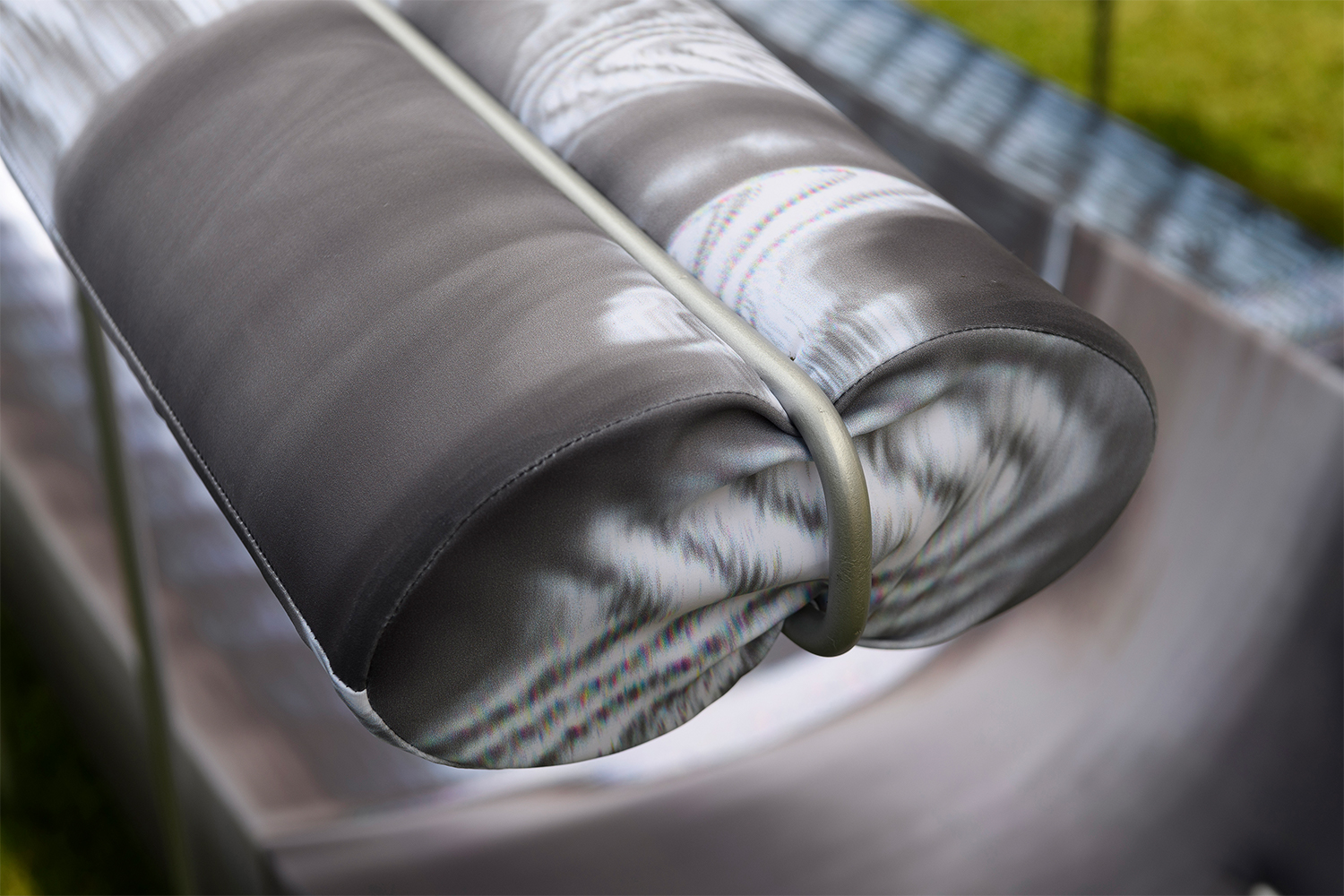L’atelier di Giulia Cenci è in una vecchia stalla di famiglia; qui erano allevate pecore e maiali. Quando ha intuito che era adatta al suo lavoro, ha passato una mano di calce. Ma l’odore degli animali che qui hanno vissuto non è andato via e aleggia ancora nell’aria. All’esterno ci sono vari attrezzi e macchinari agricoli che entrano a far parte del suo lavoro. Estremamente fertile in questi ultimi anni, ha preso dimensioni sempre più imponenti. Dopo la mostra al MAXXI di Roma e al Museo Novecento di Firenze, Giulia Cenci espone ne “Il latte dei sogni”, la 59a Biennale di Venezia curata da Cecilia Alemanni. dead dance (2021–22) è una struttura aerea che si snoda per centocinquanta metri in una calle veneziana. Associabile, come è stato fatto, a un’estetica post- apocalittica, in realtà c’è molto di più, come emerge dalla conversazione che segue.
Danza macabra
Riccardo Venturi: dead dance: così una calle veneziana come tante si fa luogo di una danza macabra. Se manca il movimento, è suggerito dalle contrazioni muscolari degli arti e, in modo quasi preistorico, dalla ripetizione di un solo elemento identico.
Giulia Cenci: Una delle opere che mi ha ispirata è la Danza Macabra di Bernt Notke a Tallinn anche se, assieme alla pittura antica, mi piace anche la dance degli anni Novanta. Da qualche anno mi interessa mettere in scena una sorta di coreografia dello spettatore.
RV: La tua scelta è andata subito a questo spazio?
GC: Sin dall’inizio era chiaro che l’Arsenale, spazio di per sé bellissimo, non si prestava al mio lavoro che, in genere, funziona male nelle collettive. È una questione di logiche spaziali e installative, del modo in cui un singolo elemento ha la capacità di generare un ambiente. A Venezia ho svolto diversi sopralluoghi, indecisa se utilizzare vari spazi esterni, ma avevo in mente un intervento più ampio e invasivo. All’inizio tuttavia non pensavo alla calle. Il mio modo di lavorare oscilla come un pendolo tra il fare e il progettare, tra un sopralluogo e il lavoro a studio.
RV: Spesso installato all’interno, il tuo lavoro si è anche confrontato con spazi aperti, come archipelago (2018) a Punta San Nicola (Favignana), per ricordarne uno.
GC: Esistono diverse opzioni che non si limitano all’alternativa secca chiuso/aperto. Lo scalone del MAXXI ricorda in parte un aeroporto o un centro commerciale; la calle veneziana è più idonea ma quando è vuota non ispira grandi cose; l’Arsenale è migliore di entrambi ma, come ti dicevo, poco adatto all’occasione. La calle offre delle condizioni speciali e una situazione complessa con cui volevo confrontarmi. Di certo una concentrazione di realtà migliore del white cube, che allontana il lavoro dalla vita. Perché, come ricordo spesso, la mattina non ti svegli in un white cube ma nel caos della vita, in un ambiente che offre diversi livelli di comprensione della realtà lontani dall’isolamento generato dal cubo bianco.
Dunque, non si tratta tanto del binomio esterno/ interno, al punto che a volte sposto le opere da un luogo all’altro e funzionano integrandosi con l’ambiente. Al MAXXI (lento-violento, 2020) ho esposto ferri vecchi e distrutti perché cercavo il contrasto se non l’innesto tra l’architettura patinata stile archistar e le architetture di oggetti obsoleti. lento-violento (ininterrottamente), part B (2020) è un oggetto unico che include vari elementi necessari all’essere umano per trasportare e velocizzare il suo movimento e i processi produttivi: da una sella dei primi del Novecento applicabile a cavalli e muli solitamente utilizzata per trasportare le fascine, fino a telai di macchine e motocicli o pezzi agricoli di ultima generazione. Insomma si tratta di una geologia del progresso e dello sfruttamento umano, dalla pre-motorizzazione ai giorni nostri. Un’arma gigantesca che punta dritta allo spettatore. Diverso il contesto veneziano, storicamente connotato, con la salsedine che deteriora gli edifici e fa arrugginire il ferro.
RV: Riguardo alla logica del mostruoso presente nella tua opera, mi chiedo se hai un occhio per quelle composizioni macabre che si trovano negli ossari delle chiese o nelle necropoli: una versione barocca della morte in cui le ossa di monaci e fedeli diventano mattoncini di un Lego infernale, di un “Lego post-mortem”.
GC: Ho frequentato molto il Sud Italia, i templi classici, prima d’inseguire il macabro. Ma anche a Cortona abbiamo una santa imbalsamata che non mi stanco di visitare. Mi sorprende osservare come si conserva il nostro corpo e cosa ne resta col passare del tempo, come i capelli o quella struttura ossea che si può allungare grazie alle protesi, come fa l’attrezzatura sportiva o medica. A volte mi chiedo cosa pensano gli animali nel vederci ricoperti di vestiti o con lo sguardo oscurato dagli occhiali da sole. Per noi si tratta di dispositivi culturali, talmente integrati ai nostri corpi da averli naturalizzati.
Tornando al barocco, dal punto di vista formale mi interessa relativamente. Mi sento più vicina a Piero della Francesca, alle battaglie di cavalli nelle Storie della Vera Croce. Hai presente quelle infilate di gambe animali, di pezzi umani, di braccia, di lance brandite in aria? C’è un tale rigore del lavoro strutturale – è una guerra silenziosa, congelata, frazionata al millimetro. Come calcolata al millimetro è l’installazione di Venezia.

Sospensione e attraversamento
RV: Se nessuno degli elementi tocca terra, tale sospensione non implica un’assenza di gravità. In scalata vediamo una composizione piramidale con più animali, quasi una salita agli inferi. La direzionalità è così invertita: si sale, eppure questa salita prende la forma di una discesa nell’abisso.
GC: Per vedere dead dance bisogna alzare lo sguardo come si fa per i grandi affreschi nelle chiese. È sospesa a partire dai 3,30 metri d’altezza, con le proporzioni prospettiche rispettate: alcune teste sono ad esempio più grandi dei corpi in quanto esposte in alto, tanto per ricordare uno dei piccoli aggiustamenti. È un lavoro costruito prospetticamente che evolve da un’opera all’altra, come uno spartito. Un modo per far funzionare il caos, per gestirlo come in bolgia (2022), che richiede uno studio accurato della scena e delle sue specularità, senza rinunciare alle sue eccentricità.
Mancano degli elementi a terra anche per ragioni tecniche e di sicurezza. Ma in genere mi piace lavorare a terra e ci sono persino opere che, anche se poggiate al suolo, sembrano sospese. Poggiarle al suolo è un modo di coinvolgere il corpo, di condizionarlo, di suggerire punti di vista diversi, movimenti ma anche ostacoli. Il corpo dello spettatore è così obbligato a guardare e relazionarsi con qualcosa, che siano sculture o parti del corpo. A Venezia la coreografia dello spettatore cui accennavo prima è suggerita dalla conformazione della calle. È una danza, una camminata o forse una marcia, se non una processione.
Una situazione diversa da quella del MAXXI, dove lo spazio era immenso e mancava l’interazione fisica. Per inciso, installarlo non è stato facile per me che soffro di vertigini… Si tratta di uno spazio con un grande potenziale e una molteplicità di punti di vista che permette una visione in costante mutamento.
RV: Sospendere una scultura in aria vuol dire inevitabilmente azionare un gioco caleidoscopico di ombre che entrano in dialogo con l’opera, conferendole un movimento assente alla scultura poggiata sul piedistallo. Un effetto che vale all’esterno come all’interno.
GC: Premesso che ho un fascino per le mostre buie e che esporrei i miei lavori in ambienti molto più scuri, da bosco di notte, l’esperienza notturna dell’installazione è importante. A Venezia ho fatto diversi sopralluoghi di sera per definire l’illuminazione. E se la guardi di sera somiglia a una centrale elettrica dismessa dove fioriscono forme di vita già morte.
RV: Le tue opere sospese mi fanno pensare anche ai musei di scienze naturali: osservi le vetrine e solo in un secondo momento ti accorgi che sopra la tua testa incombe un immenso uccello estinto o i frammenti dello scheletro di un dinosauro.
GC: Ho sempre visitato i musei di scienze naturali: mi piace vedere le cose estinte, così come combinare assieme specie di animali che non esistono più ad animali viventi o considerati essenziali nelle nostre vite. Non è poi tanto diverso dal realizzare un essere preistorico con pezzi meccanici agricoli come al Museo Novecento. Sovraccaricare ciò che è vivo e ciò che è morto; riflettere sulla permeabilità del DNA e sulla sua eredità, su un mondo in movimento in cui non esiste inerzia. Molte mie installazioni giocano con una confusione del tempo oltre che delle specie; lo stesso accade quando faccio coesistere una macchina nuova e una vecchia, il moderno con il vintage. Senza classificarli, per trattenerli nel presente e di conseguenza, farli convivere in un ipotetico futuro.
RV: Entrambi presenti, appaiono al nostro sguardo in una sorta di attraversamento.
GC: Tengo molto all’attraversamento come elemento proprio alla vita; mi riferisco al modo in cui alcuni elementi ti vengono incontro e ne fai esperienza, ad esempio in macchina o in treno. Li incontri in una prospettiva definita, non diversamente dalle danze macabre: se osservi i dipinti di riti e ballate, i diversi componenti della gerarchia sociale dell’epoca sono riuniti in una danza lineare che li accomuna e li unisce, presi sotto braccio dal ballo della morte. In dead dance questa danza non parla più solo dell’uomo ma viene ampliata ad oggetti, a specie, all’architettura e persino agli scheletri.
Ho vissuto due anni a Sud dell’Olanda, nel paese dove è nato Bosch. Ti assicuro che durante il Carnevale hai difficoltà a riconoscere la civiltà in cui hai vissuto finora, perché i cittadini si trasformano in mostri. Sono giorni di libertà in cui persone generalmente composte diventano folli solo perché la Legge glielo consente – è una libertà condizionata, una sovversione per forza di legge. A dire il vero anche la mia Cortona è un posto strano, con una civiltà contadina e una cultura americana legata al mondo etrusco. Al bar ti puoi imbattere nel contadino sceso dal trattore così come nel miliardario americano, fianco a fianco, il cappello di paglia e quello da baseball.
RV: L’attraversamento di cui parli diventa, in progresso scorsoio, ripetizione.
GC: Sì, a Venezia c’è un tratto lungo ventisei metri di ripetizione pura. Qui, come in una stalla con le sbarre, intravedi un’infilata di culi animali che ho aggiunto man mano che progettavo dead dance. Ma puoi pensare anche ai lunghi corridoi di un supermercato o di un aeroporto dove il paesaggio resta identico per metri. Mi interessa esporre il mio lavoro alla pseudo-ripetizione, sforzarmi di comprendere l’atto creativo confrontandolo alla ripetizione, un’idea che minaccia l’istintività. A volte tento di riprodurre le stesse sculture, anche dieci volte di seguito. In che modo evolve il fare manuale? In che modo la moltiplicazione incide sulla soggettività in un’epoca come la nostra segnata da quell’esubero del soggetto tipico dei social media?
Vita animale
RV: Il tuo lavoro mi sembra agli antipodi della tassidermia, presente in molta arte contemporanea, italiana inclusa. Non una mimesi della vita rappresa in un gesto raggelato, non un trofeo ma un rapporto col vivente che va al di là della divisione tra natura e cultura.
GC: Non amo la distinzione naturale/artificiale: ai miei occhi non c’è differenza tra un nido e un palazzo. Non esiste un punto di vista singolo ma solo interdipendenza. Come dice un mio amico giardiniere, “più piante metto nel mio giardino meglio stanno”. C’è un’interconnessione profonda nel mondo del vivente, un humus, una mescolanza dove il termine artificiale perde di senso.
Il fare scultura è ancora troppo legato a un linguaggio specifico e a forme prestabilite, mentre io tendo ad appropriarmi di una tecnica, come il calco o la modellazione, e stravolgerne le regole che la costituiscono, introdurmi nel prototipo e restituirlo attraverso la mescolanza. Siamo in effetti lontani dalla tassidermia.
RV: Mi viene in mente still life the oldest (2022).
GC: In still life the oldest mi piace anzitutto il doppio senso del termine inglese per “natura morta”: ancora vita, ancora in vita. È composta, oltre che dalla testa di alce, da lupi; le loro zampe si uniscono ai tronchi-bastoni, si trasformano in quei tronchi-bastoni utilizzati dagli anziani che, curvandosi, non stanno più in piedi. L’animale non è immediatamente riconoscibile o sembra provenire da un’altra era. In genere lavoro con i cugini più selvatici degli animali sfruttati dall’uomo: non il cane ma il lupo, non il cavallo ma l’alce.
RV: bolgia evoca il mondo del mattatoio come già, in modo più esplicito, macello (2021). In entrambe tuttavia non c’è traccia di sangue. La violenza è più sottile, trasmessa dal materiale – metallo e alluminio – e dalle forme acuminate. Le carcasse animali appese sono, al limite, nell’immaginazione dello spettatore.
GC: Sono cresciuta in mezzo al macello, tra agnelli e maiali scuoiati che a volte mi ritrovavo appesi nella doccia! Mangiavo gli animali anche se gli facevo il funerale. E mi piacciono molto libri di poesie come Macello di Ivano Ferrari, che ha lavorato nel mattatoio di Mantova, o Dimora naturale di Andrea Bajani sugli animali in città. Ed è proprio vivendo in città che ho perso il contatto con gli animali, dove assumono le fattezze di una confezione di carne plastificata o di esseri umanizzati poiché appartenenti a specie privilegiate, come i nostri animali da compagnia. Qui c’è non-vita o speculazione sulla vita. Se nel mio Mattatoio non c’è sangue è perché a scandalizzarmi è meno il macello che la commercializzazione del pezzo di carne animale pronto all’uso, il pezzo di vita morta in frigo, sempre identico a se stesso.
Mi sono sensibilizzata alla questione animale mangiando selvaggina e percependo l’odore di selvatico, di vita. Sono diventata consapevole di introdurre vita dentro di me e consapevole, di riflesso, del commercio sfrenato e dello spreco legato alla produzione, che si tratti di mammiferi o dei prodotti della terra.
RV: Vuoi dire che, per te, quanto vale per la questione animale vale anche per l’agricoltura?
GC: Sì, perlomeno per l’agricoltura industriale improntata allo sfruttamento della terra rispetto a forme più sostenibili, come quella bio-dinamica per esempio: per produrre cibo usiamo macchine che distruggono la terra, la rendono improduttiva e infertile. Qui intorno a me, per esempio, la monocultura della vigna impoverisce la terra, uccide la biodiversità. Non ci sono neanche più gli operai ma solo cavi di acciaio e infrastrutture – la natura è ormai una fabbrica!
Quando sono andata via da casa pensavo al posto da cui venivo come a un idillio – tornarci mi ha sconvolta. Anche da qui deriva la presenza, nel mio lavoro, di componenti di macchine agricole legate alla produzione intensiva. Alcune opere derivano dal mio sguardo sui paesaggi agricoli sempre più industrializzati. Se osservi un vigneto, ti accorgi che la vita è organizzata e pianificata; sullo sfondo si stagliano antenne e centrali elettriche. Finché sui suoi fili si posa un uccello selvatico, o passa l’ultimo operaio guardiano, che spezza l’uniformità della struttura tecnologica…
Un’inquietudine organizzata
RV: Solo ora che siamo alle battute finali mi accorgo che non abbiamo evocato la presenza umana (non deve essere un caso), non centrale ma non assente. In bolgia – guardiano, bolgia – mangiatoia e lungo il percorso di dead dance appaiono volti dall’espressione tribolata. Sono volti gonfi, simili ai corpi annegati e ripescati.
GC: L’uomo costituisce una componente del mio lavoro, ma non più importante dell’animale. Come ci siamo resi conto durante la pandemia, l’uomo è piccolo e le vecchie gerarchie imposte dall’antropocentrismo non tengono più. Quei volti umani vengono dai manichini medici utilizzati per la rianimazione e l’espressione è data dalla loro bocca socchiusa attraverso cui gli aspiranti
dottori possono esercitarsi.
RV: Una curiosità prima di chiudere: in diverse occasioni usi il termine scorsoio. Consultando il dizionario, mi sono accorto che è legato, oltre che al nodo, al capestro, cioè alla fune con cui si legano per la testa animali come buoi, vacche e cavalli ma anche alla forca dell’impiccagione (“mandare al capestro”).
GC: L’idea dello scorsoio e del suo scorrimento lento viene dai versi di Andrea Zanzotto: “in questo progresso scorsoio / non so se vengo ingoiato / o se ingoio”. Ma non mancano riferimenti a KO de mondo dei CSI. Mi appassionano le figure che mangiano e divorano se stesse fino a diventare ossee. Dei viventi che si mangiano reciprocamente sono un’immagine della nutrizione e, al proposito, mi ha colpito la scena di Salò e le 120 giornate di Sodoma di Pasolini dove gli umani mangiano al guinzaglio. C’è geometria ma anche inquietudine, perché la geometria non può assorbire la distruzione. Prendi cosmogonia e cosmoagonia, che aprono e chiudono dead dance. Entrambe partono da due figure quasi identiche, per tentare un inizio e una fine speculari. Nella prima, una teoria immaginaria di ipotetiche genesi, le due figure formate da varie specie si uniscono in un unico corpo. È un’immagine sulle possibilità di creazione e riproduzione. Ci mostra un atto amoroso composto apparentemente da due volti, ma contiene un corpo costituito da tante specie contemporaneamente, al punto che è difficile dire se l’unità è prodotta da un essere unico o dalla coppia. Ovviamente si ispira anche a tutti quei viventi capaci di riprodursi senza bisogno dell’accoppiamento. Nell’ultima, cosmoagonia, gli esseri non sono più uniti. Uno dei due – l’essere-antenna con la testa di alce – è superiore all’altro e guarda il palmo della propria mano, ignorando un suo simile che urla agonizzante poco sotto.
Organizzare l’inquietudine: non è in fondo una tendenza naturale nella storia dell’umanità?