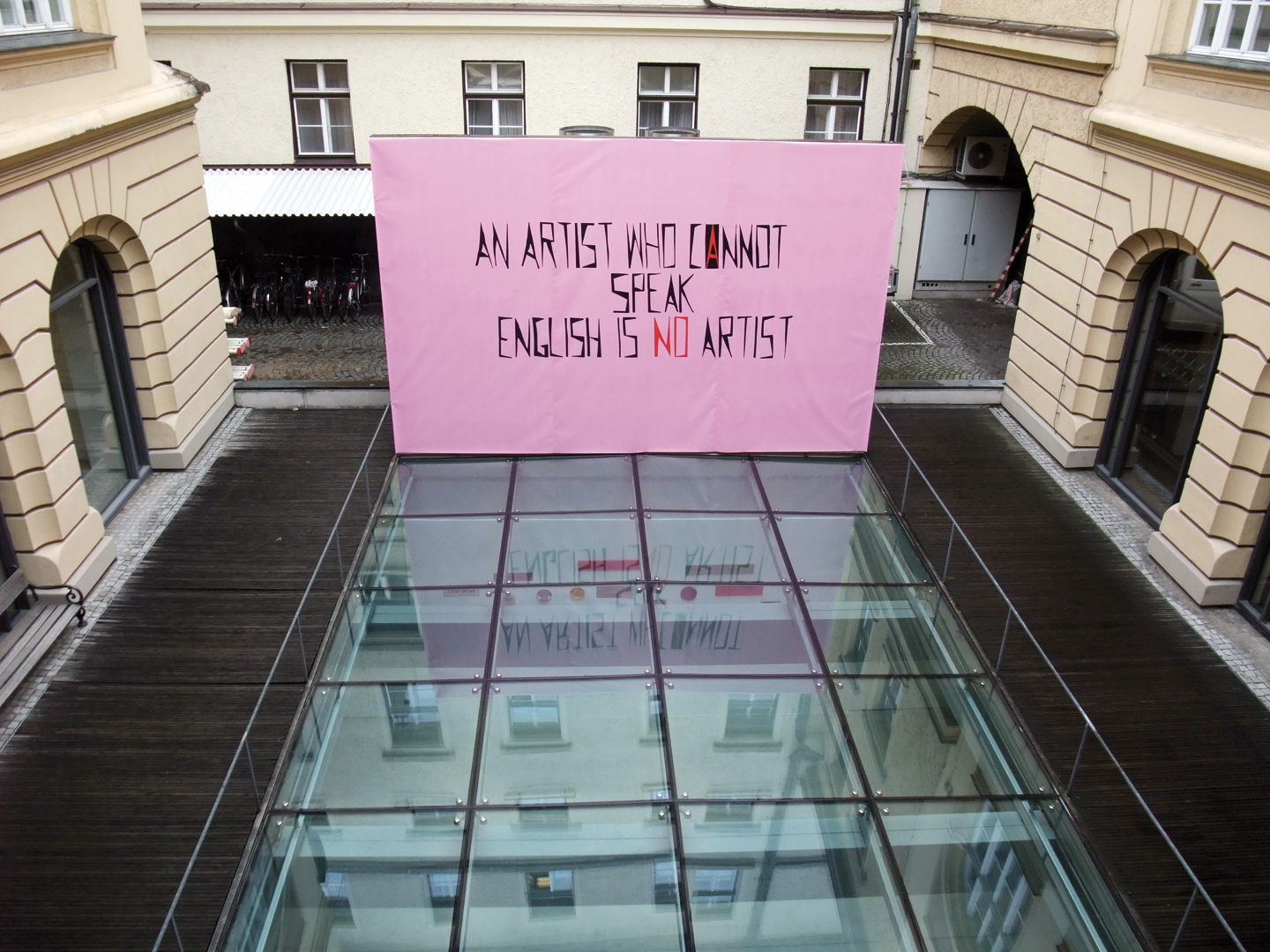La Collezione Maramotti ha aperto negli spazi dell’ex stabilimento Max Mara — una collezione che da qualche anno funziona a tutti gli effetti come una Kunsthalle — “La pittura come forma radicale”, una collettiva sulla pittura degli ultimi quindici anni da parte di artisti statunitensi o che lavorano negli Stati Uniti che, più che fare il punto sulla situazione, diventa un’occasione per mostrare gli acquisti degli ultimi anni e celebrare l’uscita del libro di Mario Diacono Archetypes and Historicity / Painting and Other Radical Forms 1995-2007.
Non si tratta, dunque, di una mostra di circostanza per ricordarci che esiste “anche” la pittura: questo infatti è un argomento che in arte raccoglie più pettegolezzi dei flirt di Belen e la simpatica conversazione tra i co-curatori Mario Diacono e Bob Nickas che ha accompagnato il vernissage non ha potuto fare a meno di sfiorarne alcuni (la pittura non è amata dai curatori, è assente dalle grandi mostre, pittura e fotografia, etc…). Nickas ricorda una tavola rotonda organizzata da Flash Art negli anni Ottanta nella quale Philip Taaffe tagliò ogni spiegazione teorica affermando “You can’t kill painting”. Esiste, non puoi farne a meno… e non esiste solo sul mercato come dimostra anche la ricerca di Mario Diacono. Esiste dunque una pittura “radicale”? Per evitare equivoci bisogna dire che le opere degli artisti in mostra non hanno nulla a che fare con quell’auto-referenzialità della Radical Painting anni Ottanta e dei suoi monocromi. Le opere dimostrano quell’eterogenità tipica dell’arte, da quando i movimenti non dettano più regole e i linguaggi si sposano per divorziare un istante dopo. Troviamo dunque l’astrazione “seria” di John Tremblay, Dan Walsh, Matthew Antezzo e Jacqueline Humphries; quella giocosa di Pedro Barbeito e Steve Di Benedetto oppure quell’astrazione-figurazione molto en vogue negli ultimi anni dove l’una e l’altra vengono utilizzate indifferentemente (a volte nella stessa opera) come è tipico nel lavoro di Jules de Balincourt, Benjamin Degen, Kelley Walker, Scott Grodesky, David Dupuis, Jutta Koether e Wayne Gonzales; quelli che dipingono perché hanno perso la macchina fotografica… Damian Loeb; quelli che combinano pittura e scultura come Matthew Day Jackson; quelli che dipingono perché solo così il simbolismo viene “come dico io” come Andy Cross o Dana Schutz; e quelli che gli “anni Ottanta” non sono mai finiti come David Bowes e Ann Craven. La collettiva conferma qualunque analisi sulla pittura come “tecnologia lenta” (Nickas) attraverso la quale si protrae una continuità tra vecchio e nuovo immaginario, tra un passato che “rimane visibile nonostante la reinvenzione” (Diacono) e un presente nel quale l’inventiva non sembra mancare mai, motivo per cui si dipinge ancora oggi.