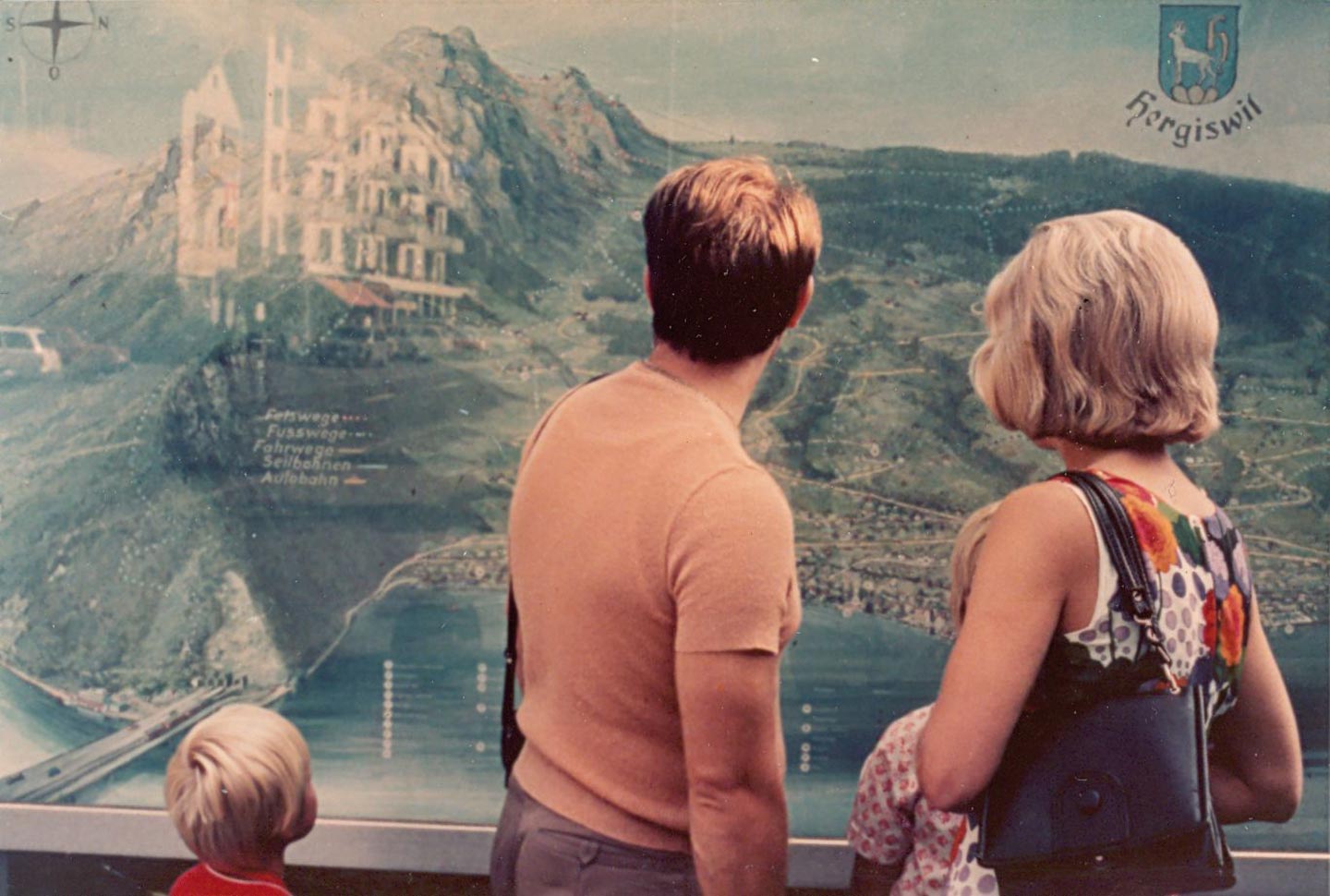C’è un filo d’Arianna che orienta, sviluppa e collega l’opera singolare di tre artisti non a caso italiani, riconducibili a tre generazioni diverse che hanno rinvenuto nella figura del Labirinto — rara nelle arti visive quanto di casa in letteratura — il loro passaggio del testimone.
Giorgio De Chirico, Giulio Paolini e Pietro Roccasalva, a turno novelli Dante, si sono inoltrati nella selva oscura senza più uscirne, anzi eleggendola a propria dimora d’elezione.
Il novecentesco labirinto della “crisi” di Giorgio De Chirico è desumibile, per induzione, da quella teoria di “scorci” che sono le sue celeberrime tele, finestre su piazze d’Italia, vicoli ciechi e gomiti che, ignorando il disegno planimetrico, ce ne consegnano molte vedute prospettiche, accomunate dal modus teatrale dell’“affaccio”. A differenza di Dante, che fece della Commedia un trampolino di lancio per le sue ambizioni di architetto, egli sa che la pars pro toto, rinunciando alla grandezza della visione d’insieme, guadagna in ambiguità e mistero, come quando inseguiamo la fuga irregolare di un viottolo per nulla impensieriti dalla topografia del luogo.
Per Giulio Paolini, al contrario, più importante delle singole perle è il filo che le tiene. Siamo nell’epoca della piena strutturalista che inonda ogni campo e disciplina, nella vertigine di una procedura razionale che sfida gli abissi della semiosi illimitata. E il modello operativo è dichiaratamente quello labirintico, rispetto al quale il singolo momento è per lo più il riflesso di una visione d’insieme originaria, come il frattale che si auto-replica all’infinito. Non che i vari episodi non abbiano la loro pregnanza, solo che sono tappe di un percorso complessivo più rilevante e decisivo.
Pietro Roccasalva in un certo senso costituisce una sintesi dialettica dei suoi illustri predecessori: dovendo rinnegare il padre almeno in parte, recupera qualcosa del nonno.
La struttura del suo labirinto riveste pari importanza rispetto agli snodi che lo compongono. Non più la discreta melanconia di De Chirico, né il continuum maniacale di Paolini, ma un gioco delle scatole cinesi in perfetto equilibrio tra sensualità e intellettualismo che rende meglio conto del suo labirintico “cantiere”.

Fin qui, per sommi capi, le differenze strutturali che caratterizzano i dedali edificati dai tre artisti. Ma c’è, invece, un possibile nesso che li accomuna e che ci dica qualcosa d’altro? A differenza dei labirinti iniziatici e letterari di Teseo, Odisseo, Enea, Dante, Faust, Alice, Bloom, Zeno, K., quelli “a tempo indeterminato” dei tre paladini dell’arte visiva non solo non contemplano l’uscita (prerogativa anche della letteratura d’avanguardia), ma nemmeno un candidato allo smarrimento. Qualcosa di affatto diverso, dunque, rispetto a quanto accade nei grandi componimenti dell’antichità, passando per le favole e il romanzo moderno fino a giungere al cinema e a un film come Inland Empire di David Lynch. Qui la giovane protagonista, novella Psiche, guadagna la salvezza solo dopo aver patito interminabili scissioni, deliri e allucinazioni, peregrinando da un set a quello successivo in un labirinto di specchi memore della più spinta follia godardiana, quando finalmente riesce a vedersi nello schermo “standone fuori”. Bella metafora di una mente che si trae in salvo perché capace di riflettere se stessa e il mondo senza più coincidere con esso, come invece accade nella schizofrenia e, per molti versi, nell’arte visiva. Ma perché quest’ultima non necessita di un telos ora salvifico, ora tragico, comunque di una “fuoriuscita”? Per il semplice fatto che essendo iscritta nel registro simbolico dell’immagine e non in quello narrativo del racconto, difficilmente contempla una storia con una fine.
Non a caso, i mondi creati dai tre artisti appaiono potenzialmente infiniti, ma anche disabitati e inanimati, “ultraterreni”. Ogni pathos è convogliato nell’edificazione di un claustrum a opera di un demiurgo (l’artista) onnipotente quanto schivo, capace di rovesciare in habitat l’inospitale. Identificato nella figura mitologica di Dedalo, non ama convocare esseri umani e umane vicende al suo capezzale, ma al limite altri semidei quali Teseo e il Minotauro, oppure Le Muse Inquietanti, Mimesi, L’Ascensorista e via dicendo. Tutte effigi di padroni di casa sotto mentite spoglie, chiamate a decorare le loro labirintiche fortezze.
E allora, non la narrazione di un Io posto di fronte a un mondo pieno di contraddizioni e che è “altro-da-sé”, bensì la rappresentazione di un Io narcisistico che è tutt’uno con un sincronico mondo degli opposti; non un lungo viaggio catartico, ma risoluzione del conflitto con una serie ininterrotta di colpi di magia, attraverso quelle epifanie che sono le opere d’arte; non è un percorso da affrontare nel tempo, ma uno spazio-tempo da dispiegare a caratterizzare l’approccio al labirinto da parte dei tre artisti.

L’Io narrante (ed errante), al contrario, per quanto spersonalizzato e disintegrato nel tessuto del racconto, è umano e non divino, anela a conservare l’integrità non conoscendo l’onnipotenza che soggiace allo sguardo atemporale e distaccato dell’artista visivo. Temendo più di ogni altra cosa proprio quell’“Al-di-là” dove le ombre imperversano e gli opposti si confondono generando caos, necessita continuamente di tornare “in sé”, come nell’incubo che svanisce al risveglio. Come Ulisse che “deve” tornare dagli Inferi o il torero trionfante dopo aver neutralizzato il toro in quella coreografia labirintica che è la sua azione di contenimento.
L’alternativa, naturalmente, è quella di impazzire, perire o arrendersi a un fato avverso, cosa che accade sovente sia allo schizofrenico che al toreador, oltre che nel teatro, nella letteratura e nel cinema.