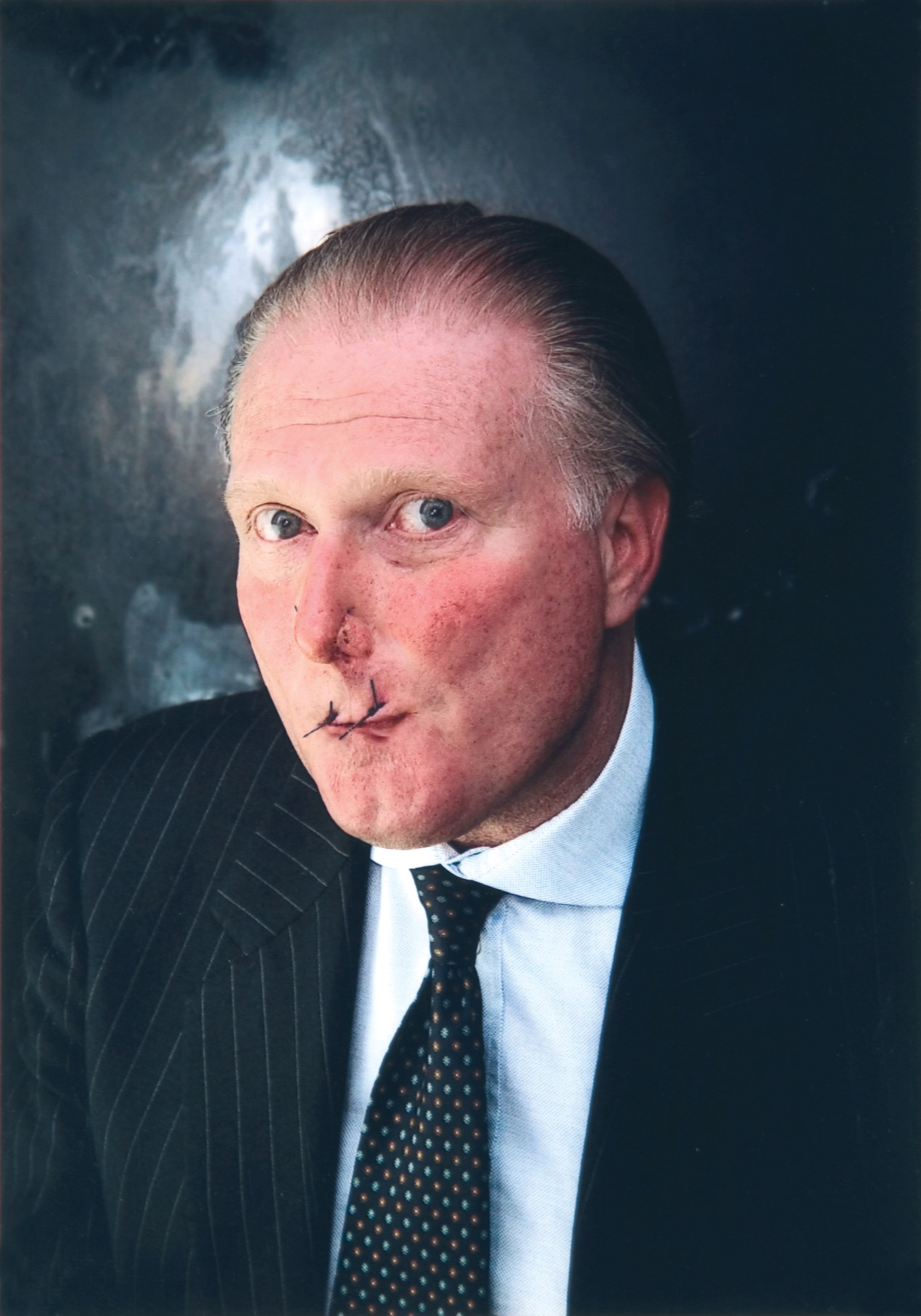Ilaria Bombelli: In questo momento la performance è oggetto di una duplice rilettura da parte vostra: da un lato il relazionarsi ad essa come a una scultura — attraverso l’espressione di movimenti essenziali e dalla durata dilatata — dall’altro state maturando un’idea interessante, che chiameremo oggetto performativo.
Lovett/Codagnone: Sulla valenza oggettuale della performance sono state scritte molte cose, quello che a noi interessa è invece parlare della valenza performativa degli oggetti. È stato importante capire a un certo punto che la nostra presenza in una performance poteva, in alcuni casi, diventare un’assenza, dove l’azione era comunque espressa ma non aveva più bisogno di essere “illustrata”. Il concetto di oggetto performativo non descrive ciò che rimane come residuo o ciò che fa parte di una performance, ma definisce lavori che contengono un atto, il concetto di azione o presenza che non necessita più di essere “performata” perché implicita. Un esempio è A love extending far beyond (2004) — una frusta in pelle con due manici — in cui l’azione è così ben descritta dall’oggetto che una nostra interpretazione sarebbe solo ridondante. Lo stesso vale per Stripped (2006) — una bandiera americana nera allungata come fosse un drappo. Diverso è per To breathe in always even though it kills (2006) — due megafoni uniti nella parte in cui viene emesso il suono — che era stato concepito come oggetto performativo che incarna precisamente l’impossibilità di un’azione. La decisione successiva di usarlo nella performance Party with Us (2006) non è nata per descrivere un atto che l’oggetto già contiene, ma per ricontestualizzarlo e trasformarlo in metafora. Questa chiave di lettura diventa per noi interessante se la si usa per leggere il lavoro di altri artisti che non fanno performance ma ne hanno assorbito la metodologia come strategia o scelta, non necessariamente conscia.
IB: Il doppio megafono, la frusta a due manici, ma anche il coltello a doppia lama della performance For You (2003), le camicie di forza di Obliquities (2004), i due cappi intrecciati di Each man kills the thing he loves (2005). Oggetti performativi che sembrano essere concepiti per un “gioco a due”.
L/C: “Non invochiamo un dualismo se non per rifiutarne un altro. Ci serviamo di un dualismo di modelli solo per pervenire a un processo che rifiuti ogni modello. Arrivare alla formula magica che cerchiamo tutti: Pluralismo = Monismo, passando per tutti i dualismi che sono il nemico, ma il nemico assolutamente necessario, il mobile che non cessiamo di spostare1”. È una citazione da Deleuze e Guattari di assoluta rilevanza. Se l’oggetto performativo descrive una performance sancendone l’assenza, nel nostro caso le tracce lasciate sono inevitabilmente due. Non facciamo un discorso di opposizione binaria tipica del pensiero metafisico. I due soggetti sono in opposizione, ma in uno scambio continuo di ruoli. Questa citazione riassume uno dei concetti base del pensiero Post-Strutturalista, ed è di estrema importanza per capire le teorie che dagli anni Settanta si sono dedicate alla rielaborazione e ridefinizione dei concetti di gender e identità.
IB: Nel vostro lavoro il riferimento al tema dell’identità è sempre molto preciso.
L/C: Se però prima era più focalizzato sull’analisi di nuclei sociali ristretti come la coppia, la famiglia o il gruppo di appartenenza, oggi ci interessa allargarlo a un’identità collettiva. Secondo Dominique Laporte, l’identità moderna nasce nel momento in cui, storicamente nel 1600, viene isolato architettonicamente il luogo dove defechiamo e organizzata l’idea del waste in generale. Questa rimozione è l’atto che, secondo Laporte, sancisce la nascita della soggettività moderna. Proprio Histoire de la merde di Laporte è uno dei testi che ci ha ispirato il lavoro ASK* (2003): una stanza immersa in una luce rossa e in una miscela di aromi associati a effetti afrodisiaci, con panchine lungo le pareti simili a quelle delle saune. In questo spazio si sono tenute letture dal vivo di brani di natura scatologica tratti da Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini, registrate e trasmesse il giorno seguente contemporaneamente alle nuove letture; si creava così una cacofonia. ASK* è un’installazione/performance dove il dialogo tra spazio architettonico e identità è predominante. L’intento era di creare uno spazio sociale, personale e pubblico, un anti-luogo, eterotopico, secondo la definizione di Michel Foucault.
IB: Spesso lo specchio si fa metafora di un discorso identitario. Ad esempio in The internal nothingness of myself (2006), uno specchio coperto di vernice nera eccetto in corrispondenza della scritta “So this is me. Me. Me? What is that? What is that? Me?”.
L/C: È una frase tratta da una scena del film Angst vor der Angst di Fassbinder. Margot, la protagonista, madre e casalinga perfetta, un giorno guardandosi allo specchio inizia a non riconoscersi e a domandarsi appunto: “Io. Io? Cos’è quello? Io?”. Questo stato di confusione rispetto all’identità e perdita di sé avviene nel momento in cui Margot inizia ad abbandonare i ruoli sociali a cui era stata costretta fino a quel momento. È un passaggio molto indicativo del processo di costruzione dell’identità e di quanto siamo costretti ad aderire a dei ruoli che ci vengono imposti e che ci condizionano.

IB: Nella performance Obliquities lo specchio è sempre strumento di un’affermazione di identità ma attraverso l’esclusione — visiva ma anche metaforica — dell’alterità.
L/C: Il sonoro di Obliquities è un estratto dal testo Self-Accusation di Peter Handke: “I recognized that I am not you. I made myself. I made myself what I am. I changed myself. I became someone else”. Sono frasi che abbiamo ripetuto e registrato a casa nostra per dieci giorni consecutivi, dovevano essere le prime parole pronunciate al mattino, uno di fronte all’altro, e le ultime prima di coricarci. La performance è durata due ore: eravamo in piedi, questa volta di spalle, ai due lati opposti della stanza, di fronte a uno specchio e legati dalle maniche di due camicie di forza in pelle bianca che drappeggiavano sul pavimento dividendolo a metà. Entrambi vedevamo riflessi nello specchio noi stessi e la stanza ma non potevamo vederci tra di noi perché col corpo ci escludevamo a vicenda la vista dell’altro. L’atto di annullare visivamente la presenza dell’altro, pur mantenendone precisa la cognizione attraverso il suono e i lacci che ci univano, è la rappresentazione di un rapporto di potere dove per affermare la propria identità necessitiamo di cancellare l’identità dell’altro.
IB: Siamo costantemente sottoposti ai rapporti di potere?
L/C: Questa idea soprattutto è sempre stata al centro del nostro lavoro. Forse ciò che più ci ha influenzato è stato il pensiero di Foucault, secondo cui il potere è ovunque e non monolitico. Il nostro obiettivo è la messa in discussione del fatto che ci sia un soggetto dominante e uno subordinato, e che la demarcazione dei ruoli sia precisa e irreversibile, proponendo invece un dialogo all’interno dei rapporti di potere. In un passo della Fenomenologia dello Spirito, Hegel parla proprio del rapporto dominazione-sottomissione: secondo Hegel c’è sempre una sconfitta da parte del “padrone” perché, per definizione — e questo è molto importante per definire l’identità — non potrebbe esistere senza lo “schiavo”. Per essere definiti abbiamo bisogno del riconoscimento dell’altro, ed è questa dipendenza a creare il dialogo. Il film The Servant di Joseph Losey, di cui abbiamo usato un dialogo per il sonoro del video Wenn ich mir was wünschen dürfte… (If I could wish something) del 2001, si basa proprio su questo, esplicitato nel film dall’inversione dei ruoli tra il padrone della casa e il maggiordomo. Ma essendo definiti dal linguaggio, che è strutturato per opposti, dobbiamo sempre definirci “rispetto” all’altro, non esiste uno spazio di mezzo perché non c’è un linguaggio per descriverlo. E allora, dire che il carnefice ha bisogno della vittima per definirsi tale crea un po’ questo spazio di mezzo.
IB: Perfect Day (1998) è un video che mostra, sulle note dell’omonima canzone d’amore di Lou Reed, il lento divoramento di un ratto ad opera di un serpente. Un’immagine che sembrerebbe al contrario esemplificare perfettamente il rapporto dominazione-sottomissione.
L/C: A Perfect Day ci ha condotto una ricerca che avevamo fatto sui ratti: nella relazione con un serpente, se il ratto (la preda) per qualche motivo non viene mangiato dal serpente, diventa lui il predatore. Un ratto femmina e incinta può uccidere un boa di sei metri. Finito di girare il video, abbiamo dato un secondo ratto al serpente, ormai sazio, e il ratto ha iniziato ad aggredirlo. Un modello visivo della reversibilità del ruolo di chi detiene il potere. Questa idea nei nostri primi lavori attingeva all’immaginario Sado/Maso, ma sempre in chiave psicologica: nel film Il portiere di notte, da cui abbiamo distillato una fotografia nella performance Wenn ich mir was wünschen dürfte… (If I could wish something), la relazione tra il portiere ex ufficiale SS e la ex deportata ha un chiaro aspetto S&M rispetto ai rapporti di potere, non solo in chiave sessuale.
IB: Spesso per parlare di rapporti di potere all’interno di una coppia usate la danza, come in For You — anche se il movimento è delegato alla sola pedana — dove indossate i costumi tipici dei ballerini di Tango, avete braccia e gambe legate per mantenere la posa e stringete tra i denti un coltello con incisa la scritta “For You”.
L/C: Il Tango in origine veniva ballato da due uomini e il coltello faceva parte di un rituale che è stato sempre presente nel Tango, fin dalla sua nascita. Secondo Jorge Luis Borges, che scrisse sulla tradizione del Tango in Evaristo Carriego, la vera natura del Tango è “litigiosa” perché nasce appunto da un confronto. Da questa rilettura del Tango secondo la sua tradizione più antica abbiamo estrapolato una posa portandola all’estremo. L’altro aspetto che ci interessava era la natura clandestina del Tango e il fatto che qualcosa che è pubblico come la danza venisse forzato in spazi privati e nascosti.

IB: Quando vi rapportate proprio a ciò che è pubblico e ciò che è privato rispetto ai rapporti di potere lo fate riferendovi all’ambiente domestico o familiare. Octavio Zaya, già nel ’98, conferiva ai vostri lavori l’effetto di “pervertire il domestico mentre addomesticano il perverso”.
L/C: Nel relazionarsi e nel rappresentare una situazione domestica, la prima cosa che viene demarcata è la dimensione privata e quella pubblica, due sfere che sembrano inconciliabili: da una parte la percezione, dall’altra la verità.
<< Play >> (2000) è una videoinstallazione in cui, con i genitori di John, abbiamo rifatto gli ultimi tre minuti del film Who’s afraid of Virginia Woolf? Una notte i due protagonisti, Martha e suo marito George, si ritrovano ubriachi in un “gioco della verità”, un vero e proprio esercizio di S&M psicologico in cui parlano sempre del figlio, e chi vede il film dà per scontato che questo figlio esiste. Fino a quando George dice alla moglie che il figlio è morto. Si scopre allora che, non potendo avere figli, i due avevano creato il mito di un figlio che non era mai esistito. Negli ultimi tre minuti del film Martha e George cercano di capire dove andare da quel momento in avanti, è come se venisse messa in discussione l’esistenza di una coppia senza figli al di là della sua realtà privata, in funzione dell’immagine pubblica.
IB: Si può dire che siete molto “legati”: nella vita da un rapporto che dura da 13 anni, nel lavoro, in senso letterale, da guinzagli, gomitoli, lacci, cappi, camicie di forza…
L/C: Perché c’è anche l’idea che essere uniti sia comunque una forzatura. Nella performance Each man kills the thing he loves siamo rimasti seduti per due ore, schiena contro schiena, vincolati dall’indossare un unico cappuccio, sotto due neon a forma di cappi intrecciati. Dopo un po’ ci tiravamo l’uno con l’altro e vedevi proprio questo nostro continuo negoziare. Era di nuovo un modo di rapportarsi al potere: se io sto comodo lui sta scomodo e viceversa, e più il tempo passava più questa dinamica era evidente.
IB: Quanta fiducia ci vuole… e quanto amore?
L/C: Tutte le nostre performance sono basate sulla fiducia. Soprattutto Suited (2001), dove siamo bendati e sigillati in un unico vestito che ci unisce schiena contro schiena. Il contatto è forzato, il movimento circoscritto inframmezzato da pause in cui recitiamo un testo in forma di domanda e risposta: “A: Do you love me? B: you love me. A: Do you love me like I love you?”, per poi invertire il senso di marcia e chi lo conduce. Questa performance si basa proprio sull’affidamento reciproco: se uno cede, cede anche l’altro, devi liberarti da qualsiasi resistenza e darti all’altro completamente, che è una cosa difficilissima. L’amore è una componente fondamentale nel nostro lavoro, ma è difficile parlare di sentimenti senza diventare cheap. Chi è riuscito più di tutti a farlo in modo concettuale è stato Bas Jan Ader. Nel 1996, per la nostra prima mostra a New York da White Columns, ci siamo filmati mentre ci facevamo tatuare come simbolo della nostra unione un disegno formato da tanti cuori ricavato da una stoffa samurai giapponese. Nel video, Samurai Love (1996), le immagini e il suono irritante della macchinetta del tatuatore creano una tensione continua tra l’idea romantica che una scelta del genere ritualizza e la sua realtà più cruda.