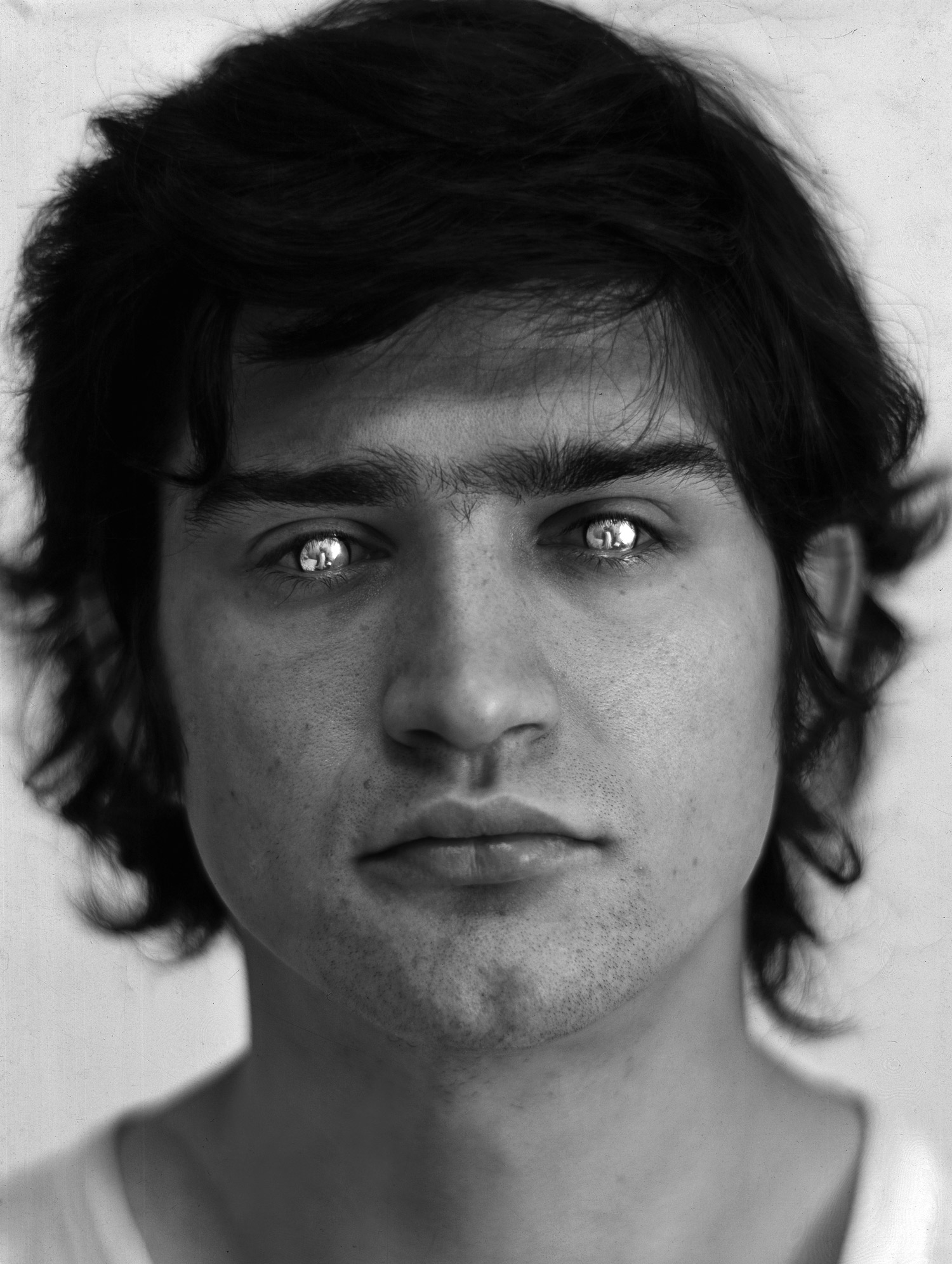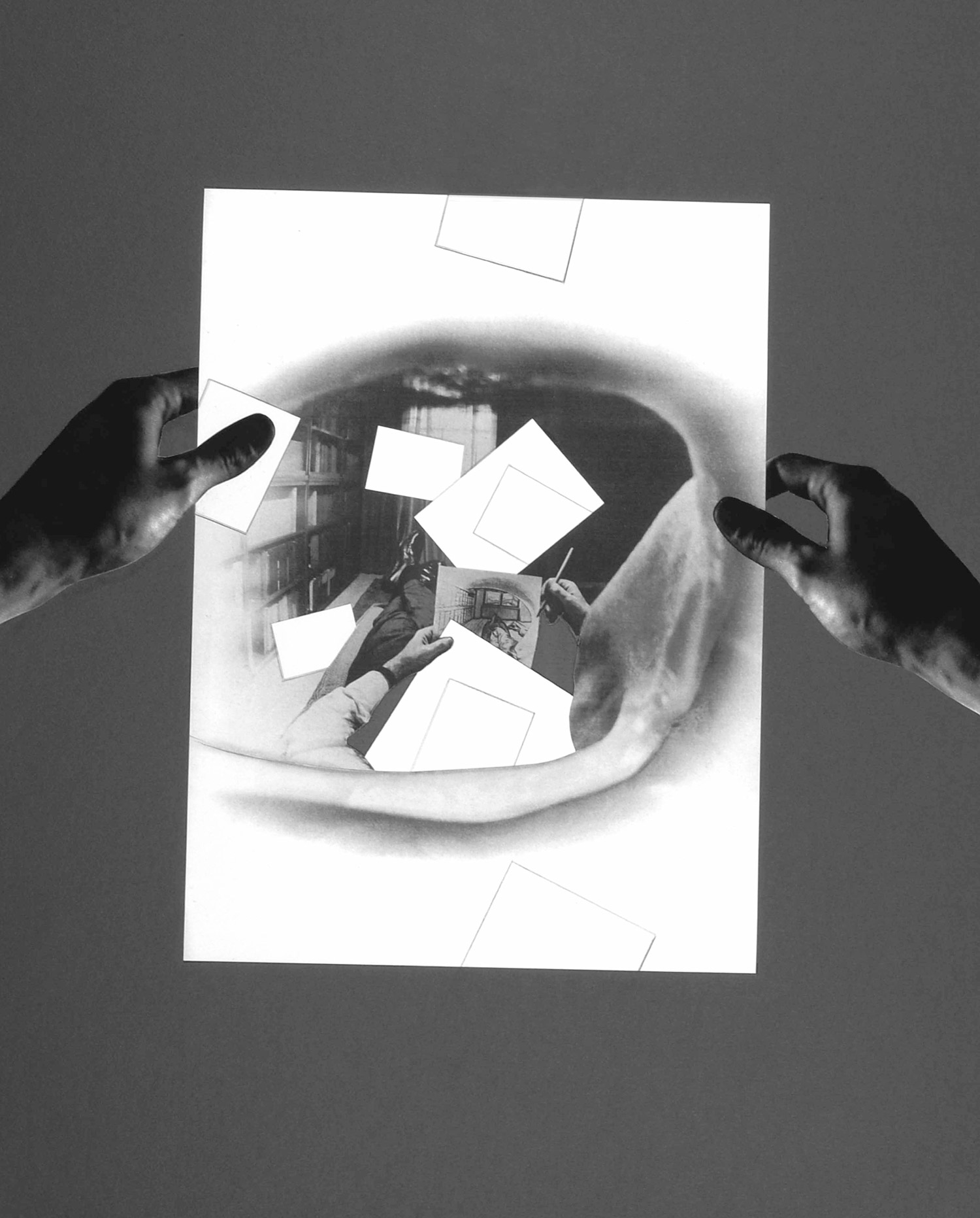Nemmeno lui, Lucio Fontana, avrebbe allestito, all’epoca, una mostra così. Probabilmente oggi sì, sensibile, come era, alla contemporaneità. E, infatti, Elena Geuna e Sergio Casoli l’hanno allestita in modo esemplare a Genova a Palazzo Ducale. Dall’ambiente tutto nero iniziale al cubo di neon verticali si apre lo spazio dedicato alle opere di colore nero, dalla “ceramica riflessata” del 1948 alla scultura spaziale in ferro dipinto del 1951-52, ai vetri neri del 1953 e 1956, ai teatrini del 1965-66 fino all’ellisse del 1967 e al taglio del 1968, una delle sue ultime opere. Poi, dalla sala tutta rosa dagli squarci sensuali del 1962 alla grande Fine di Dio del 1963, alla sala d’oro delle Venezie del 1961. Segue la sala dei rossi, affollatissima, con i “quanta” del 1960 e tanti tagli, buchi e teatrini.
Ed ancora quella dei bianchi con i buchi del 1950, le Attese sagomate e tutto il repertorio classico di Fontana. La sala dei gialli precede quella delle nature, originariamente in creta, del 1959-60, anche se qui sono in bronzo.
Quando mi affacciai alla scena dell’arte, nella Milano fine anni Cinquanta-inizi Sessanta, l’avanguardia astratta era divisa tra Mario Balocco, solitario ricercatore di fenomeni percettivi, Bruno Munari, designer che aveva proseguito la lezione futurista, freddo, calcolatore, puntiglioso, sempre sopra le righe, abile nell’attingere e nell’appropriarsi delle cose più curiose, soprattutto se di spirito esotico o lontano, e Lucio Fontana, suo opposto, talento naturale del fare, gran signore, generosissimo, con storie inverosimili alle spalle per un suo passato sudamericano. Il suo senso fondamentale era superare i confini dello spazio per dare concretezza con un minimo segno, un punto o un taglio all’utopia. I giovani trovavano nel suo bellissimo studio in corso Monforte 23, affacciato su un parco verde, non un padre, ma un amico, un compagno di viaggio con cui condividere idee e progetti, in una interrelazione perfetta fra dare e avere, sentimenti e quotidianità. Fontana lavorava in modo metodico, dopo aver preparato le tele aspettava qualche ora affinché il colore raggiungesse un grado preciso di umidità, prima che si asciugasse, poi le bucava o tagliava in solitudine nel momento esatto. Il resto del tempo lo trascorreva a conoscere o ad ascoltare o a raccontare le cose più disparate, più sorprendenti e meno scontate per il piacere di farlo. I suoi interessi andavano dallo studio di materiali particolari da utilizzare — in quegli anni le industrie chimiche ne producevano di nuovissimi — all’andare al teatro, dove le bellissime Rita Renoir e Rita Cadillac improvvisavano solo per lui degli azzardatissimi striptease, a cercare di capire cosa si potesse fare durante un viaggio aereo intercontinentale, al progetto di una mostra in un luogo imprevedibile. Fu il primo artista a volere una mia superficie, e iniziò così la mia passione di scambiare opere con i colleghi; ricordo che mi offrì una sua opera che era il doppio di quella che gli avevo dato io — una tela bianca con sei tagli —, dicendomi che per eseguire la mia avevo lavorato più di lui. Possedeva una grande collezione di lavori dei suoi amici/colleghi — da Crippa a Dova, da Manzoni a Castellani, da Colombo a Boriani e ancora Twombly, Raysse, Christo, Tinguely, Yves Klein e tanti altri che dovevano essere tutti rigorosamente più giovani di lui, sia per aiutarli sia per condividere le idee. Mi invitò anche — allora ero giovanissimo — alla Biennale di Venezia e quando, meravigliato, gli chiesi il motivo mi rispose “perché sei bravo e devi esserci”. Quale lontananza dai criteri esclusivamente strategici o clientelari dei nostri giorni! Una prerogativa di Fontana era difendere la qualità e la giustizia in tutti i sensi e si ergeva sempre a difensore dei bravi rispetto ai più arroganti e potenti. Sulla porta del suo studio c’era scritto: “Io sono un santo”. Quando seppi che era morto, il 7 settembre 1968, mi sentii come se non ci fosse più Dio, perché allora credevo che Dio fosse la verità. Lucio Fontana sembrava una creatura dell’altro mondo anche perché aveva vissuto la sua infanzia in Argentina e all’epoca quei paesi e quei luoghi apparivano davvero lontanissimi. Era nato il 19 febbraio del 1899 a Rosario di Santa Fè, da genitori lombardi, ed è proprio in Argentina dove rientra dopo essere stato a lungo in Europa che nel 1946 redige, con un gruppo di suoi studenti della scuola di Altamira, il Manifesto Bianco, premessa alla teorizzazione dello spazialismo che avrebbe continuato a seguire. Sono questi gli anni in cui scrive: “Tutte le cose sorgono per necessità e valorizzano le esigenze del proprio tempo. Le trasformazioni dei mezzi materiali della vita determinano gli stati d’animo dell’uomo attraverso la storia.
Forse, Lucio Fontana può essere stato anche un po’ mistificatore per aver enfatizzato i suoi concetti dello spazio, ma ha avuto la genialità di dare un titolo, come quello di “attese”, alle sue opere più significative divenute celebri (i tagli) e questa è alta filosofia. L’ uomo senza l’attesa è nulla, perché se manca l’attesa non c’è vita.
Palazzo Ducale, Genova.