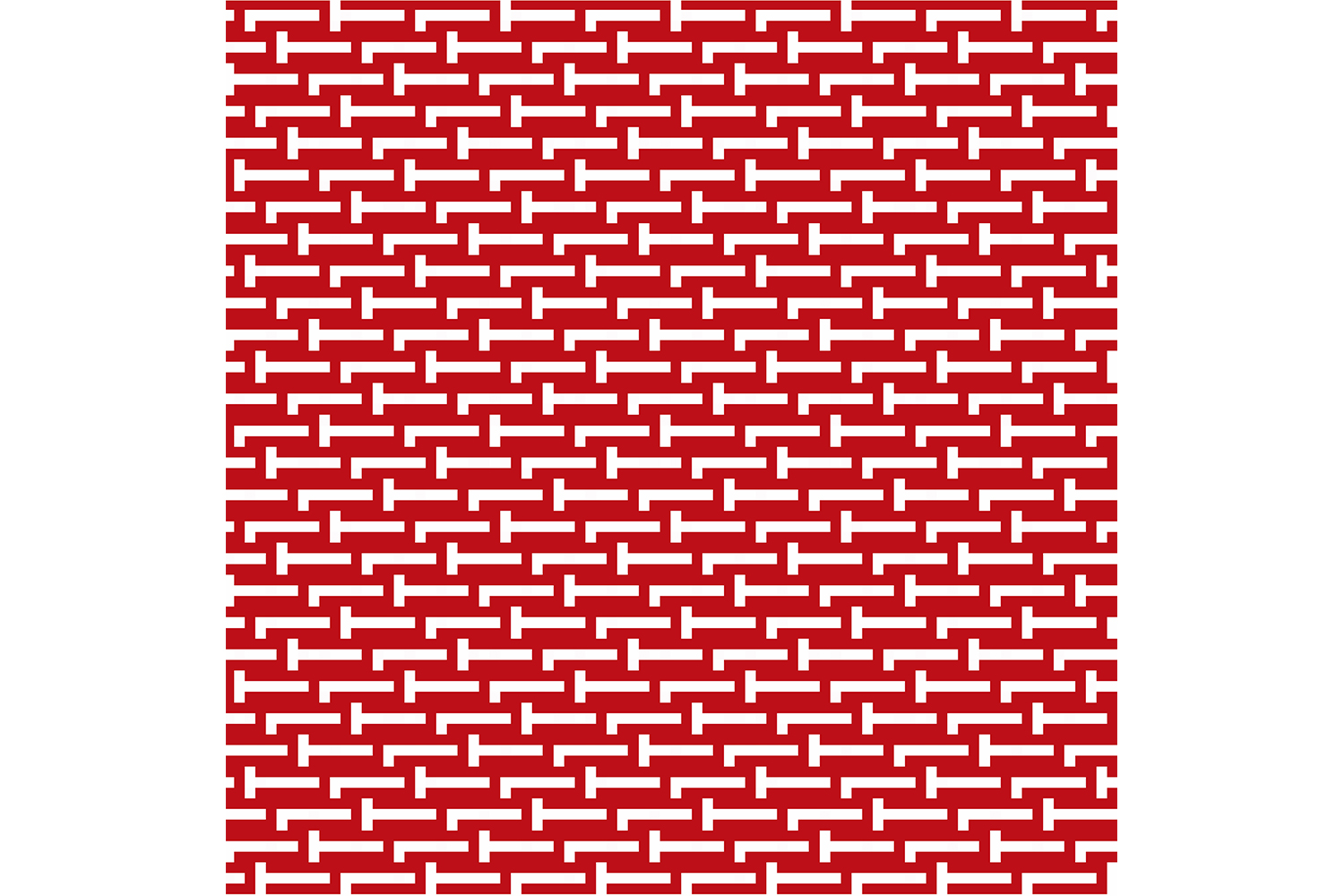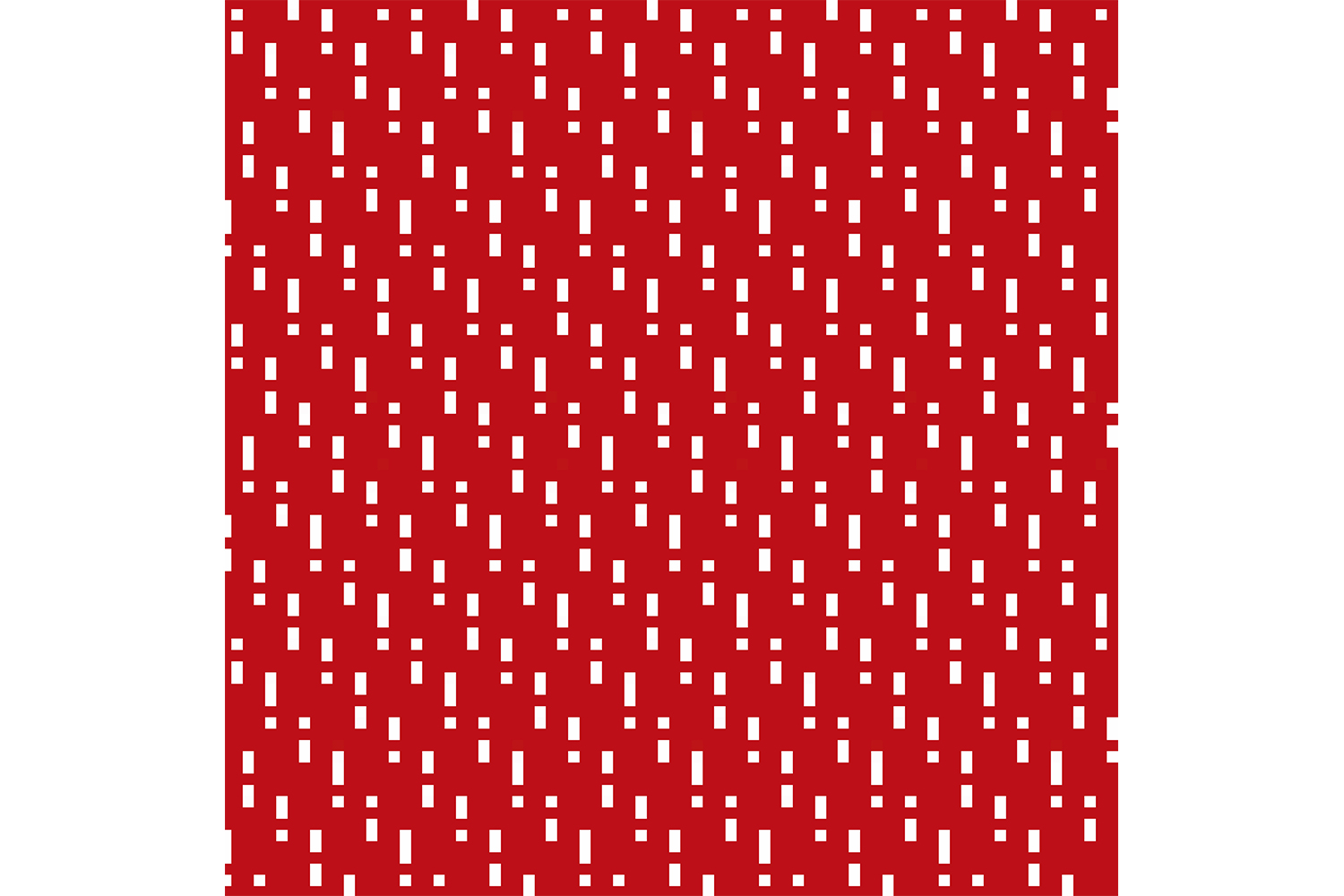La prima volta che ho incontrato Margherita Raso, a colazione, era il 2016. Era prima di “Piercing” (2017), la sua personale nell’attuale galleria Fanta-MLN, allora Fanta Spazio, a Milano, in cui ha calcato notevolmente la dimensione della scultura, letteralmente esplosa, sfiorando quasi una certa monumentalità. Vulnerabili, apparivano così ai miei occhi le prime sculture di Raso, in legno e porcellana, esposte in una collettiva nello spazio Viafarini, sempre a Milano, prima di quell’incontro (Lottatori, 2015). Erano contenute, a pavimento, incerte sulla soglia che dovessero occupare. Allo stesso tempo però trattenevano un rapporto, quasi un 1:1 fra forma e confine.
Quando mi sono avvicinata al lavoro di Margherita Raso ero ancora convinta che quando il personale si incontra – odori, vissuto, rapporto con gli oggetti e persone, inclusi noi stessi – allora non si è più in grado di discernere il perché sentiamo la necessità di riflettere (e scrivere) sul lavoro di un’artista. Quella mattina mi ha mostrato Bianco Miele (2016), che non aveva ancora mai esposto, una fusione in bronzo con una forte componente plastica: una sorta di torso alato (così mi suggeriva la forma) svuotato al suo interno. Si trattava in realtà di un tessuto jacquard che ha utilizzato come stampo, applicando la tecnica dello strappo e poi della cera persa. La forma è data dal bronzo che ha incontrato la cavità data dalla bruciatura della cera e dello jacquard nella fase di cottura. Rispetto alle porcellane incerte, qui c’era uno slancio e i confini non erano più così delineati.

La lunga conversazione davanti a quel latte (ben caldo per entrambe) era terminata con una mia affermazione singolare, suonava come un augurio, che per qualche strana ragione ho continuato a ricordare: “Per saltare in alto devi fare un bel plié”. Mi sono chiesta anche io, più volte, perché avessi trattenuto quel momento e cosa c’entrasse con il lavoro di Raso. A distanza di neppure un anno è arrivata Piercing: quattordici tessuti jacquard fissati a mo’ di drappeggio con piccole calamite, perlopiù invisibili, sostenuti da fasci di lamiera ondulata, che si stagliano parallelamente rivestendo tutto l’arco della navata dello spazio. Mentre l’occhio corre lungo i tessuti non riesce a cogliere la scultura nella sua interezza, c’è sempre un punto di vista che manca, che si perde, e nonostante la forma complessiva ricalchi la geometria della navata, mi rendo conto che non c’è più un vero confine. Si è aperto qualcosa. La forma, completata dalle sagome reiterate di un corpo (quello di Margherita) blu navy intessute nei drappi argentei, si apre e rientra continuamente; è disorientante. Lo sguardo è inevitabilmente proiettato in alto. Uno slancio della scultura, una conseguenza diretta di quel rapporto instabile e precario in quelle sculture-frammento che non azzardavano un “salto” più in alto.
Qui, un salto lo ha fatto la mia memoria, alla prefazione di Elio Grazioli che apre l’imprescindibile Passaggi1 di Rosalind Krauss con la domanda “Che cos’è la scultura moderna?”. Il senso della scultura dopo l’età moderna si produce all’interno della scultura stessa e non lo precede, come afferma Krauss –– citando il caso della Porta dell’Inferno di Rodin che sfonda la canonica divisione in quadranti della porta –– e questo spiega ancora esaustivamente quell’apertura della scultura dopo il Concettuale, dopo il Minimalismo, dopo la Land Art. Quel senso si produce all’interno dell’esperienza stessa e si reinventa sempre nuovamente, è il sé “privato e inaccessibile”2 di Edmund Husserl, che si colloca nella giunzione tra il sé privato, di cui ognuno di noi è cosciente, e l’oggetto esterno che si presenta attraverso i nostri gesti e movimenti. La scultura, da Rodin in poi, dipende dal corpo: è la prima “porta” verso l’oggetto, una superficie che ingloba interno ed esterno. Sta lì il senso dell’opera, in quella soglia liminale. In Piercing il campo entro cui si sviluppa l’immagine, 255 m2 di quattordici tessuti di 13 × 1,4 metri cuciti parzialmente fra loro, è anch’esso legato per certi versi alla dimensione di una porta, del quadro: è la soglia. Raso, con questa operazione, genera una rottura nello sviluppo del lavoro nello spazio, i drappi di jacquard sono soglie con cui il corpo necessariamente si rapporta (fisico, gassoso o di qualsivoglia natura), con un limite evidente dovuto a quella presunta monumentalità.
Parlo di monumentalità presunta perché sarebbe fuorviante leggere l’opera di Raso legandola alla sua dimensionalità e al luogo –– nell’accezione di site-specific. Se è vero che da quel momento la sua scultura esplode e il suo campo d’azione si espande, è vero anche che non è quella tensione alla grandezza l’elemento di riferimento, ma quel salto attraverso la soglia, tra esterno e interno, tra sé e corpo –– in fondo ogni immagine è una soglia e quello che cambia è il rapporto che un corpo può avere con essa.
La verticalità delle avanguardie, prima del pianale3 steinberghiano, non permetteva pienamente al corpo di sfondare la soglia, né alla scultura di essere molle, o emanciparsi dalla forma e aprirsi alla performatività (Michael Fried diceva che la teatralità aveva invaso il campo della scultura) possibile invece da quando la dimensione orizzontale inverte il paradigma, e la scultura viene letta come campo espanso4. La crisi dell’autosufficienza della forma accoglie il corpo trasformando anche la lettura frontale (verticale) dell’oggetto. Lo stesso vale quando ci rapportiamo alle sculture di Raso, negoziando il nostro movimento tra un piano orizzontale e il nostro sviluppo biologico quali esseri verticali –– ad esempio in Somersaults (2021) [dall’inglese ‘capriole’, ma vuol dire anche ‘salto mortale’ o ‘cappottamento’], le silhouettes color rame si incastrano e si portano verso il basso, fra pericolo e gioco, suggerendo un’inversione del piano. Il nostro rapporto con l’oggetto è sempre e comunque binario.
Per una delle sue ultime produzioni Raso fa un salto ulteriore verso quel rapporto contaminando notevolmente la scultura e rapportandosi a un luogo molto diverso dai precedenti: il campanile di una chiesa nel Principato di Lucedio, che si trova nell’area di un’estesa risaia vicino a un’ex centrale nucleare chiusa nell’86, il cui reattore è ancora attivo e in costante monitoraggio. La ricerca, durata circa due anni, si sviluppa a partire dal modulo della griglia – dove gli assi si incontrano ¬– che Raso sintetizza a partire dalle dinamiche geologiche del luogo (collinare, in origine) scegliendo di concentrarsi su un preciso momento in cui lo spazio (la risaia) incontra il tempo: l’inondazione, quando l’acqua irrompe nella risaia. L’irruzione dell’acqua nel terreno si configura come la rottura della griglia, quella modernista ma anche quella dell’esigenza umana, in cui afferrare (e fermare) il tempo è pressoché impossibile.
Come abbracciare un corpo? Allo stesso modo Raso si chiede come sia possibile contenere uno spazio, così inizia a fotografare il territorio con un drone nell’arco di un intero anno solare, studiandone i cambiamenti cromatici a livello scultoreo e visivo. Questa macro-osservazione è come un grande calco, un’immagine, una registrazione fisica, così il terreno si configura come materia potenziale con cui interagire a livello scultoreo. Il risultato sono tre immagini che raffigurano i momenti (tempo) in cui gli argini vengono rotti dall’acqua che entra. Il tempo reale in cui l’acqua sfonda la griglia e la struttura del “disegno” del terreno è di circa un giorno, e potremmo definirlo più un momento di entropia che una vera e propria rottura.
“Casting The Tempo”, il titolo della mostra, parte dunque da una dimensione monumentale, inafferrabile, dalla registrazione a volo d’uccello del paesaggio mantenendo una distanza notevole, per arrivare alla micro-dimensione, eccessiva, morbosa, quasi patologica dell’armatura5, ovvero la matrice nel procedimento di tessitura jacquard6. Il processo che anni fa l’aveva portata a Piercing – in cui lei stessa era parte attiva di quella esplosione della scultura – qui in un certo senso si inverte, insistendo sull’astrazione e sulla meccanica del procedimento tessile come matrice per arrivare poi alla scultura: il dittico di stampe su carta, in mostra a Lucedio, è l’armatura di 1 + 1 centimetro dei tessuti jacquard esposti. Ogni centimetro di tessuto contiene ottantaquattro fili (quadratini bianchi e rossi) di ordito7. Raso lavora su questi due moduli – Canto for The Flooded Field (2021) – emancipando l’elemento scultoreo di “struttura + tessuto” da un’architettura che lo accoglie ma che non diventa pelle (come invece in “Piercing”) e affidandoli alla musicista americana Kali Malone che ha composto una sonorità interpretando e analizzando le informazioni strutturali dei due moduli, nonché frammenti dell’armatura di due dei tessuti jacquard presenti (Lentezza No. 1 e Lentezza No. 2, entrambi 2021). Malone interpreta musicalmente i pattern delle armature zoomando su un singolo punto che la sua sensibilità percepisce come centrale del motivo, e poi mappando quella forma in strutture musicali correlate. Esaminando solo pochi millimetri del motivo jacquard, Malone sviluppa un tipo di algoritmo che la porta a determinare informazioni musicali riguardanti la durata ritmica, la struttura canonica e le variazioni di ottava. La rigidità dei parametri definiti dall’algoritmo ha determinato le progressioni di accordi e del materiale armonico. Malone compone interamente la traccia con un organo a canne; la scelta dello strumento è legata all’unica immagine intatta presente nella chiesa: il dipinto di un organo collocato sulla cantoria, una simulazione, un’immagine-simulacro che ha funzionato come un’epifania per Raso la quale, associandolo al telaio e al suo meccanismo – la successione del pedale e la dimensione dell’aria che comprime e determina il suono – invita Malone a tradurre le armature dei tessuti in una composizione per organo. I quaranta minuti della traccia contengono anche il momento dell’inondazione, che Raso percepisce come una temporalità dilatata, in un certo senso una costrizione.
Stressare la percezione nel tempo e nello spazio, è questo che fa il suono all’interno di questa mostra, di cui si avverte la sua dimensione sculturale; la massa dell’aria, il volume del suono, collocano le tre sculture in una posizione liminale e ambigua: sono superfici tridimensionali, sonore, affette dal tempo e dall’aria che penetra all’interno del campanile dove sono collocate. I quattro piani dell’edificio, piuttosto angusti, segnano inevitabilmente un percorso dalla terra al cielo entro cui si stagliano i tre jacquard sostenuti ognuno da strutture di rame – un conduttore, in questo caso associato all’acqua – di quattro metri, griglie generose ma discrete che lasciano spazio ai tessuti in grigio antracite con cromie arbitrarie dal freddo al caldo.
L’immagine, la forma, la temperatura (il calore che Raso imprime sul tessuto che palesa la grana del disegno) sono tutti elementi legati imprescindibilmente al materiale che affronta un processo di rimediazione8 – dalla scultura alla partitura sonora. Il rapporto binario fra immagine e suono è legato alla percezione aptica9, che nonostante sia un elemento invisibile nella pratica di Raso – spaziale, massiva per certi versi – è strutturale. L’immagine sonora, otticamente tattile, come si configura a Lucedio, è il risultato di un lavoro complesso ma consapevole di stratificazione per arrivare a un certo grado di percezione: qui la soglia si apre per attraversare la verticalità del lavoro, che non si esaurisce nella sua componente plastica, tattile, ingombrante o cromatica, neppure nella sua specificità all’interno del luogo. Questo asse verticale dato dalla tensione verso l’alto delle sculture – come anche del luogo in cui sono collocate – si allarga con il movimento di attraversamento della soglia. La visione è sempre parziale, e anche quando esiste una possibilità di frontalità non si compie mai in modo definitivo.
Il lavoro di Margherita Raso si colloca in ciò che chiamerei verticalità espansa10, una modalità di svincolare certe produzioni scultoree dalla loro dimensione prettamente fisica e site-specific, considerando la tensione all’alto come una delle componenti per attraversare e percepire i vari passaggi mediali dell’opera. La specificità legata al luogo in Raso non è che una manifestazione di una delle possibilità della percezione, e non l’abitare della scultura a un determinato luogo.
Torniamo allora a quella vulnerabilità – che c’era in Bianco Miele (2016) e oggi in Untitled (2021), una scultura in bronzo realizzata con lo stesso procedimento – che continua a essere presente nell’opera di Raso in una modalità che entra consapevolmente nei meccanismi produttivi e che stressa il tempo nel tentativo di occupare, sempre diversamente, lo spazio.