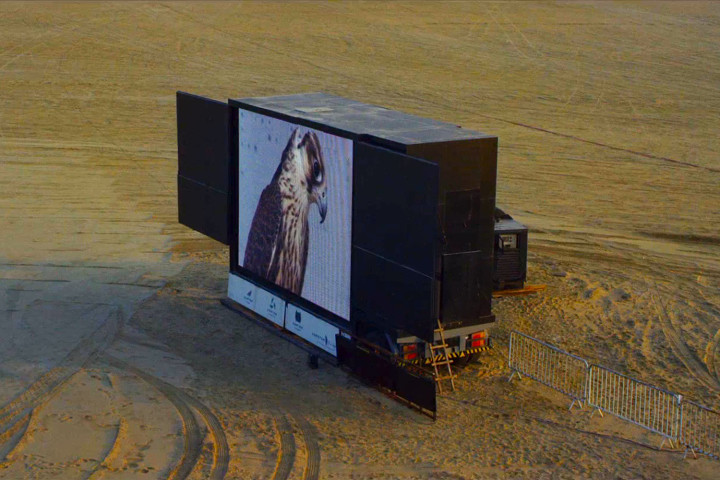“A real artist, a real L.A. detective, a fake rock”
Tutto comincia con Michael Scott, il controllato ma risoluto investigatore privato, ex detective della omicidi in pensione, che mette la sua esperienza al servizio di un caso anomalo, la ricerca di un sasso in fibra di vetro perfettamente mimetizzato nel deserto del Mojave. Rocky II è un’opera di Ed Ruscha degli anni ’70 oramai dimenticata, perduta per sempre se non per un unico indizio: il documentario della BBC (Seven artists, 1979) che mostra l’artista impegnato nel trasporto del masso nel deserto americano. Questo documento è ciò che smuove la trama di Where is Rocky II? (2016), domanda con cui il regista Pierre Bismuth coglie di sorpresa Ruscha durante la conferenza stampa per la sua retrospettiva alla Hayward Gallery di Londra. Tutto ciò che vediamo nel film è infatti reale, non segue un copione, ma solo gli sviluppi delle premesse ironicamente orchestrate da Bismuth. Scott è dunque catapultato in universo ameno, costruito su linguaggi e convenzioni distanti dalla sua esperienza quotidiana. Come un antropologo esperto, Scott accetta le credenze dell’arte contemporanea senza mai giudicare, anzi, è l’unico a non dubitare mai dell’esistenza né del valore conferito a tale pietra filosofale. Il film di Bismuth è, in questo senso, un inno alla ricerca dove Scott, investigatore come lo sono gli storici dell’arte, non cerca informazioni, cerca conoscenza.
Post-truth, fake fictions
Ripercorrendo le consuetudini filmiche del genere investigativo, Bismuth è stato capace di esplicitare le potenzialità narrative insite nei documentari, creando ciò che lui stesso chiama “fake fiction”, dove il reale si trasforma poiché codificato dal vocabolario cinematografico. È interessante notare come il 16 novembre scorso, giorno d’inaugurazione del festival, abbia coinciso con la decisione da parte degli Oxford Dictionaries di scegliere “post-truth” come parola dell’anno¹, nella sua nuova accezione che descrive la necessità di ridurre le potenzialità del reale per renderlo più facilmente comprensibile e trasmissibile. Al contrario, molti degli artisti presenti nel programma del festival si sono confrontati con la capacità dell’arte di superare la realtà non per semplificarla ma, anzi, per aumentarne le possibilità critiche.
Omer Fast affronta le ripercussioni psicologiche della guerra in Afghanistan da parte di una coppia tedesca e del loro figlio militare (Continuity, 2016), studiandone i sintomi attraverso una narrazione in cui casualità e linearità lasciano lo spazio a una continua ricombinazione di personaggi ed eventi che possa rendere “l’esperienza traumatica attraverso la distruzione della catena di significato”. Se tale combinatoria può ricordare inizialmente Teorema di Pasolini, la mancanza di una logica geometrica mostra una realtà tradotta da un algoritmo difettoso, che finisce per sovrapporre il paesaggio invernale tedesco a un campo di battaglia afghano, i cui orrori sono mostrati attraverso una composizione che evoca la celebre fotografia di Jeff Wall Dead Troops Talk (a vision after an ambush of a Red Army Patrol, near Moqor, Afghanistan, winter 1986) (1992).
Nico Joana Weber nel suo Markasit (2014) ci mostra la Ruhr-Universität a Bochum attraverso l’esperienza di una figura silenziosa, forse mitologica, forse fiabesca. Questa viandante, portatrice di un realismo magico, osserva in segreto lo sviluppo della nostra civiltà, mostrandoci con occhi nuovi il sapere scientifico racchiuso in questa architettura brutalista, prima di tornare nella foresta e concludere il proprio viaggio di formazione. Così interviste e riprese di un vero istituto di talassoterapia diventano il contesto per The Waterway (2014) di Louise Hervé e Chloé Maillet, in cui un club privato cerca di prolungare l’esistenza dei propri iscritti ibridandoli con la fauna marina. In entrambi i casi le immagini documentarie si uniscono a una narrazione fantascientifica e fiabesca, con il risultato di rendere la fantasia più reale, e la realtà più fantastica.
Etologia e antropologia visiva
In Faux Départ (2015), Yto Barrada documenta con delicatezza la pratica diffusa in Marocco dei “magasin des fossil aux bon prix”, dove artigiani, con molteplici strumenti e soluzioni, realizzano “veri nuovi fossili” per ogni necessità turistica. La riproduzione attraverso il calco si rispecchia sia nel supporto visivo scelto (la grana del 16mm sembra copiare quella della polvere che circonda questi scultori di favole) sia nell’ultima scena, in cui un artigiano, facendo un catalogo dei propri attrezzi, lascia un’impronta scultorea sulla sabbia.
L’interpretazione del reale attraverso la materialità del supporto filmico è al centro anche della ricerca di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi. Tramite una macchina analitica capace di leggere pellicole rovinate dal tempo, la coppia filma nuovamente materiali d’archivio “in una maniera personale, non filologica. Vogliamo che il film appaia come nostro, nelle parti che ci interessano: i dettagli e la velocità”. Diario africano (1994) è il racconto per immagini di un viaggiatore di fine anni ’20, in cui colori e grana raggiungono attraverso il filtro della camera analitica una dimensione pittorica vicina a Delacroix. Aiutata dalla colonna sonora, questa interpretazione di un diario privato astrae il valore di documento storico verso una lettura più viscerale delle immagini.
Se Barrada usa il calco per parlare di fossili estinti, Luca Trevisani realizza una scansione emotiva di un monumento vivente: Sudan, l’ultimo maschio di rinoceronte bianco esistente al mondo. L’artista non offre mai una visione d’insieme del proprio soggetto, ma procede invece per dettagli e prossimità, lasciando che sia una vicinanza quasi tattile a definire il ritratto di questa scultura che respira, preservata per frammenti che si possono ricostruire solo nella nostra esperienza cinematografica.
Epilogo
Un coro di luci e suoni accompagna l’ingresso dei visitatori nella sala deserta. Da un palco il canto di un soprano si unisce al ritmo di tamburi elettronici che scandiscono con solennità la lettura del preambolo al trattato costitutivo dell’Unione Europea. Mentre la cantante protagonista di The financial singing (2014)² di Elena Mazzi interpreta la complessità emotiva racchiusa nell’andamento degli ultimi 130 anni della borsa americana, ASTROLOGY OF A FRIDAY (2016) di Teresa Cos rimette in movimento le necessità non solo commerciali alla base di un’Europa unita. Il soffitto testimone della firma del trattato è filmato da Cos in una coreografia ipnotica, mostrato come un ingranaggio bloccato in un presente insicuro del proprio futuro. Questi sono due dei dodici video³ che hanno attivato con la propria presenza fisica i corridoi, il palco e i camerini del Cinema La Compagnia, aumentando l’esperienza del festival su più livelli e dimensioni.