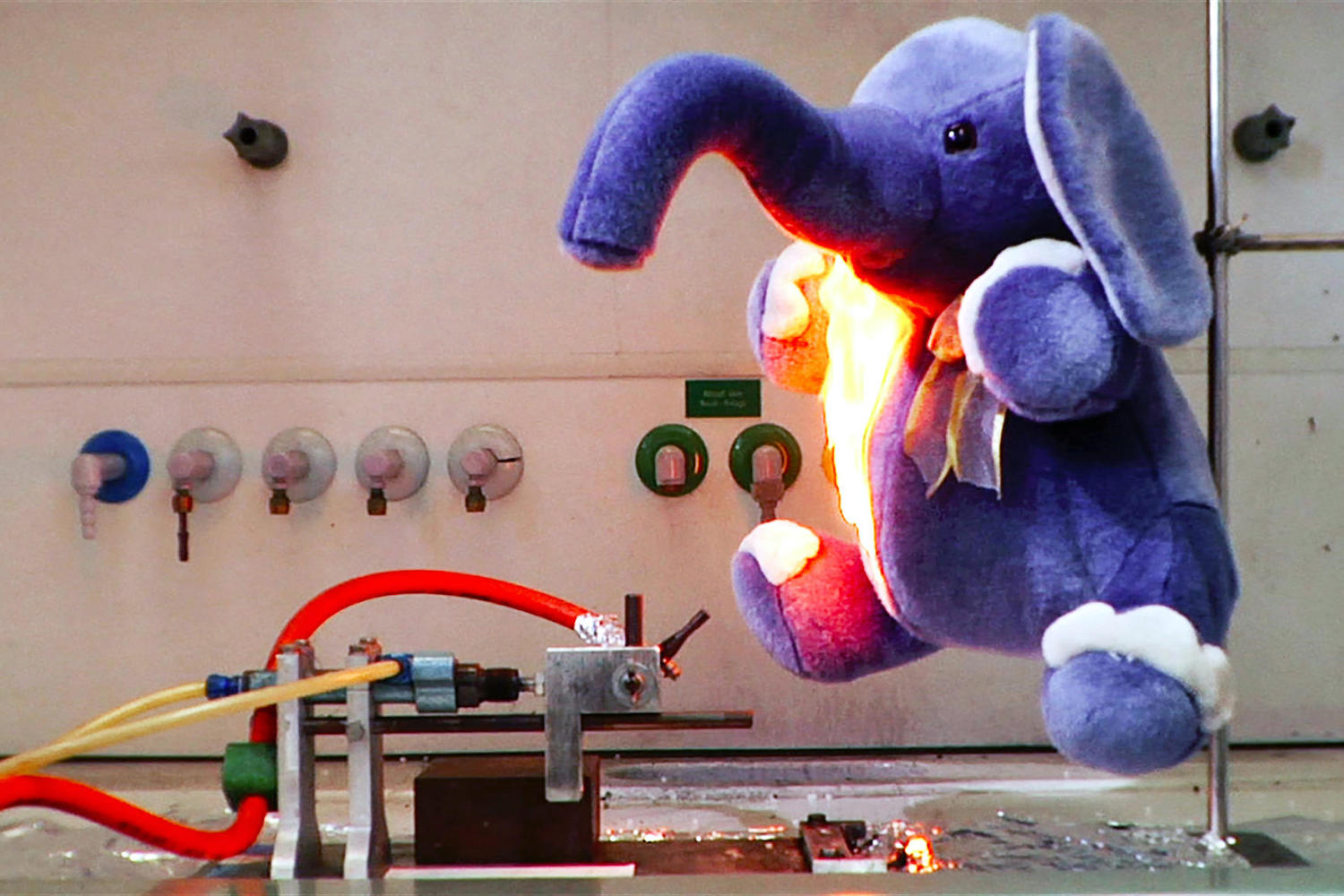A giudicare dalla storiografia italiana, e non solo, sugli anni Ottanta sembra che il problema dei femminismi e della relativa ricerca artistica si sia fermato alla decade precedente, indiscutibilmente significativa per le grandi conquiste femminili. Con il dissolversi della seconda ondata femminista e con i cambiamenti politici avvenuti tra la fine degli Settanta e i primi anni Ottanta – non solo in Italia con il consolidarsi del Partito Socialista di Bettino Craxi, ma anche nel resto dell’attuale Europa con François Mitterand in Francia, Margaret Thatcher in Inghilterra e Helmut Kohl in Germania – si ritiene che la questione della partecipazione attiva dei cittadini, anche delle donne, nella politica passi in secondo piano e che di conseguenza anche la ricerca artistica che nei decenni precedenti si era nutrita delle contestazioni sociali venga meno, soprattutto dal punto di vista femminista. Questa analisi deriva da un problema di storicizzazione e dell’attuale lento revisionismo degli anni Ottanta. A conferma di quanto detto, soprattutto nell’ottica di una ricerca storica dell’arte al femminile, si è atteso il 2020 per avere finalmente una riflessione storiografica su ciò che si può considerare il punto più alto per la critica d’arte e l’arte femminista alla fine degli anni Settanta, ovvero la mostra di Lea Vergine a Palazzo Reale di Milano, “L’altra metà dell’avanguardia 1910-1940. Pittrici e scultrici nei movimenti delle avanguardie storiche.”1 Resta, invece, ancora da ridefinire il peso di una mostra fondamentale quale “Materializzazione del linguaggio”, curata dall’artista Mirella Bentivoglio, nel 1978, ai Magazzini del Sale alle Zattere in occasione della XXXVIII Biennale di Venezia.
Questo decennio è stato caratterizzato, sul piano nazionale e internazionale, da importanti cambiamenti nel fare artistico e da nevralgici stravolgimenti negli equilibri fra artista, gallerista e critico d’arte. Il perché di una difficile ricerca sull’ “arte e i femminismi” italiani di questo decennio si deve inquadrare certamente anche nel diverso ruolo che il critico d’arte inizia ad assumere in Italia, in particolar modo con Achille Bonito Oliva che nel novembre del 1979 pubblica, proprio sulle pagine di Flash Art2, il manifesto programmatico della “sua” Transavanguardia. “La Transavanguardia c’est moi!”, esclama Bonito Oliva in occasione della nascita del movimento artistico di cui è il responsabile non solo del termine e della sua teorizzazione, ma anche nella scelta degli artisti – in questo movimento non vi è spazio alcuno per le artiste – e delle opere. Nel contesto italiano il ruolo assunto dal critico d’arte è eccezionale se messo a confronto con quanto accade fuori dalla penisola: il critico è colui che teorizza, informa, crea, distrugge e trasforma. Bonito Oliva ottiene un enorme successo a livello internazionale non solo per quanto riguarda il mercato delle opere: la sua Transavaguardia, i suoi artisti, sono conosciuti ovunque, le opere sono richieste dai più importanti collezionisti globali.
Nel 1982, Bonito Oliva realizza quella che forse è da considerarsi la mostra più importante per la definizione del suo movimento, “Avanguardia Transavanguardia 68-77” alle Mura Aureliane di Roma, città in cui fino a qualche tempo prima Palma Bucarelli era stata la direttrice e sovrintendente della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e in cui, dal 1976 al 1978, aveva operato la Cooperativa Beato Angelico, a cui, oltre all’Accardi, avevano aderito circa una decina fra artiste e critiche dell’epoca. Per questa mostra, Achille Bonito Oliva coinvolge due artiste, Carla Accardi e Marisa Merz, un numero certamente esiguo rispetto ai restanti quarantatré artisti coinvolti. Nel catalogo della mostra Bonito Oliva interpella la critica Annemarie Sauzeau-Boetti per fare un bilancio di quella che era stata la parabola femminista in Italia fino agli anni Settanta:
[…] Si riparlava dunque di Identità, tramite differenziazione…Per fondare differenza e identità, si fece ricordo ovviamente a una cultura del “pieno”, a un insieme di “valori”. Furono restaurati e capitalizzati antichi culti, blasoni e “lettere di nobilità” femminili. Questi “grandi racconti” riconfermavano maschile e femminile in disastrosa e paralizzante contrapposizione.3
La lettura sul femminismo proposta da Sauzeau-Boetti non è sicuramente una delle più positive, né tantomeno è l’unica voce che negli anni Ottanta riflette su quello che era stato il fenomeno femminista. Quel che interessa è l’interpretazione che ne dà in termini di identità e di contrapposizione dualistica maschile-femminile, individuando proprio in quest’ultima una delle ragioni per cui il femminismo il Italia nel corso degli anni Ottanta ha perso la forza linfatica degli inizi.
Pensando a un termine di confronto con la situazione del femminismo in Italia negli anni Ottanta bisogna far riferimento alla Germania di quello stesso decennio, ancora divisa dal Muro in due blocchi, la Repubblica Federale e la Repubblica Democratica. In questo caso, è la situazione presente all’interno del blocco occidentale che desta più interesse: l’analisi artistica inerente i femminismi sussiste certamente anche all’interno del blocco orientale, seppur con qualche limitazione dovuta alla visione del femminismo come fenomeno importato dal capitalismo americano. È in particolare la Berlino Ovest a rappresentare il punto nevralgico di formazione di un tipo di “sottocultura” che ha permesso, nei primi anni Ottanta, una ricerca identitaria (anche femminista) e artistica molto più profonda rispetto alla situazione italiana coeva. La Berlino divisa dal Muro diviene terreno fertile per il costituirsi di quel fenomeno sociale che prende il nome di Subkultur, nato in contrapposizione con la cultura istituzionale e come reazione ai cambiamenti globali e che, nel caso berlinese, ha precisi attori – artisti, cantanti, musicisti, transgender, dragqueens, gay, lesbiche, rivoltosi, disoccupati, abusivi – nel contesto del quartiere Kreuzberg, a ridosso del Muro, un vero e proprio laboratorio di sperimentazione artistica e culturale in cui gallerie autogestite, discoteche e pubs punk e new wave ne sono il fulcro. Se le artiste, dal punto di vista delle grandi istituzioni museali tedesche, continuano ad avere difficoltà ad essere rappresentate (fatta eccezione per qualche mostra come, ad esempio, la nota “Künstlerinnen international: 1877–1977” del 1977 presso lo Schloss di Charlottenburg, il cui catalogo è stato studiato anche da Lea Vergine per la sua rassegna a Palazzo Reale), è in questa vivissima scena artistica della sottocultura che hanno possibilità di esprimersi e di portare avanti quella ricerca sull’identità, anche di genere, che nell’Italia contemporanea viene meno.
In questo particolare microcosmo culturale tedesco (oltre al caso berlinese, si ricordano simili situazioni ad Amburgo e Colonia), le artiste sono occupate a collaborare insieme ai colleghi uomini, molti dei quali impegnati nell’esplorazione e nell’espressione della propria identità sessuale, tema centrale – insieme a quello della “maschera” e del travestimento – nell’arte tedesca degli anni Ottanta. Artiste come Elvira Bach, Ina Barfuss, Bettina Semmer, Sabine Herrmann, non solo fanno parte dei gruppi musicali punk e new wave protagonisti delle notti berlinesi, ma prendono parte alle collettive dei loro colleghi uomini – si ricorda che si tratta di gallerie ed eventi quasi sempre autogestiti, non subordinati alle istituzioni culturali ufficiali – e svolgono la loro indagine figurativa focalizzandosi sulla propria identità sessuale e di donna, come soggetti nel ruolo esistenziale del genere, al pari di artisti come Rainer Fetting, Salomé o Helmut Middendorf.
In opere quali Nachteule (1982) o Ohne Titel (Ich bin nicht gut, ich bin nicht böse) (1983), Elvira Bach mette in scena le sue tipiche Io-Donne, figure voluminose che fanno esplodere lo spazio pittorico, realizzate con tratti energici, contorni forti, colori sensuali. Le donne indossano abiti scollati e aderenti, marcatamente truccate, nascondono gli occhi dietro gli occhiali e fumano con spavalderia. Per i soggetti, è quasi difficile distinguere, se non per un discorso prettamente stilistico, le donne della Bach dai travestiti soggetti delle opere di Salomé e di Fetting. Accanto a tematiche più personali, legate anche al discorso identitario, non bisogna dimenticare artiste come Ina Barfuss o Bettina Semmer che realizzano anche opere di contestazione, come Weltwährung (Valuta mondiale, 1981) di Barfuss, una critica molto forte al nascente neoliberismo reaganiano, in cui i fotomontaggi dell’artista dada tedesca, Hannah Höch sono ancora molto presenti; e Kuh (1983) di Semmer in cui un minotauro femminile tiene in mano la mela di Eva, simbolo del peccato, accanto a una copia esatta di sé. Il dipinto ha una carica critica molto forte nei confronti della società patriarcale e misogina: il minotauro, rappresentazione del male, solitamente è raffigurato come un essere androgino, mentre in questo caso ha attributi femminili e porta in mano “la mela del peccato originale” della tradizione cristiana.
La mancanza di storicizzazione e revisionismo che caratterizza gli anni Ottanta è ancora più sensibile per quanto riguarda l’arte e i femminismi: è necessario e utile per comprendere le difficoltà della storia del femminismo italiano in questa decade e confrontare tale realtà con altre internazionali , come provo a fare in questo breve testo, con la situazione della Germania dell’Ovest, dove nei primi anni Ottanta, anche come conseguenza del vivido ambiente culturale, si continuano a riconoscere leggi importanti, come quella sulla parità di trattamento tra uomini e donne sul lavoro istituita in Italia solo a partire dal 2006.