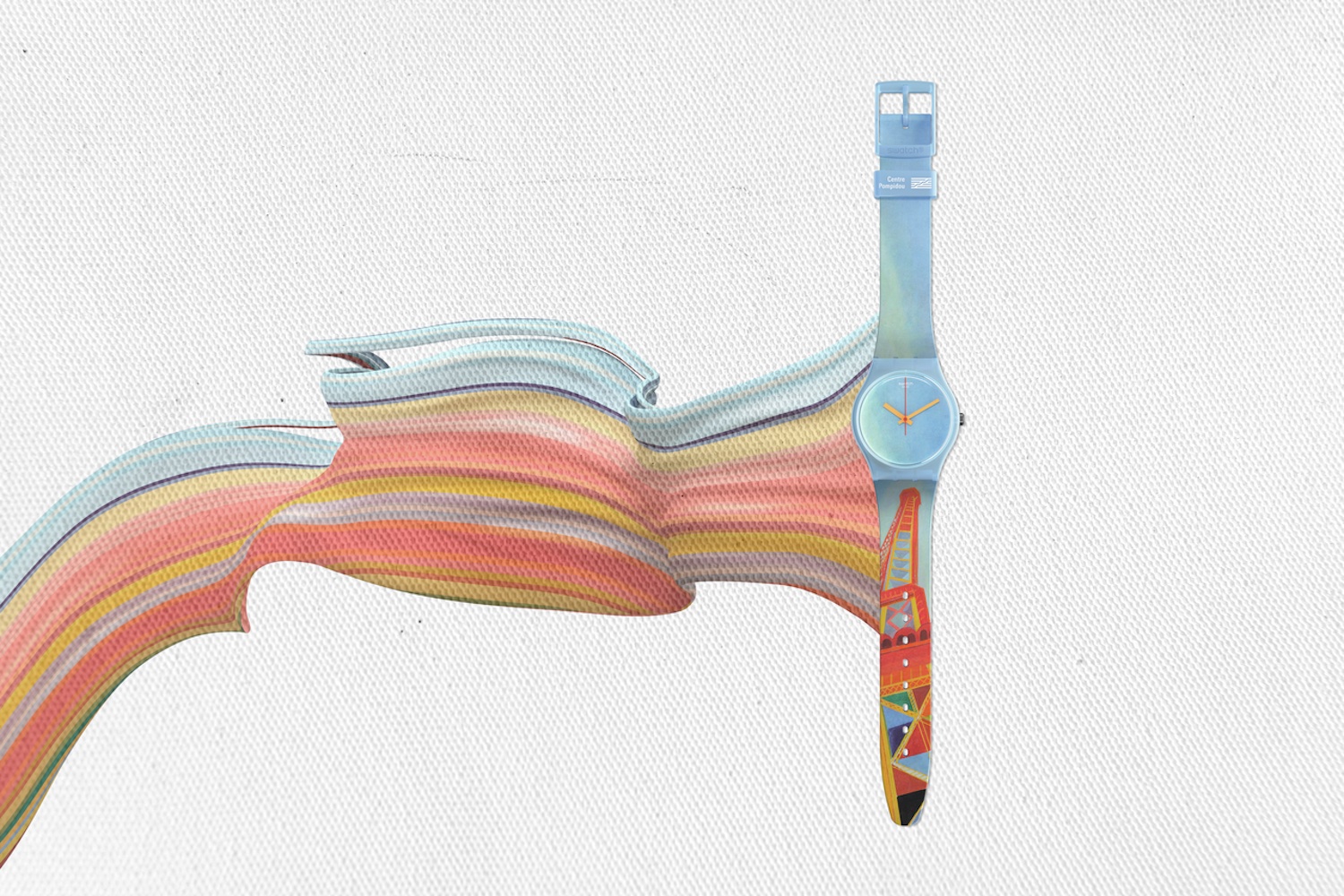Il titolo di questa conversazione cita una fortunata rassegna bolognese del 1981 curata da Francesca Alinovi, Renato Barilli e Roberto Daolio. Ho scelto di riprenderlo per chiarire fin da subito un punto centrale del lavoro di Martina Rota: che si tratti di pittura, scultura, letteratura, musica o danza, linguaggi che l’artista considera senza gerarchie, c’è sempre un elemento esperienziale intrinseco che la porta spesso a completare l’opera in senso performativo. Partendo dalle immagini, Rota pensa ai modi più efficienti e pratici per realizzarle, abitandole e mettendole in azione. Il medium privilegiato diviene così la triade sincronica corpo-spazio-tempo.
Giulia Zompa: Mi sembra che il tuo lavoro si ponga come una continua esplorazione dei meccanismi del corpo, un’ossessione per la scoperta delle sue infinite possibilità di esistenza. Si tratta di un aspetto significativo, ma forse il tuo lavoro è prima di tutto un’indagine sul linguaggio, sia verbale che non verbale, sui limiti e le ambiguità della comunicazione. Solo successivamente si concentra sul corpo. Questa visione mi permette di comprendere, per esempio, la tua passione per la poesia e la crescente centralità della performance nella tua pratica artistica.
Martina Rota: La tua osservazione è assolutamente puntuale e coerente, e ti ringrazio per aver offerto questo punto di vista che spesso manca. Sono sempre stata molto interessata ai linguaggi e alla loro estremizzazione, anche se poi non scelgo necessariamente l’estremo di un linguaggio, ma qualcosa di più minimale. Secondo me là dove c’è ricerca c’è performance. Forse per questo negli ultimi anni ricado lì. Come ben sai, anche una ricerca teorica confinata alla pagina scritta implica un atteggiamento performativo: andare in biblioteca, stare sui libri, parlare con artisti e condurre interviste. C’è nella ricerca, aspetto che per me è fondamentale, questo atteggiamento di apertura e sconfinamento, soprattutto spaziale. La performatività mi permette di interagire con lo spazio in un senso molto ampio, cosa che, per esempio, la pittura per sua natura non consente, poiché più focalizzata e circoscritta. A me, invece, interessa riconsiderare lo spazio e la sua apertura. Credo che si sia perso il contatto con la spazialità e con il significato di abitare gli spazi: li attraversiamo in modo schematico, senza esplorazione, mentre la performance offre questa possibilità di scontrarsi con lo spazio, attraversarlo, respingerlo, farlo proprio anche attraverso diversi materiali.
GZ: Nell’opera Dirty Sweat (2021), affronti l’orgasmo come strumento di rivendicazione politica e personale, trasformando un corpo traumatizzato, segnato da abusi e violenza, in un corpo capace di riscoprire il piacere. Questa è una riflessione sul corpo che parte dalla tua esperienza autobiografica. L’analisi del rapporto tra le donne e il loro corpo, e della sessualità femminile a partire dal sé, è stata centrale in molte riflessioni del movimento femminista. In che misura oggi definiresti il tuo lavoro femminista e quanto, e come, credi che si apra ad altre questioni?
MR: La tua domanda è sicuramente lecita, soprattutto considerando i tempi in cui viviamo. Con sincerità, credo che il mio lavoro, per la mia biografia e le scelte di impegno politico della mia vita personale, abbia molto a che fare con il femminismo. Tuttavia, vorrei fare questa riflessione: mi domando quante volte venga chiesto a un uomo quanto il suo lavoro sia femminista e come si rapporti a tematiche urgenti come questa. Credo quasi mai. Invece, a me è stato chiesto molte volte, soprattutto in passato, quando la visione estetica del mio lavoro era molto legata al colore rosa, che negli ultimi anni è stato oggetto di rivendicazione del femminismo e di una certa moda. In passato mi è stato anche chiesto di partecipare a rassegne o mostre legate al femminismo, e ho rifiutato. Trovavo fuorviante etichettare il mio lavoro come esclusivamente femminista, in quanto poteva distorcerne la percezione. Il femminismo è necessario e ribadisco lecito, ma credo che non debba diventare la chiave di lettura dell’arte. Può essere una lente con la quale la si legge, ma non l’unica. L’arte deve sempre fornire aperture. Come dice una mia carissima amica arista, Carolina Papetti, “Femminismo è un concetto che rompe, si dilata, si restringe attraverso non solo il suolo dell’opera ma anche nei meandri del sotto sotto suolo”. Nell’arte c’è l’intento di raggiungere il maggior numero di persone possibile. Mi chiedo se essere definita esclusivamente femminista possa escludere una parte di pubblico. Anche con l’ultimo progetto With All My Strength (2024-in corso) che coinvolge tre bodybuilders, il tentativo è sempre quello di aprire a nuove narrazioni, coinvolgendo corpi e soggetti che solitamente non consideriamo alleati. La mia indagine non è specificamente un’indagine sul genere, tuttavia sarebbe da incoscienti non considerare ciò che ogni corporeità porta con sè. In questo senso, posso definire femminista la scelta consapevole di ciò che il corpo trasporta all’interno del lavoro che sia me stessa, un gruppo di adolescenti o di body builders. L’opera d’arte comprende sempre in sun discorso politico ed etico stratificato dove diversi gradi di lettura si compenetrano.
GZ: In Dirty Sweat, il fatto che questa ricerca del piacere sia condotta da una donna fa una differenza significativa. Mi piacerebbe sapere da te quanto questa sia stata un’operazione veramente chirurgica anche di rielaborazione del tuo passato e del tuo vissuto, e quanto potrebbe invece essere delegata a un uomo, eterosessuale o omosessuale, o a una persona transessuale, e quali differenze comporterebbe.
MR: Io avevo bisogno di affrontare questa pratica chirurgica, come l’hai definita tu, e di chiedere al mio corpo qualcosa che trovavo difficile. Sei anni fa ho iniziato il lavoro Dirty Sweat e il percorso è ancora in evoluzione. Avevo conosciuto il mio fisioterapista, Claudio Morandini, che è anche sessuologo, per una serie di problemi che avevo. Lui mi ha spiegato che il nostro corpo è progettato per trattenere il dolore in situazioni di pericolo, ma non per immagazzinare il piacere. Mi ha invitato a provare il maggior numero di orgasmi possibile. Uscendo da lì, mi sono chiesta cosa significasse. Questa riflessione mi ha completamente cambiata. Fino ad allora, la mia indagine era sul dolore e le sue varie forme, su come viene rappresentato ed esorcizzato. Ma quel punto di vista personale mi ha spinta a chiedermi quale voce e ruolo abbia il piacere nella mia vita, nella persona che sono e in come abito lo spazio. Ho iniziato da me stessa, finché ora mi rendo conto che forse è il momento di concedere questa pratica ad altri corpi e riportarla per me in una sfera privata. Il rischio di cercare il piacere attraverso la performance è infatti poi quello di strumentalizzarlo, c’è un click che scatta dopo un po’ di tempo per cui il piacere diventa cristallizzato, si affossa in un ideale e allora non performi più cercando piacere, ma il piacere diventa là, e allora dico stop. Penso spesso anche ai corpi anziani, marginalizzati: dopo i 60 anni, è come se un corpo non avesse più il diritto di esplorare il piacere. Sarebbe curioso proporre questa performance a un’ottantenne, ad esempio, per aprire ulteriormente il discorso.
GZ: Parlando di Dirty Sweat, hai ricordato che questa performance è mutata nel tempo. Nei tuoi lavori, un elemento ricorrente è la scioglievolezza di alcuni materiali, che mi sembra mettere in evidenza proprio il tema della temporalità. Le tue opere esistono spesso in uno stato di flusso e cambiamento, riflettendo l’aspetto transitorio della vita e delle esperienze umane. Questo è evidente anche in Don’t Fight The Feelings (2023), dove la performance è intrecciata con lo sciogliersi dei ghiaccioli. Qual è il significato della scelta di certi materiali?
MR: Non amo vedere le cose sempre uguali e anzi forse la staticità mi spaventa. È una scelta operata su più piani alcuni più consapevoli altri meno.
GZ: Anche in With All My Strength, la performance a cui stai lavorando e che coinvolge alcuni bodybuilders, mi hai detto che inizialmente avevi pensato a una performance senza acqua ma poi questo elemento è arrivato…
MR: Sì, anche prepotentemente, visto la forma attuale dei cuscini d’acqua. Ho una fascinazione per l’acqua come elemento; mi fa paura l’idea di perderla è una delle mie più grandi paure e al tempo stesso mi eccita l’idea che non posso mai possederla. Quindi forse l’acqua è per me un feticcio fantasma, che posso solo divertirmi ad esperire, ad attraversare, a lasciare andare e, quando lo fai, assume forme e immagini totalmente inaspettate e sorprendenti.
GZ: Mi sembra che questi elementi scioglievoli, l’acqua stessa, abbiano sempre una sfumatura erotica. Penso in particolare alla candela di cera nella fotografia UNTITLED 111 (TO FORGET) (2021), un’opera che inaugura la tua indagine sul piacere, fino a Dirty Sweat, dove il tuo sudore diventa protagonista insieme al raggiungimento del piacere stesso.
MR: Direi che più che di sfumatura erotica possiamo parlare di intimità delle immagini. Mi interessa stabilire una relazione di intimità tra le immagini e chi le guarda, per poter aprire la lettura del lavoro a più livelli di profondità. Come se l’immagine e l’osservatore fossero due amanti o due vecchi amici. Quella componente di indicibilità che si trattiene nello spazio di mezzo.
GZ: In alcuni casi sei la protagonista delle tue performance, ma molte volte lavori con altri corpi. Questa relazione mi incuriosisce molto, soprattutto il modo in cui il tuo sguardo diviene in una qualche misura esterno e le diversità a cui conduce. Che tipo di rapporto è e come scegli di interpretare o non interpretare direttamente?
MR: Il rapporto è sempre un rapporto di fiducia, se non faccio un’operazione di fiducia il lavoro non parte. Inoltre, è per me spesso un momento di respiro, uscire da me stessa e portare il mio retro-mondo ad incontrare il retro-mondo degli altri. Analizzare, osservare minuziosamente altri soggetti è un grande scambio sia in termini umani che lavorativi. Sono molto “controllante” nel mio lavoro e forse proprio per questo mi piace lavorare con altre persone, per perdere quel controllo. La scelta delle persone si basa sulla loro soggettività; chi sono, come sono, da dove vengono, che visione hanno, ecc… mi interessa ciò che il singolo può portare nel progetto, comprendere il punto di risonanza delle nostre soggettività e generare delle temporanee collettività. Sembra banale, ma non lo è, è una relazione tra noi, il pubblico e lo spazio. Se consideri tutto come una relazione, gli elementi su cui agisci agiscono anche su di te, e infatti uso elementi attivi che influenzano l’opera. Quando performo da sola, è molto più difficile trovare questo equilibrio perché è una relazione interna; non ho sguardi esterni e l’unico modo che ho di vedermi è attraverso la camera o gli occhi degli altri. Sono due mondi diversi: uno mette in dialogo il mio interno, l’altro si apre di più, e queste due pratiche si compensano.
GZ: Insistendo su questo ruolo attivo degli elementi, in molte opere costringi i performer a confrontarsi fisicamente con oggetti specifici, trasformando lo spazio performativo in un luogo di interazione dinamica. I movimenti del corpo rispondono e si adattano all’ambiente, rivelando una sincerità del corpo ma anche la sua vulnerabilità.
MR: Quando il corpo è in uno stato di iperattenzione e allerta, non puoi concentrarti su come rappresentare il movimento, ma devi semplicemente essere presente con sincerità. Quando presento un lavoro so che ci saranno quelli che io chiamo “appuntamenti”, delle immagini che sono ancore, ma non so mai esattamente come si verificherà la nascita di questi appuntamenti. C’è una componenete di imprevedibilità e di rischio molto alta. Questo fa emergere altre intelligenze del corpo e altre immagini non previste, che non necessariamente devono essere forti, ma che sorprendono me e chi le vive dall’interno. E quando ti sorprendi, questo crea una sorpresa anche in chi osserva.
GZ: In molte delle tue opere, l’uso del corpo e dei suoi movimenti ripetitivi sembra andare oltre l’aspetto puramente coreografico e ritmico portando a galla ossessioni e componenti psicologiche.
MR: Si potrebbero fare due discorsi paralleli. Uno riguarda il non dover necessariamente trovare qualcosa di nuovo, quindi l’idea di uscire dall’urgenza dell’inedito. Forse è nella rivisitazione e nell’abitare gesti che si ripetono che posso trovare una novità. A volte, ripetendo un gesto infinitamente, mi rendo conto che scopro strati nascosti, cose che mi muovono, anche se la forma esterna può sembrare invariata. Il secondo discorso, quell’aspetto psicologico a cui ti riferisci, mi fa pensare a ciò che dice sempre il mio maestro di yoga: se una cosa si ripete nella tua vita, probabilmente è perché non hai ancora imparato la lezione e devi rimanere in quel pattern. Concedersi la possibilità di stare in un loop di gesti senza fuggire, ma abitarlo completamente, è importante. Forse è questo, l’aspetto dell’abitare la dimensione presente, non cercare di sfuggirla ma includerla.