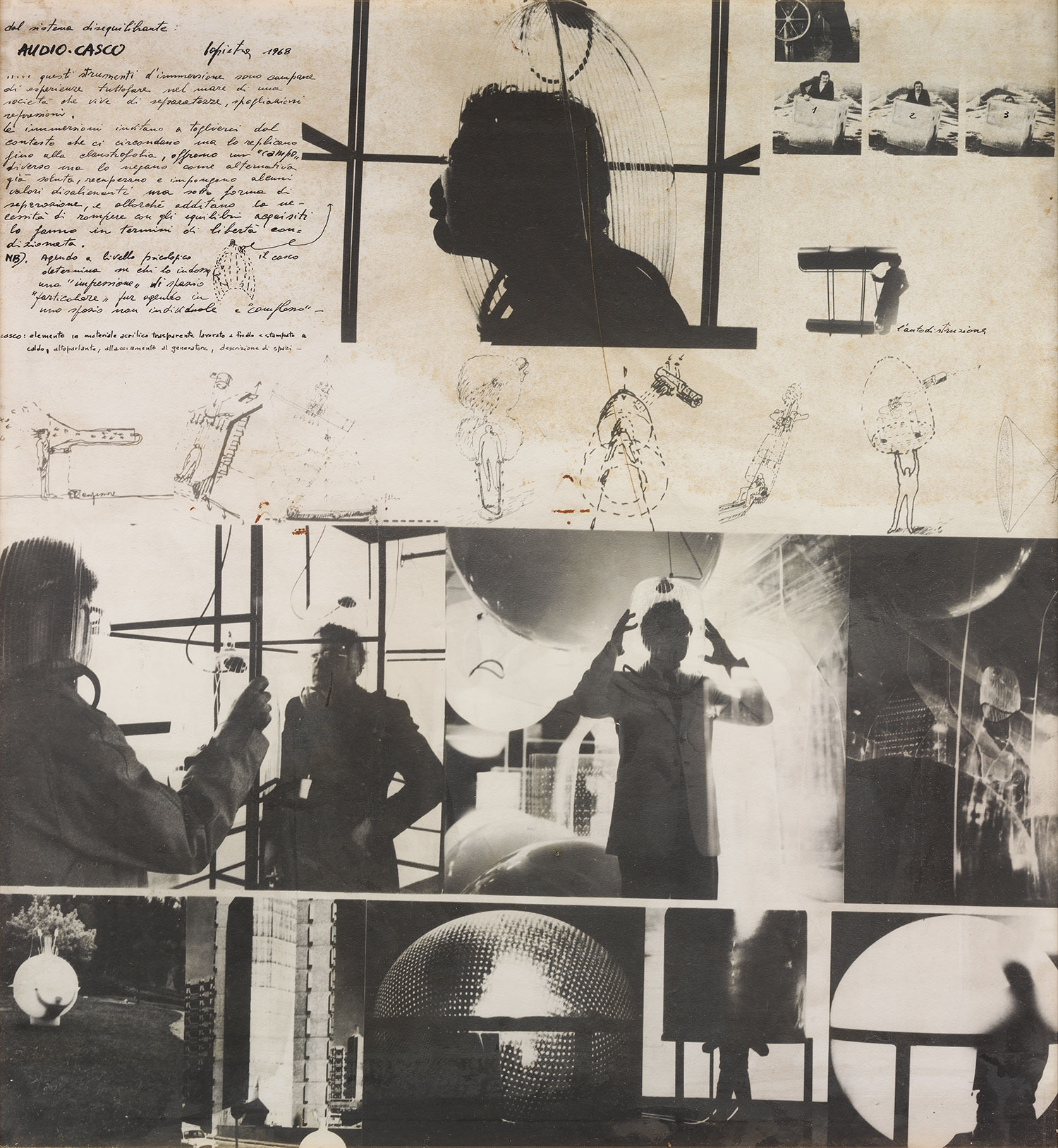“In qualsiasi situazione è possibile trovare altri mondi.” Quella frase di Darko Suvin, sospesa tra autobiografia e teoria, è la chiave che spalanca “The Island”. Perché il nuovo progetto di Hito Steyerl non è una mostra: è un collasso narrativo programmato. Geologie e algoritmi, memorie di guerra e rendering quantistici, archeologia e pop culture si toccano, si urtano, talvolta si annullano. Un’isola che non galleggia: vibra.
A Milano, negli spazi dell’Osservatorio Fondazione Prada – un’architettura mentale tanto quanto fisica – Steyerl converte l’aneddoto di Suvin in un dispositivo espositivo. Quell’episodio di Zagabria nel 1941, l’esplosione, e l’istante in cui il giovane Suvin si immagina catapultato dentro Flash Gordon alla conquista di Marte, non è solo un ricordo: è già una dichiarazione di poetica. La fantascienza come dispositivo di sopravvivenza, “una scialuppa mentale nelle ore più buie”. L’immaginazione come difesa, come salto quantico involontario.
Da lì, tutto avanza con la logica di un mondo che cambia stato. Il tempo non scorre: si stratifica, arretra, sobbalza. Steyerl non cita la fisica quantistica: la assorbe. Stati sovrapposti, dimensioni parallele, realtà che collassano come schermi che si accendono simultaneamente in stanze diverse. Così l’isola oscilla – senza perdere ritmo – dal Neolitico sommerso ai laboratori di IA generativa, dalle coralità della klapa alla qualità trash dei contenuti sintetici, dalle superfici liquide di una sfera luminosa alle poltrone rosse di un cinema anni Quaranta che sembrano in attesa di spettatori defunti.
Il primo livello è un archivio impossibile: un globo come pianetino in decompressione, scansioni 3D come reperti post-umani, interviste che sono più apparizioni che documenti. Tommaso Calarco, Mate Parica, Sachi Shimomura, Suvin stesso: più che rispondere, tracciano vettori. Costruiscono un sistema di coordinate dove l’archeologia incontra la fisica, la storia del linguaggio incontra la fantascienza. Le poesie di Suvin, adagiate su legni restituiti dal mare, funzionano come messaggi da un’altra linea temporale.
Il secondo piano è una macchina scenica perfetta: la ricostruzione di una sala cinematografica reliquia emotiva, la piattaforma-isola, la proiezione che intreccia canto tradizionale, storia culturale e scarti temporali. Qui il film si riprende il primato, ricordando che il cinema – quando torna a essere mondo – resta “una delle tecnologie più avanzate dell’immaginazione”.
Le installazioni finali – legni marini che reggono emisferi proiettivi come piccole lune sommerse – riportano tutto all’origine: la materia, il tempo profondo, la memoria non umana. E soprattutto quel junk time, il “tempo spazzatura” di cui parla l’artista: il tempo artificiale e accelerato del capitalismo, fatto di loop, salti, sospensioni. Steyerl lo mette in collisione con i tempi geologici e subacquei, che scorrono fuori da qualsiasi algoritmo. È un attrito senza soluzione, un’oscillazione continua tra il rumore tossico del presente e il silenzio remoto della storia.
“The Island” – curata da Niccolò Gravina – ci ricorda che la fantascienza non è un genere, ma la grammatica del nostro tempo. E che l’arte, quando funziona davvero, non crea mondi alternativi: li rivela. Un varco improvviso nel mezzo del rumore. Un dettaglio che si apre. L’attimo in cui passiamo dall’altra parte.