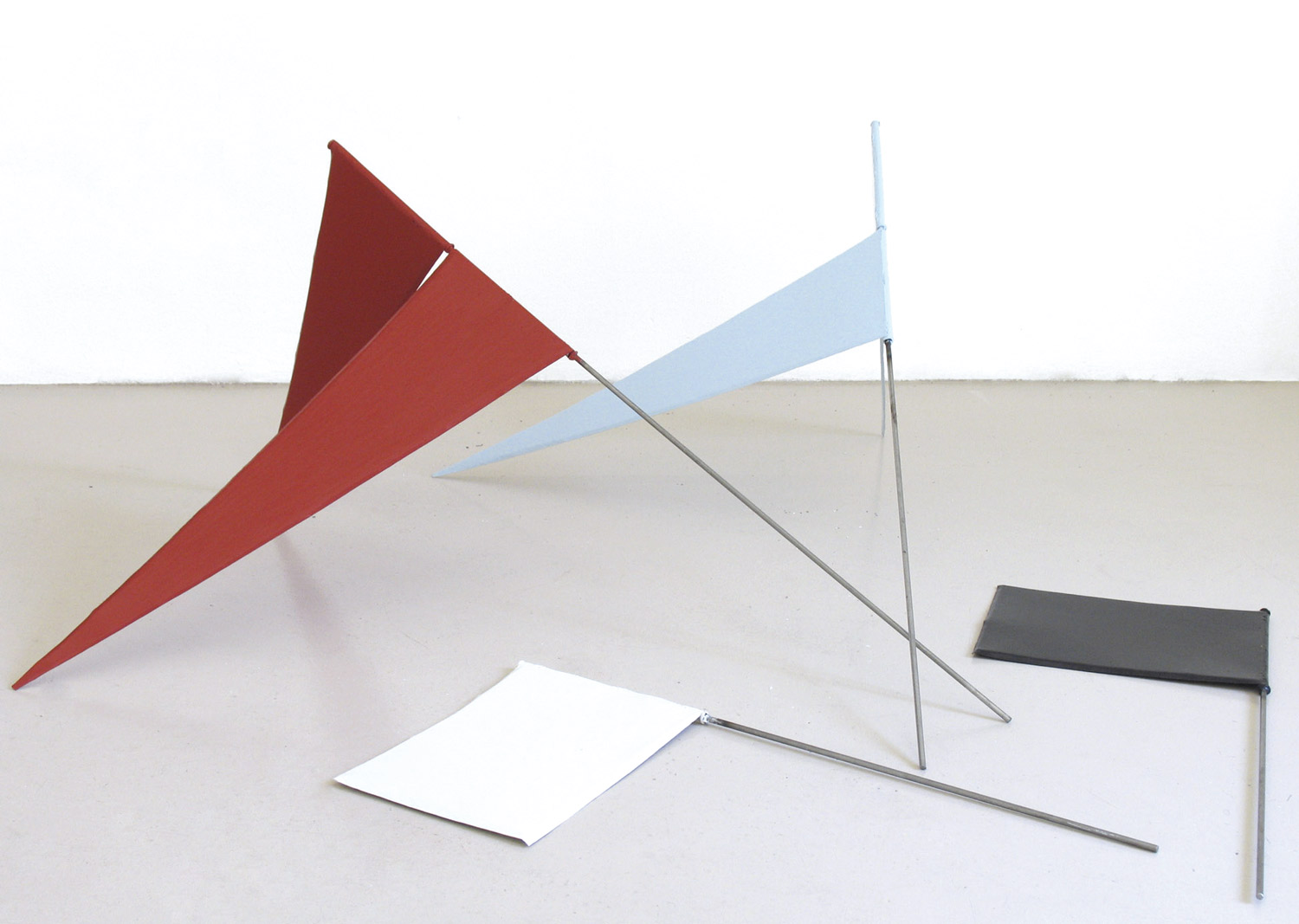Maria Brewinska: Hai partecipato a grandi mostre collettive di pittura come “Urgent Painting”, “Painting On The Move” e ora “The Painting of Modern Life” alla Hayward Gallery di Londra. Hai iniziato la tua carriera con mostre alla Galeria Zderzak di Cracovia e al CSW di Varsavia nel 1999. Nel 2001, alla Foksal Gallery di Varsavia, hai presentato il film Automobili e persone. Da pittore ormai affermato quale eri hai annunciato di lavorare anche con il mezzo filmico. Questo mi ha ricordato quando, recentemente, hai detto di “aver rischiato per la seconda volta” e alla mostra dei candidati al premio Vincent 2006, allo Stedelijk Museum di Amsterdam non hai presentato dipinti ma solo tre film. Nelle tue ultime mostre personali hai esposto dipinti e film, come se non volessi essere associato solo alla pittura. Con quale mezzo ti identifichi di più?
Wilhelm Sasnal: È un po’ colpa mia se vengo considerato soprattutto come un pittore. Fino al 2004 ho esposto quasi solo dipinti, i film erano riposti in un cassetto. La mostra alla Foksal è stata un’eccezione, e in gran parte un’idea di Andrzej Przywara. Si trattava di aspettare. Ho esposto i film assieme ai dipinti per la prima volta in una mostra alla Kunsthalle di Zurigo nel 2003: i film erano proiettati in un luogo defilato, in biblioteca, su uno schermo televisivo. Anche nel 2004, alla mostra “Who If Not We” allo Stedelijk Museum — a cui partecipavano artisti dei paesi da poco nell’Unione Europea — ho esposto sia dipinti che film. Al premio Vincent 2006 ho deciso invece di presentare solo tre film: River, Kodachrome e Kamera.
MB: Qual è stata la reazione?
WS: Il curatore non ha commentato i film, ha solo detto che amava la mia pittura. Non mi aspettavo di ricevere un premio, è stato un grande evento nella mia vita adulta. Mi ha fatto capire che qualcosa era cambiato. Per molto tempo era come se le persone prestassero attenzione solo alla mia pittura, mentre adesso vengo considerato come un artista che lavora sia con il mezzo pittorico che con quello filmico. Questa complementarietà nel mio lavoro mi permette di tenere una certa distanza nei confronti di entrambe le discipline. Associo l’idea di “essere pittore” agli insegnamenti accademici, e non nascondo che è un guscio che ancora mi porto sulle spalle.
MB: Parli spesso dell’Accademia con una certa avversione e dell’“essere pittore” in senso negativo, accademico appunto.
WS: Spesso penso alla pittura come a una tecnica sterile, perfetta ma priva di anima ed energia. Non voglio essere perfetto ma avere il massimo della distanza possibile dal mio lavoro, per poterlo guardare da una prospettiva più ampia. Dipingendo a volte ho la sensazione di non sapere nulla e che sia il dipinto a guidare me, non io il dipinto. Questo sentore si enfatizza quando faccio film. Ma se voglio risolvere un problema mi è molto più semplice dipingerlo; filmare vuol dire invece intervenire su un materiale precedentemente raccolto e dal quale solo in seguito posso ricavare qualcosa.
MB: Cosa è venuto prima: la pittura o i film?
WS: La pittura, ma prima ancora l’ascolto della musica. Durante il primo anno di istituto professionale iniziai a ricalcare le copertine dei dischi di heavy metal. Scoprii il gruppo rock Bauhaus e solo allora appresi che cosa fosse il Bauhaus in arte. Lessi un libro sul Cubismo, non ci capii nulla, ma lo lessi fino alla fine.
MB: Allora vivevamo oltre la cortina di ferro, non tutto arrivava fino a noi, e per quanto riguarda la musica la fonte principale era la radio. Quale radio ascoltavi in quel periodo?
WS: Soprattutto il terzo canale, ma anche il secondo canale della radio polacca che prevedeva delle serate dedicate ai dischi. Uno dei dischi più importanti per me è stato South of Heaven degli Slayer; lo registrai la prima volta proprio dal secondo canale, una domenica, alle nove di sera. Non ascoltavo la stazione degli scout, non ero ancora così alternativo…
MB: Andavi a lezione di disegno, imparavi a dipingere e a filmare?
WS: Ricordo il mio primo quadro, un paesaggio dipinto su tavola con colori a olio tratto dal libro Paesaggi di Cracovia di Adam Bujak. Ero forse al quarto anno di scuola. Allora dipingevo solo per me, disegnavo moltissimo. All’università scelsi la Facoltà di Architettura perché sapevo che non ce l’avrei fatta a entrare all’Accademia. Così l’architettura divenne un surrogato degli studi artistici. Entrai ad Architettura e dopo due anni, quando ormai dipingevo più di quanto progettassi, superai l’esame per entrare all’Accademia.
MB: Come hai fatto a sopportare quei due anni ad Architettura? Ti sentivi costretto a fare una cosa invece che un’altra?
WS: Non posso dire che fosse una costrizione, gli studi universitari davano molte possibilità, ma quando sono entrato all’Accademia ho sentito che qualcosa nella mia vita stava cambiando. È stato forse al secondo anno che comprai dal padre di un mio amico d’infanzia una cinepresa 8mm. Era il 1995, fu il mio primo contatto con una cinepresa. Giravo filmando situazioni normali, familiari. Mi interessai ai film perché ero affascinato da quelli di Ryszard Antoniszczak.
MB: Antoniszczak usava diverse tecniche di animazione, inclusa quella di disegnare direttamente sulla pellicola.
WS: E per quei tempi “primitivi” era qualcosa di molto coraggioso. Secondo me è stato il capostipite del punk nel cinema. Colorai il mio primo Super8, mi piaceva scrivere, incidere la pellicola con pennarelli ad alcol per fare in modo che le scene prendessero vita, come nei film di Antoniszczak.
MB: I tuoi primi film erano molto sperimentali, stavi testando le possibilità del mezzo?
WS: Sì, e in questo mi aiutarono molto Marek Norek e Krzysztof Szafraniec del centro culturale di Nowa Huta. Ho girato i miei primi film con una cinepresa 16mm che avevo avuto da loro.
MB: Perché utilizzi la pellicola e non la banda magnetica?
WS: Perché è un altro tipo di immagine. Quando ritraggo qualcuno creo un tipo di universum e credo che la pellicola dia un risultato simile: un certo tipo di solidità, di densità del mezzo, come il colore a olio. Ha molta importanza anche il modo in cui in seguito proietto il film. So di non poter filmare tutto, la pellicola è corta, dura solo tre minuti, e le decisioni vanno prese in poco tempo.
MB: Hai scelto la pittura in un momento in cui imperversavano videoarte e installazione. Cosa ti interessava allora?
WS: Non riuscivo a orientarmi nel mondo dell’arte. Per me sono stati molto importanti Andrzej Wróblewski e il Gruppa. Il loro lavoro mi sembrava ancora molto fresco, mi piaceva il loro approccio alla pittura, vi compariva anche la musica… Non era pittura seriosa, pomposa. Conoscevo anche Libera e Kozyra, anche se non erano pittori.
MB: I quadri dipinti tra il 1997 e il 2001 sono completamente diversi: “pop-banalistici”, “nominalistici”, la critica li chiama in vari modi. Come sei giunto a questa svolta in pittura?
WS: Credo che fossi stanco del gruppo Ladnie e pur provando a fare qualcosa di mio subivo il marchio di fabbrica di Ladnie. A un certo punto ho capito che non volevo più avere nulla a che fare con tutto quello che avevo fatto fino ad allora — una creazione allegra, acritica, che non toccava le cose fondamentali. Ho capito che dipingere è un modo di esprimere ciò che non si può dire con le parole, che l’arte è misteriosa, tocca l’invisibile, l’indicibile. Non mi piace l’arte che gioca né quella che fa il verso al linguaggio pubblicitario. Amo le emozioni e il mistero che l’arte contiene. Vale la stessa cosa per la musica. Era il 2001 ma ancora mi capitava di fare certi quadri pop. Non ho però bruciato tutto dicendo “mai più”. Forse non è stata una rivoluzione ma un’evoluzione.
MB: Nei tuoi dipinti oggi giochi con le convenzioni, decostruisci, riduci, disorienti, commetti errori: rifuggi continuamente il “bel quadro”.
WS: Quando non sapevo in quale direzione dirigere la cinepresa creavo sempre qualche casino per fare in modo di avere un po’ di azione da riprendere. Probabilmente faccio la stessa cosa quando dipingo. Per me è importante mettere le cose sottosopra, rivoltarle.
MB: Hai sempre dipinto partendo da fotografie, trattando però la fotografia solo in quanto mezzo, perché è il soggetto che conta.
WS: Terminata la scuola ho iniziato a ritoccare le fotografie in modo da far risultare il dipinto il meno possibile accademico. Ora uso colle, tessiture, materiali puramente pittorici che prima non avrei mai usato perché li associavo a qualcosa di anacronistico. In questo momento il medium da cui prendo le immagini è secondario, ma continuo a usare la fotografia.
MB: Suppongo che alla pittura non si accompagni un’immagine fissa nella mente, ma che sia soggetta a cambiamenti…
WS: Effettivamente non è un fermo immagine, nel dipinto costruisco un intero mondo, incluso il tempo che passa mentre dipingo e il tempo di cui un dato soggetto è impregnato.
MB: Può sembrare che registri incessantemente immagini per i tuoi quadri…
WS: Oggi, mentre stavo guidando, ho visto una cornacchia che reggeva qualcosa nel becco. È un’immgine a cui è possibile attribuire molti significati ma non volevo nominarla, rinchiuderla. Non sono riuscito a fotografarla così ho provato a cercare delle foto di cornacchie su Internet. La prima visione della cornacchia ha agito come un motorino d’avviamento che mi ha portato poi a rovistare alla ricerca di altre cose. Non conosco mai la direzione verso cui mi dirigo, ma trovo sempre qualcosa di interessante lungo la via. Le osservazioni importanti vengono da presentimenti, intuizioni, non da una scelta o da un’associazione razionale, come ad esempio le cornacchie nell’emblema nazionale tedesco…
MB: Una volta hai detto che dipingere ti chiude mentre filmare ti apre. È ancora così?
WS: Un dipinto è sempre la trasformazione di qualcosa di già visto o ricordato; è come praticare un foro nella propria pancia e mescolare i colori da qualche parte all’interno. Quando dipingo mi immergo profondamente in me stesso e le immagini che uso sono casuali, raramente le cerco, più spesso le trovo. Con i film è diverso: devo piazzare la cinepresa e indirizzarla verso situazioni su cui in seguito posso costruire una narrazione o che posso accompagnare alla musica. Per me un film è fortemente legato alla musica. Quelli tra i miei film che “illustrano” una musica sono nati dal mio girovagare per la città con il walkman: è il video musicale più bello, che giri nella mente, ascolti la musica e guardi il mondo cercando di adattarlo ad essa. Devo avere gli occhi ovunque per trovare la situazione più appropriata. Assorbo più di quanto non “sputi fuori”. Dipingere è un po’ come sputare, e filmare è assorbire.

MB: Cosa accade al materiale che raccogli? E fino a che punto lo sottoponi a una selezione?
WS: A volte si deposita per un paio d’anni aspettando il suo momento. Se filmo seguendo un piano o un copione inizio a lavorarci subito dopo aver sviluppato la pellicola.
MB: Dipingi/sputi un gran numero di quadri, come suggeriva la mostra “Cento pezzi” svoltasi alla galleria Zderzak nel 1999. Da dove nasce questa energia nel dipingere? Ed è corretto parlare di energia?
WS: Sì, ti senti il fuoco dentro. Mi sveglio con questa sensazione e so che devo subito mettermi al lavoro. D’altra parte, è un modo ideale per combattere la noia…
MB: Si può avere l’impressione che tu abbia un’eccezionale facilità nel dipingere…
WS: No, è un’illusione. Se sei serio con te stesso e onesto con gli altri pretendi sempre di più. È il mio pane quotidiano, quello che ho fatto oggi dipingendo quell’uccello nero su sfondo verde. È una lotta, cancello e ricomincio da capo. La pittura è per me come assorbire un frammento della tela tramite l’energia e la densità del colore.
MB: Cosa vuoi ottenere?
WS: Luc Tuymans ha affermato di aver sempre dipinto quadri in modo tale che sembrassero risalire a cinquant’anni fa. Io voglio dipingere quadri che tra cinquant’anni sembrino identici a oggi, trovare una forma che vada oltre il tempo. È proprio questo che amo della pittura, trovare una certa consistenza, una densità del colore, che determini il carattere imperituro del dipinto.
MB: Spesso dipingi in serie, costruendo una narrazione più ampia intorno al soggetto che ti interessa.
WS: Alcuni soggetti richiedono più di un dipinto, un commento più ampio, come Ural e Moscice. Mi interessa la tensione, la chimica che si genera tra i dipinti, perché l’accostamento di due dipinti crea una situazione nuova. Alcuni sono autosufficienti e funzionano al di fuori della serie, ma per dipingere un quadro di questo tipo bisogna acquisire una certa credibilità attraverso altri lavori.
MB: Come sono nati i quadri della serie di Moscice? Questo è un soggetto importante nei tuoi dipinti, molto personale.
WS: Sulla base di fotografie di famiglia e altre prese dai libri. La serie è stata in qualche modo integrata perché ho dipinto molti altri quadri: il cielo e i riflettori dello stadio, Anka alla casa della cultura, la strada per Moscice. Questo soggetto vive in me e ancora non ho realizzato un lavoro che lo illustri per intero.
MB: Dipingi in serie di getto o a distanza di tempo?
WS: La serie “Metinides”, ad esempio, l’ho dipinta di getto. Ma alcuni soggetti si ripetono, ritornano, come gli aerei o i pianeti.
MB: Perché ti affascinano così tanto gli aerei?
WS: Perché non c’è nessun altro dispositivo che possa far volare così comune come l’aereo. È un normale mezzo di trasporto, anche se non mette l’uomo nella sua condizione naturale. Ad esempio, puoi dipingere un UFO solo sulla base di fotografie, e non sai se sono attendibili o frutto di manipolazioni. Ci si invischia nella psichedelia, il soggetto stesso è ambiguo, tocca la questione della fede, dell’ingenuità…
MB: Anche il film Concorde tratta il tema del volo, il volo di addio di questo gigante… È un film a cui del resto tu stesso hai partecipato.
WS: Da bambino sapevo dell’esistenza di un aereo che era il più veloce, il più bello, e che volava più in alto di tutti, e quando hanno annunciato che il Concorde non avrebbe più volato volevo fare qualcosa. Per me era come la fine di un’era, come se avessero rinchiuso la mia infanzia nella bacheca di un museo. Per questo ho volato con il Concorde, filmando il cielo dal finestrino. Volevo che questo film, proiettato, si consumasse fino a scomparire, come il tempo, la memoria.
MB: È un film sulla fugacità? È piuttosto sentimentale…
WS: Sì, in ciò che faccio c’è molto sentimentalismo, non lo nego.
MB: Hai affrontato un tema simile nel film Kodachrome: la fine di una tecnologia di culto.
WS: In Occidente intere generazioni hanno girato film in Kodachrome e volevo mostrare la fine di quest’epoca. Ho raccolto testimonianze di persone che utilizzavano il Kodachrome a livello amatoriale assieme ad altre di alcuni specialisti di questa pellicola, che non sbiadisce mai. Le ho unite ad altre informazioni, come ad esempio quella che sostiene come l’omicidio del presidente Kennedy fosse stato registrato su Kodachrome. Entrambi i film sono sulla fine di un’epoca e della tecnologia che l’ha contrassegnata. Concorde è meno immediato, più concettuale; in Kodachrome ho unito le informazioni che riguardano la pellicola alle dichiarazioni di chi ha viaggiato in Concorde realizzando così il suo sogno. Entrambi i fenomeni sono nati e si sono conclusi più o meno nello stesso periodo.

MB: Con i film lotti forse meno che con la pittura. Assieme alla musica e ai viaggi, girare film ti dà molta soddisfazione?
WS: Girare film è meno impegnativo che dipingere. Sì, è un grande godimento portare la cinepresa in un posto nuovo e interessante, dove tutto si dispone in una totalità. Filmare vuol dire anche afferrare una realtà che mi sfugge, che per me è nuova. Nel film Brasilia tutto si svolgeva casualmente, le dimostrazioni di piazza non erano pianificate, non avevamo idea di cosa stesse succedendo. È stato un puro piacere filmare quegli avvenimenti, ma in un tale approccio con la realtà si nasconde anche la mia bramosia: quando qualcosa mi interessa voglio filmare tutto. Del resto, anche in pittura voglio appropriarmi il più possibile dello spazio, avere tutto per me. Nei film mi piace creare una nuova realtà a partire da quella esistente, costruire una nuova vita a partire da elementi reali: si può commuovere lo spettatore fino alle lacrime. Le persone non si commuovono così tanto davanti a un dipinto…
MB: Si può dipingere tutto ciò che si può immaginare. Senti di essere in qualche modo limitato in ciò che puoi dipingere?
WS: Sì, ci sono cose che non dipingo. Nell’archivio fotografico “Atlas” di Gerhard Richter ci sono alcune immagini che raffigurano dei campi di concentramento che l’artista ha deciso di non dipingere. Anch’io la penso così, posso dipingere sulla base di Maus, perché lì c’è come una diluizione, sul confine tra la morale e l’estetica, ci sono cose che non affronta…
MB: A proposito del film 80064 di Artur Zmijewski e del suo protagonista che ha accettato di farsi tatuare nuovamente il numero del campo di prigionia, hai detto che queste persone per te sono intoccabili e che non avresti mai potuto comportarti come Zmijewski né in un film né in un quadro, così come non dipingeresti un campo di concentramento a partire da una fotografia.
WS: Ciò che ha fatto Artur riguardava un uomo reale e il suo vissuto. Io non l’avrei mai fatto, non avrei rischiato di risvegliare emozioni in un uomo che è passato per una cosa del genere.
MB: I dipinti in cui risali all’epoca dell’Olocausto parlano spesso attraverso paesaggi, luoghi della memoria o dell’oblio, i quali, come in Lanzmann, svolgono il ruolo di testimoni della morte. Se appaiono persone sono ad esempio l’interprete con il volto cancellato.
WS: Sì, si trattava di dipingere un testimone muto, che si limita a tradurre e non prende posizioni, e che semplicemente si trova in mezzo agli interlocutori.
MB: I dipinti sui rapporti tra ebrei e polacchi affrontano un tema che è tabù. Sono molti, quali sono le tue motivazioni?
WS: Prima di tutto l’acquisizione della consapevolezza di ciò che è successo. Il film di Lanzmann Shoah e il fumetto Maus di Spiegelman sono apparsi nello stesso periodo, per questo ho fatto dei dipinti su di loro. Dall’altro lato, lo ammetto, è una forma di sentimentalismo. Il passato è più romantico, e attraverso questi lavori in qualche modo mi trasporto nel tempo.
MB: Adam Szymczyk ha detto che affrontando temi che erano o sono tutt’ora difficili, rimossi, tocchi la questione della vergogna e della colpevolezza, mettendoti nella posizione del colpevole, sebbene tu non lo sia.
WS: Non è tanto la colpa, quanto il sentimento di vergogna, perché è successo qui ed è una cosa terrificante che i polacchi vi abbiano preso parte. Il libro Paura di Jan Gross fa riferimento ai testi di Jastrun o di Andrzejewski evidenziando quanto sia inverosimile che, in Polonia, dopo la seconda guerra mondiale, sia potuto sopravvivere un così forte antisemitismo. È la rabbia, forse non la vergogna ma l’onta di essere di qui.
MB: I tuoi dipinti danno anche vita a un nuovo campionario di soggetti legati alla Storia. Nessun artista in Polonia scopre il passato come lo fai tu.
WS: Perché mi sta a cuore, amo vedere i vecchi film. Sento che il tema della guerra è terribile ma per chi può apprendere solo dalla televisione e dai racconti è come una calda coperta che ci avvolge tutti. Una piattaforma comune dove poter dialogare.
MB: Un quadro che riguarda il passato e la memoria collettiva è il ritratto di Narutowicz, che forse è un rifacimento… Torni spesso a ridipingere un quadro?
WS: Ho dipinto il ritratto di Narutowicz, che aveva un aspetto terribile, come se fosse stata la commissione per un dignitario qualsiasi. Ho pensato che l’unica cosa che avrebbe potuto salvarlo era offuscarlo con una specie di pellicola nera, un filtro, che suscitasse associazioni di idee completamente diverse. Per questo l’ho dipinto di scuro. Spesso queste “cose” coperte di colore sono semplicemente malriuscite, ma non sempre ciò avviene senza una riflessione. A volte i quadri si dipingono da soli. Mi accade di spulciare dopo un anno nell’archivio e rendermi conto che un certo dipinto non vale niente e non mi piace più. Ma non posso lasciarlo così, devo ridipingerlo, ricoprirlo, a volte perfino a più riprese.
MB: In molti ritratti il volto non è definito, ci sono buchi o cancellazioni, macchie…
WS: Perché il volto spesso diventa una caricatura, o tradisce troppo. Hai citato il nominalismo: quei quadri sono ancora nominalisti, voglio che contengano il più possibile, creare una sorta di simbolo. Oggi, dipingere quella cornacchia è stato come dipingere tutte le cornacchie del mondo. Ecco perché a volte ricopro i volti, perché voglio creare un modello, voglio dipingere su quel volto tutti i volti del mondo.
MB: I tuoi dipinti ci ricordano che stiamo guardando dei quadri dopotutto…
WS: Una volta non avrei voluto sentire una cosa del genere, ma adesso non mi disturba, forse consiste in questo la liberazione dal guscio (l’Accademia) di cui parlavo.
MB: Non molto tempo fa, in una conversazione telefonica, hai detto: “È tanto che non dipingo un quadro”. Non potevi dipingere perché stavi girando un film. Ho percepito un leggero rimorso di coscienza e ho pensato che ti senti, nonostante tutto, più un pittore.
WS: Sì, me ne rendo conto ora. Quando non faccio film non provo rimorsi di coscienza come quando non dipingo. Dipingere è semplicemente qualcosa di ordinario.