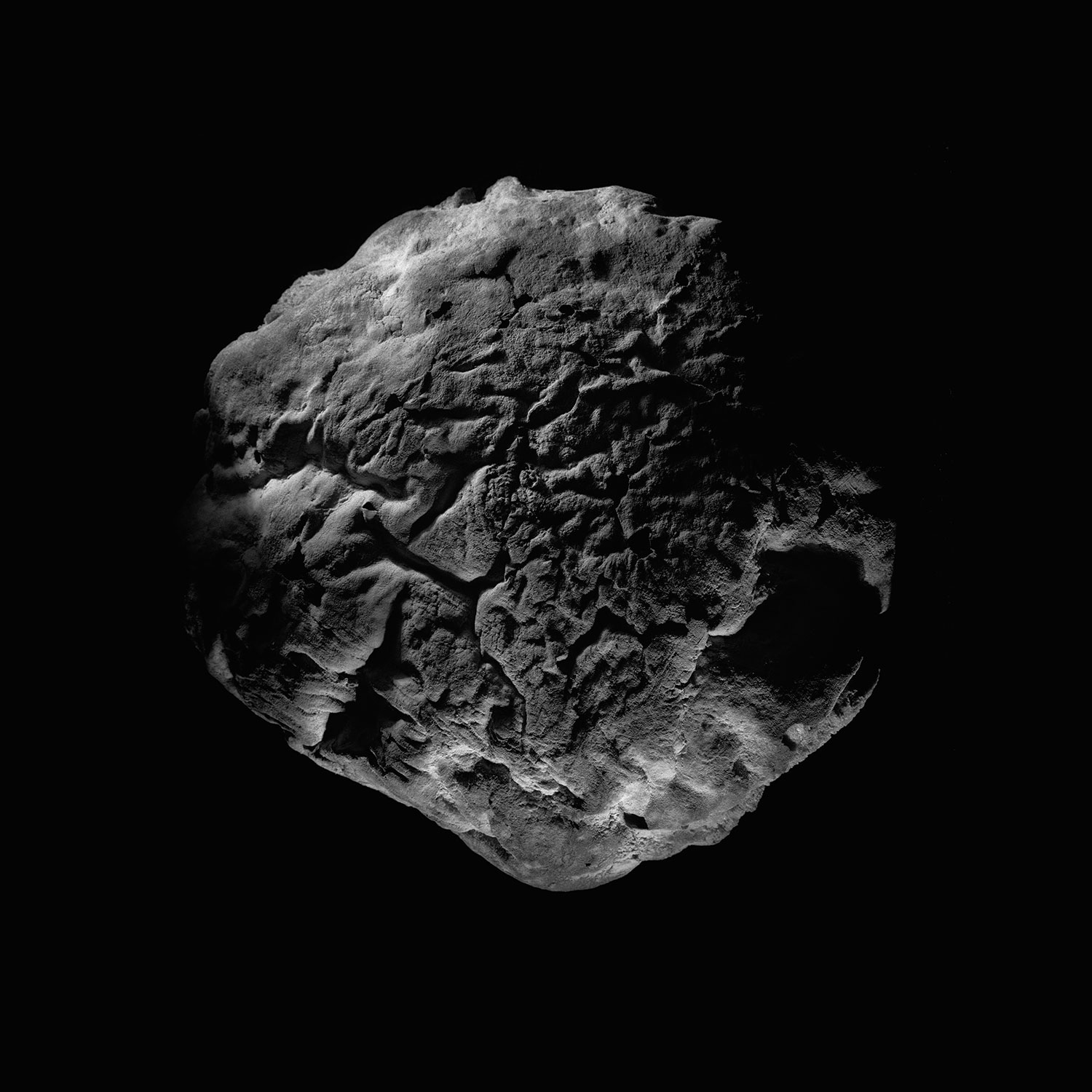Andrea Bellini: Alfredo, tu sei un artista precoce, in qualche modo il tuo ingresso nell’arte lo hai fatto quando avevi 12 anni. Sono curioso di sapere che tipo di bambino sei stato…
Alfredo Aceto: Ricordo pomeriggi di sole a Torino che si trasformavano sempre in questi paesaggi desertici, fumanti, schiaccianti e opprimenti. Mattinate d’inverno a Losanna in cui mi sentivo l’unico rimasto a Pripyat un anno dopo l’esplosione nucleare. Autostrade sulle quali si affacciano gigantesche case popolari abbandonate alternate a giganteschi monumenti. Creavo a voce alta questi scenari ossessivi e speravo, per pudore, che nessuno potesse leggere nei miei pensieri.
AB: Per pudore?
AA: Il pudore è sempre stato un motore di frustrazione costruttiva perché è nel combatterlo che mi sembra di creare qualcosa. Da ragazzino mi attirava perdermi in quella nevrosi che ancora oggi cerca di intrappolarmi quando meno me l’aspetto. Spesso ho cercato di nascondere il mio modo di essere dietro a un aspetto “normale”, anche nel vestirmi, esattamente come tutti gli altri. Un golf blu e una camicia bianca per passare inosservato e per continuare a perdermi laggiù in quei mondi fatti di sottoscala e di rovine.
AB: A proposito di rovine, qualche giorno fa mi hai detto che fare mostre ti sembra un’attività perversa. Come mai?
AA: Primo perché nella maggior parte dei casi manca effettivamente un vero pubblico: la mostra viene prodotta dal mondo dell’arte per il mondo dell’arte. Secondo perché spesso le mostre non scaturiscono da necessità psicofisiche dell’artista ma da motivi sociali e di branco…
AB: Diciamo che le mostre “scaturiscono” per i motivi più diversi, ma torniamo a te: avevi 12 anni quando hai scoperto Sophie Calle, giusto?
AA: Sì, guardando un documentario in TV.
AB: Questa tua storia con la Calle l’ho sempre trovata interessante e indicativa: un bambino di 12 anni che sviluppa una sorta di ossessione per un’artista contemporaneo, e in particolare proprio per Sophie Calle, dopo averla vista in televisione. A dirti il vero trovo questa storia interessante perché fa di te un sommo caso patologico (ride), e a me interessa molto il patologico. Cosa ti ha colpito del suo lavoro e della sua storia? Ti ricordi quel documentario?
AA: Non si intuiva nemmeno fosse un’artista ma ne rimasi comunque folgorato. L’ossessione nei suoi confronti prendeva piede e le sue caratteristiche mutavano nella mia mente trasformandola da donna a figura pressoché mitologica. In quel periodo così come oggi ero molto attratto dai luoghi deserti, dalle città abbandonate dove il passato si mescola al presente. Sophie la immaginavo scolpita in un monumento in mezzo alla foresta rossa, la “costruivo” facendo ricerche su di lei con la stessa metodologia con cui costruivo — dipingendola — la città di Pripyat. Io faccio parte di una generazione a cui i Maestri sono mancati e quindi bisognava inventarseli da sé. Trovo intrigante il rapporto che lega ciascuno di noi con il proprio passato e con i diversi passaggi generazionali, ma la cosa che più mi interessa è trovare la modalità per sovvertire tutto questo. Spesso faccio scelte che mi permettono di giocare, invertire e rovesciare l’ordine degli eventi nel tempo interrompendo la cronologia delle “fasi della vita”. È un modo per continuare a essere consapevoli in un mondo dove i limiti sono sempre più confusi e dove i bambini diventano subito adulti mentre gli adulti rimangano sempre più a lungo bambini.
AB: E poi sei riuscito a incontrarla Sophie Calle. Cosa ricordi del vostro incontro? Come è andata la storia dei due tatuaggi?
AA: A luglio ero seduto sotto un albero nella casa di Moncalieri. Chiamo Sophie per l’ennesima volta ma con più motivazione. Le chiedo un appuntamento preciso e me lo fissa sei mesi dopo dandomi già l’orario. Ero già passato davanti a casa sua in perlustrazione e l’architettura di quel palazzo diventava mistica per me. Dal satellite vedevo che c’era un grande prato dentro mentre dalla strada si vedeva solo una grande facciata di un’industria riconvertita. Mille volte ho immaginato e scritto su cosa potesse esserci dentro, quindi la cosa che ricordo di più è la scoperta del luogo. I tatuaggi… volevo un pezzo di lei che mi servisse a crescere come quella pianticella che da bambino avevo legato a dei bastoni in legno dopo che qualcuno l’aveva calpestata. Il secondo tatuaggio è la scritta “c’est fini”. Da quel giorno è come se avessi tagliato i laccetti che mi tenevano legato al pezzo di legno.
AB: Come ti sei liberato alla fine dal demone della Calle? È bastato il tatuaggio?
AA: È andata a finire che sono fuggito in Alaska da Paola Pivi per dimenticarmi di Sophie. Me lo aveva suggerito uno psicologo, quasi come battuta. Questa storia è molto ancorata alla realtà e alla vita, non c’è finzione. Ma il modo di vivere quel periodo mi ha portato in qualche modo a voler trasformare ciò che ho davanti ai miei occhi in qualcosa a più alto contenuto emotivo. Mi piace pensare che il mio lavoro possa essere una forma di lente di ingrandimento per vedere da vicino il tessuto umano e ossessivo delle persone quasi si trattasse di anatomia.

AB: Stavo pensando che il tuo accesso nel mondo dell’arte avviene attraverso l’infatuazione che hai avuto per delle persone “famose”, per quanto possa essere famoso un artista contemporaneo. Cerchi il successo nell’arte? Qual è la forza che ti muove?
AA: Per me successo e arte sono legati come responsabilità e potere. La responsabilità senza il potere che ne consegue crea un problema, così come il successo di un artista senza l’autenticità dell’arte crea un problema. Io vedo nel successo un’opportunità come un’altra per poter condividere delle urgenze con più persone. Ciò che penso sia grave e malato è cercare il successo anziché cercare l’arte.
AB: Una volta mi hai detto che pensi che la tua sia l’ultima generazione ad aver conosciuto la malinconia. Come mai? Quale potrebbe essere un ipotetico vostro obbiettivo generazionale?
AA: Le mostre mi sembrano dei mondi che si definiscono tramite sparizioni e apparizioni quasi fantasmagoriche. Ma non penso si tratti di fantasmi legati unicamente al racconto bensì alla diversa temporalità che si è creata tra realtà e finzione tramite il virtuale. Questo fosso che separa il mondo dalla sua immagine mutevole e arbitraria è probabilmente la molla che mi spinge ad andare avanti. Un obbiettivo che la mia generazione potrebbe porsi, potrebbe essere la testimonianza delle informazioni che andranno perdute in questa fase di transizione. Il ricordo della perdita piuttosto che il tentativo di ricordare.
AB: Parlami invece del fumetto dedicato a Paola Pivi…
AA: Non si tratta di un fumetto dedicato a Paola Pivi, ma della storia di due anni della mia vita. Quando sono tornato da Anchorage mi ha chiamato Milovan Farronato da Via Farini chiedendomi di andare a trovarlo. Mi dà appuntamento e mi dice che sarà presente anche un certo Roberto di cui non mi rivela il cognome ma del quale mi sorprende subito l’intelligenza corrosiva. Mi suggerisce di fare un lavoro sul modo in cui ho vissuto il rapporto con Sophie Calle e con Paola Pivi. Così accetto e decido di farne un fumetto.
AB: Roberto Cuoghi, l’ho incontrato proprio ieri a Milano, che coincidenza… Cosa hai imparato da lui?
AA: Ho imparato a separare momenti di grande libertà e spontaneità da momenti di rigore in cui analizzi le ferite che ti ha lasciato l’esperienza.
AB: Anche i monumenti agli scrittori scomparsi degli anni Novanta sono un omaggio…
AA: Certamente ironico, ma c’è anche della vera e sana malinconia.
AB: Ancora la malinconia…
AA: Sempre la malinconia! Ogni tanto prendo la macchina e vado fino a Losanna per fumare una sigaretta sull’uscio della prima casa che ho avuto in Svizzera.
AB: Cosa ti fa paura?
AA: Non essere preso sul serio.
AB: E cosa ti dà gioia?
AA: Non prendere nulla troppo sul serio.
AB: Quindi tu non credi a niente?
AA: Nella casa di Moncalieri ci sono due tuje gigantesche una attaccata all’altra. Subito sotto c’è un tavolo di marmo su cui mia nonna leggeva il giornale con noi nipoti. Ogni tanto pronunciava qualche frase dalla valenza assoluta. Per lei erano tutte verità inconfutabili! Da lì ho smesso di credere.