
Adelaide Cioni (Bologna, 1976) ha studiato disegno a UCLA, Los Angeles e scultura all’Accademia di Belle Arti di Roma. Per dieci anni ha tradotto letteratura americana, nel 2012, terminata la traduzione dei diari di John Cheever, ha deciso di smettere di tradurre per dedicarsi alla pratica artistica. Vive in Umbria dove, insieme a Fabio Giorgi Alberti, ha aperto Franca, uno studio che a cadenza più o meno regolare ospita mostre e progetti di altri artisti e curatori. Questa che segue è parte di una conversazione che prosegue senza interruzioni da un paio di anni, fra l’artista e Cecilia Canziani che si è andata addensando in occasione della doppia personale “Shape, color, taste, sound and smell” negli spazi di p420 a Bologna.
Adelaide Cioni: Tiziano ha detto che basterebbero il nero, il rosso e il bianco per fare un capolavoro. Ci puoi fare il buio e la luce, il sangue e la pelle. Sono anche i colori di molti tappeti dei nativi americani. Poi c’è il giallo che è dei fiori e del sole, che nel mio immaginario ha a che vedere con la gloria. Il blu arriva perché ci sono il cielo e il mare, quindi in un certo senso non “arriva”, è già lì – già anelito in forma di colore, perché il mare e il cielo sono le due dimensioni alle quali non possiamo accedere.
Cecilia Canziani: Anche tu mostri parsimonia nell’uso dei colori: ne usi uno alla volta, raramente due insieme. Delimiti una forma su una campitura neutra, che è lo spazio dell’immagine, a partire da un contorno che riempi con un colore pieno, puro, seducente. Usi il colore così come esce dal tubetto, è quindi una questione di scelta e non di processo – non cerchi il colore mescolandolo, lo trovi prima, e quando lo trovi, lo usi. Per quanto ho visto è una specie di innamoramento, e anche una dichiarazione – un po’ come quando Virgina Woolf scrive “possiedo la mia anima”. Le forme in cui il colore prende corpo sono sagome di animali, gelati, scacchiere, onde e così quello che si legge della figura non è il soggetto, che ne è solo il veicolo, ma il colore, e la sua seduzione. A me queste campiture piene, di colore-colore, totalmente saturo, fanno sempre pensare all’affresco, mi vengono in mente i blu di Giotto, i rosa e i celesti di Piero Della Francesca, di Fra Angelico – ne abbiamo parlato spesso.

AC: L’avvicinamento al colore è stato un passaggio lento. Per anni ho lavorato con il disegno puro, segno nero su fondo chiaro. Non mi azzardavo a toccare il colore. È un elemento talmente forte, non lo usavo, però lo guardavo. Quello che sentivo più vicino a come avrei voluto usarlo erano gli sfondi monocromi verdi e blu dei ritratti del Cinquecento fiammingo e tedesco, penso a Holbein e Cranach, ma anche degli affreschi, come hai ricordato tu, di Giotto, di Cimabue. Mi sembrava che il colore in quanto elemento vivo trovasse così massimo valore, senza dover descrivere o dire nulla, una presenza e nient’altro. In effetti la prima serie con la stoffa, Go Easy on Me (2017-2019), quella dei ghiaccioli, è nata proprio da un desiderio di non-senso. Era un periodo in cui mi sentivo spinta da più fronti a produrre lavori rigorosi, con un’idea forte, così la mia mente ha deciso di scartare e lanciarsi su un’immagine innocua, di puro piacere: un ghiacciolo. Un mio inno alla leggerezza. Ho incontrato per primo il rosa; ci siamo guardati, era un colore assurdo, il colore della nudità, persino goffo in un certo senso ci siamo riconosciuti immediatamente. Era accompagnato da un verde marino e da un azzurro. Sono venuti via con me. A dire il vero il primo avvicinamento al colore è stato nel 2014, quando vivevo a Parigi, alla Citè internationale des arts. Anche lì era un colore già dato, un incontro. Un giorno ero nella biblioteca Forney, senza sapere perché mi infilo all’ultimo piano, nella sala audiovisivi. Mi metto a spulciare tra i faldoni di diapositive e ne tiro fuori uno sulla pittura italiana del Cinquecento: era pieno di diapositive di opere, a centinaia. Sfogliando mi cade l’occhio su un profilo minuscolo e di colpo lo riconosco (un riconoscimento violento!) era un dettaglio dell’Assunta di Tiziano alla Basilica dei Frari a Venezia. Il busto di lei, con il braccio alzato, lo sguardo in su, i capelli scuri, il vestito rosso. Me l’ero dimenticata, mi ero proprio dimenticata che quel dipinto esistesse. E adesso la ritrovavo. Una magia, una cosa forte. Tanto più che la ritrovavo all’estero, da lontano. Da lì è nato un lavoro che si chiamava appunto Dimenticare Tiziano / Ritrovare Tiziano (2014) e che ruotava tutto attorno ai quadri che vediamo in riproduzione quando siamo piccoli a casa (magari è un poster in bagno, o una cartolina in cucina, ognuno ha le sue: io a casa avevo la Venere di Urbino di Tiziano, il particolare del viso della Madonna della Pala di Castelfranco di Giorgione e la Lezione di anatomia del dottor Tulp di Rembrandt). Poi crescendo uno se le dimentica, ma può capitare di rivederle e il riconoscimento è potente. L’idea era che l’Assunta dei Frari sia un’immagine fondativa che accomuna la memoria conscia o inconscia di tutti gli artisti italiani contemporanei. A partire da Kounellis che da greco decide di diventare italiano anche a causa di quel dipinto.
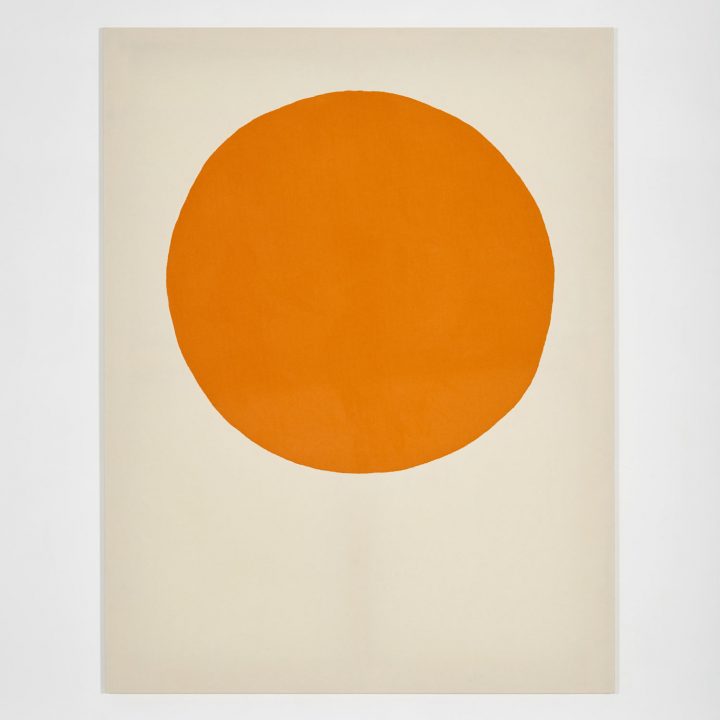
CC: Vorrei tornare a una cosa che hai detto prima parlando dei colori di Tiziano. Hai detto che sono anche quelli dei tappeti dei nativi americani. L’altro giorno mentre parlavamo al telefono hai tirato fuori Agnes Martin, e per me queste due cose sono in una qualche relazione che non riesco a mettere bene a fuoco, ma che ha a che fare con il paesaggio – largo, piano, sconfinato – con la luce, con una forma di libertà anche. C’è un’intervista video di Chuck Smith del 1997 con Agnes Martin in cui lei parla di come si forma un’immagine, dello stare con quell’immagine, del dover avere pace, solitudine e una stanza con una sedia perché quell’immagine affiori. Poi la disegna, poi la dipinge – in scala. Bene, quando hai detto ‘Agnes Martin’ mi è sembrato logico, e mi sono chiesta: come mai non ci avevo pensato?
AC: Agnes Martin fa questa cosa di uscire dal senso. Uscire dal senso verbale e andare nella geometria, che poi è quello che succede nei tappeti Navajo, e in vari motivi decorativi di tante culture. È un’altra via per accedere all’anima ed è una via che mi interessa enormemente. Ha a che fare con il paesaggio, forse perché il paesaggio incarna la possibilità dell’essere sconfinato in qualcosa di fisico come la conformazione del terreno e dei monti o delle pianure. Non per niente con la geometria si è studiato l’universo prima della fisica. È il rapporto con l’infinita misura. Quando pensi all’universo… pensi, ok noi siamo sulla Terra, che sta nel sistema solare, il sistema solare sta nella via Lattea che è la nostra galassia, tutto attorno ci sono altre galassie, e oltre quelle? Cosa c’è oltre? Dove finisce lo spazio? Dove poggia tutto questo? È veramente una vertigine l’idea dell’infinito. E penso che questa vertigine noi la affrontiamo nella geometria e nei “pattern” dei motivi decorativi, c’è un po’ di questo già in diversi pezzi della serie Secondary Images (2019): penso al Mare, alla Scacchiera, anche ai Buchi neri. E io, se adesso dovessi pensare di lavorare su qualcosa penserei soltanto a un motivo decorativo. Mi muovo sempre per riconoscimento, incontro un motivo che mi colpisce profondamente, per esempio in questo periodo sono avvinta dal motivo a strisce rosse e bianche che Buren ha reso suo ma che esiste da migliaia di anni e ricorre, nelle tombe etrusche, nei quadri medievali. Lo vado cercando e ci lavoro.

CC: Agnes Martin ha detto una cosa bellissima: “alla musica chiediamo di emozionarci, ma dall’arte vogliamo spiegazioni”. Le sue griglie prima e le righe pallidissime dei suoi ultimi quadri sono stati d’animo. La tua Colonna (2019) gialla è un incontro, un grido, una forma felice. Il Sole (2019) è un sole, di un preciso colore, di una specifica grandezza e ci investe di luce. I pattern a cui guardi ora sono modi di rappresentare quello che non sappiamo misurare. Su queste presenze che occupano i margini di un quadro e chiamiamo decorazione, lo sguardo, dice Didi-Hubermann, si chiude. Sono spesso tanto semplici quanto inattese, sono “figure del dissimile”: immagini astratte investite dalla potenza pura del significato. In un certo senso i lavori degli ultimi anni hanno un funzionamento simile: gli animali o i gelati, sono soggetti che riconosciamo senza rivestirli di senso, né letterale, né metaforico, ma nemmeno figurale. Per questo ci investono, perché le riconosciamo istintivamente. La serie a cui stai lavorando ora è più precisa ancora. Tu le chiami Secondary images: sono scacchi, onde, buchi neri, soli. A me hanno fatto venire in mente le immagini che Aby Warburg chiama Nachleben: sopravvivenze, però non si tratta solamente di immagini archetipiche, ma anche – come mi hai ricordato – di immagini secondarie, che non sono mai il soggetto del quadro. Sono sullo sfondo, ma sono lì. E hanno uno strano potere sulla nostra memoria.
AC: Warburg è un riferimento puntuale. Al contrario dei Pathosformel però le immagini che cerco sono del tutto a-patetiche, se si può dire. Nella tavola no. 32 del Bilderatlas Mnemosyne comunque c’è una scacchiera rossa. Anche da lì è venuta quella. Mi sono appoggiata a lui anche per la ricerca sulle carte da gioco che porto ancora avanti. Diciamo che mi interessa il riconoscimento, quel moto della memoria che presuppone che uno abbia dimenticato per un po’. Perché per riconoscere una cosa devi averla almeno in parte dimenticata. La memoria ha un funzionamento singolare, perché sembra una cosa incorporea ma si accende e si spegne secondo un criterio di economia degli spazi, un criterio che solitamente si riferisce ai corpi. Non possiamo ricordare in una volta sola tutto quello che abbiamo introiettato nella nostra vita. Questo deve significare che la memoria ha una conformazione di tipo spaziale, ovvero con dei limiti di capienza. No, ho detto male, i limiti di capienza non li ha la memoria in sé, li ha il palcoscenico su cui sfilano le cose che stiamo ricordando in un dato istante. Quello sì è limitato. Perché è limitato il vedere, e la memoria è fatta di immagini che per tornare alla coscienza devono passare attraverso un filtro sensoriale che in questo caso è relativo alla vista ovvero agli occhi, a qualcosa di eminentemente fisico (può essere anche papillare, olfattivo, ecc). La memoria quindi vive sul filo che separa il fisico dall’immateriale. E non è estranea a nessuno dei due. Poiché se ha dei limiti allora ha un corpo. Così il riconoscimento ci fa sentire quel limine su cui viviamo e per di più ci fa sentire un’identità con esso. Come il segno.

CC: Questo limite di cui parli è evidente nel modo in cui tu componi le immagini: c’è il colore e c’è la linea di contorno che lo contiene. C’è quindi il disegno – che è la radice del tuo lavoro – e c’è la forbice, che similmente ritaglia o delimita una forma. E quando hai iniziato a usare la stoffa nella stessa maniera in cui usi il colore, cioè come colore dato, che scegli quando lo incontri, il dato tattile – corporeo – del tuo lavoro ha preso ancora più rilievo. Una stoffa può essere ruvida, soffice, liscia, setosa. Sono qualità che riconosciamo con la vista e poi con il tatto (mi piace molto che si usi l’espressione ‘la mano del tessuto’ per indicarne le specificità), e rimandano a sensazioni. E le grandi dimensioni dei tuoi dipinti di stoffa chiedono a loro volta un rapporto corporeo con lo spettatore: sono io davanti a una forma-colore. Un ingombro davanti a un ingombro.
AC: Sì, il corpo è fondamentale. Le parole e le spiegazioni vengono dopo. La cosa che non sapevo del tessuto di lana e che ho scoperto poi lavorandoci è che assorbe la luce, per cui il colore ritorna purissimo agli occhi, non si disperde, arriva più intenso. Anni fa mi trovavo in un museo, non ricordo quale e neppure in quale paese, se era la Germania o la Svizzera, e a un tratto nella sala dov’ero io, un uomo un po’ strano si è messo a ululare davanti a un quadro. Letteralmente ululare. Era un quadro di Cy Twombly, forse la Vendetta di Achille, un triangolo con la punta rossa rivolta verso l’alto. Era fortissimo. E ho pensato: ecco, questa è la reazione che vorrei provocare in chi guarda un mio quadro.




