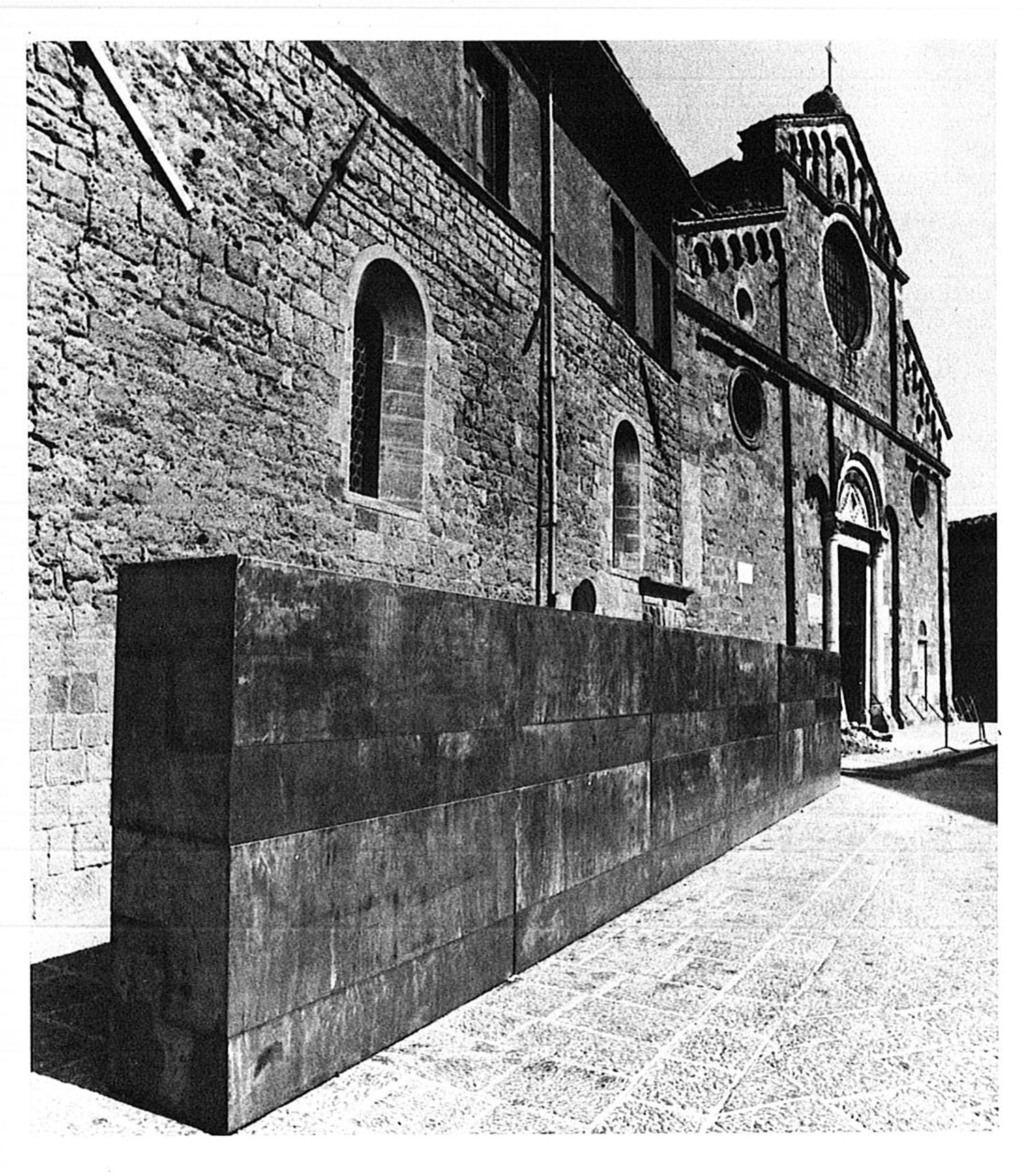Paola Nicolin: Come hai costruito il percorso della mostra in corso alla Galleria Civica di Modena e quali criteri di scelta hai adottato insieme ai curatori?
Adelita Husni-Bey: La prima immagine a venirmi in mente pensando a questa mostra è stata una “visuale dall’alto”, una sorta di mappa estesa che potesse connettere vari aspetti del lavoro svolto negli ultimi dieci anni. Mi è venuto in mente anche un passaggio di un bellissimo libro di Michael Taussig, My Cocaine Museum, dove viene descritto il tragico arrivo di Hernán Cortés in Colombia, a bordo di barche che mapparono i territori attraverso il Rio Timbiquí. Presto gli acquarellisti di corte si ammalarono e in sostituzione Cortes impiegò delle persone del posto. Alcune di queste primissime mappe sono quindi caratterizzate da molteplici tipi di veduta, poiché i nativi non conoscevano le tecniche della vista dall’alto e gli acquarellisti di corte non conoscevano i territori. Mi ha sempre affascinato questo passaggio, la molteplicità di visioni legata alla formazione socio-politica dei soggetti che osservano. Ho cercato di produrre dei percorsi interpretabili, con alcuni punti fermi, un paio di fil rouge. Nella sala centrale abbiamo posto il mio “primo” lavoro, Postcards from the Desert Island (2011) e il mio lavoro più recente, The Council (2017). Partendo da questa sala centrale si può percorrere l’ala sinistra della ¹ Palazzina, che raccoglie opere legate all’abilità / debilità, oppure visitare l’ala destra, che ha come fulcro la nozione di potere e la sua distribuzione, la legge e l’imperialismo.
Proviamo a figurarci un ipotetico lemmario, composto da un insieme di voci che possano iniziare a tracciare una lettura trasversale del tuo lavoro. Per esempio, “cura”: quanto è rilevante il tema della cura nella tua ricerca?
Per me il concetto di cura è un atto di riconoscimento della dipendenza che ci lega. Un testo che amo e che cito spesso è The Ethics of Care, Dependence and Disability di Eva Feder Kittay¹, in cui si descrive il nostro corpo come solo “temporaneamente abile”; accettando e convivendo con quest’abilità temporanea, riconosciamo anche la dipendenza che è parte naturale della vita corporea. Da bambini, ad esempio, abbiamo bisogno di aiuto per essere autonomi, per sopravvivere; così come, molto spesso, anche da anziani. In mezzo può capitarci di ammalarci, di romperci una gamba, di soffrire di depressione. Ecco cosa vuol dire l’abilità temporanea: riconoscere e accettare come la debilità sia una parte imprescindibile e profonda del nostro percorso. L’unica cosa che rende orrenda la debilità è la sua percezione sociale, lo stigma che l’accompagna, perché ci fa rallentare, fa rallentare quelli che ci circondano, e il rallentare è inconcepibile nel capitalismo. Visto che essere disabili o debilitati è un’offesa al mantra capitalista viviamo in una società che ci fa provare pena per le persone debilitate, che le isola e rende la vita difficile a chi decide di stargli vicino. Forse la vera rivoluzione parte da lì, dalla debilità, il suo riconoscimento e l’amore verso le nostre debilità attuali, passate o future. La trasfigurazione di questo amore per noi stessi, per il nostro corpo e per il corpo degli altri, è il riconoscere quanto sia importante andare piano. La debilità che, infine, tocca a tutti è la morte. Partendo da questi pensieri ho sviluppato alcuni dei lavori in mostra come Shower (2013), realizzato in collaborazione con l’artista Park McArthur, oppure After the Finish Line (2015), coinvolgendo dei giovani atleti di San Francisco. In Shower ci si può sedere su degli sgabelli in plastica, normalmente utilizzati per lavarsi in periodi di debilità, e leggere un dialogo tra me e Park dove sono impartite istruzioni su come ci si può aiutare vicendevolmente a fare la doccia, come se una di noi due non fosse in grado di farla autonomamente. In After the Finish Line, invece, ho coinvolto un gruppo di atleti prendendo contatti col dipartimento di rieducazione fisica dell’Oakland Children’s Hospital e cercando con loro la radice del desiderio di competizione. Sempre in mostra, nella stessa ala dell’edificio, si trova Incontri sul dolore (2018), una serie di sagome su carta medica su cui ho annotato i pensieri di singoli individui con cui ho avuto una breve sessione privata, durante la quale li ho accompagnati attraverso un’analisi socio-politica del proprio dolore fisico. Alcune di queste idee le ho prese in prestito dai cosiddetti “Crip Studies”, ovvero studi dell’identità della debilità. Di lavori svolti che trattano il tema della cura, ma che non sono in mostra, c’è anche la cura strumentalizzata che è quella dell’accoglienza, esplorata in On Exile al Museo del Novecento di Milano; oppure la cura che si fa per lavoro, che sto cercando di rappresentare in un libro per bambini commissionato dalle Serpentine Galleries, sui tagli ai centri per l’infanzia. Un libro nato da un progetto iniziato nel 2014, scritto coralmente, attraverso esercizi teatrali con le madri e le impiegate del Portman Early Childhood Center di Londra.
“Istituzione”. Che cos’è un’istituzione e come nel tuo lavoro si trasforma?
L’istituzione etimologicamente è il luogo dove si istituisce la norma; mi interessa particolarmente lavorare nelle istituzioni e con le istituzioni, mettendo in atto dei processi di de-normativizzazione. L’istituzione è il contenitore che fornisce spazio, visibilità e fondi, ma i laboratori che solitamente propongo sono come un piccolo ospite che cerca di mettere in questione il gigante. Può essere anche che venga fagocitato, ma intanto ha piantato un piccolo seme critico all’interno della macchina. Ad esempio, per il mio ultimo lavoro, The Council (2018) commissionato dal MoMA di New York (l’istituzione artistica per antonomasia), ho deciso di fare proprio questo: ho lavorato con il dipartimento educativo del museo proponendo ai partecipanti di immaginare il MoMA del futuro, dopo un evento che ipoteticamente ha spogliato il museo della sua funzione originaria. Nel re-immaginare il museo come luogo di cura, come piantagione di marjuana, come comune governata da un’intelligenza artificiale moralmente superiore, è inevitabilmente emersa la domanda: cos’è il museo adesso? Perché ha queste specifiche forma e funzione? Cosa potrebbe essere invece? Tutti gli scenari sono stati sviluppati unicamente dai ragazzi, seguendo un protocollo di esercizi teatrali che li ha aiutati a costruire identità distinte, messe a confronto nella giornata finale che ha visto “il consiglio” riunirsi. In un’altra opera in mostra, Agency (2014), girata all’interno del MAXXI di Roma, il laboratorio verteva invece sull’analisi dei rapporti di potere tra classi sociali e professioni predeterminate. In Agency l’istituzione era quella che veniva stabilita dai rapporti tra i gruppi di studenti che hanno rappresentato politici, banchieri, lavoratori, attivisti e giornalisti, nel gioco di ruolo che ho loro proposto. L’istituzione non è impenetrabile, statica, ma fatta di persone e di norme costantemente in evoluzione e plasmate dai rapporti di potere insiti in quel momento storico.
“Forma vs formalizzazione”: la tua formazione, tra studi sociali, architettura e arti visive si intreccia a un talento nel disegno che è un dono, prima di tutto, e uno strumento di verbalizzazione visiva. A tutto questo si è affiancata una attitudine verso il film, il documentario e l’immagine che ne deriva, come formalizzazione di un discorso in evoluzione. Come trovi la sintesi formale in questa complessità?
Tra le opere d’arte che amo di più ci sono The Last Silent Movie (2007) di Susan Hiller e Bliz-aard Ball Sale (1983) di David Hammons; ma anche la serie di sculture di Jesse Darling che trattano di debilità mostrate nella sua personale “Support Level” a Chapter NY; o il dipinto Painted Representation of Arlo di Hamishi Farah, che ritrae il figlio di Dana Schutz, “rea” di aver dipinto Emmett Till – il giovane afro-americano linciato nel 1955 per essersi relazionato con una donna bianca. In tutte queste opere percepisco una profondità concettuale e una formalizzazione che riesce a trasmettere questa profondità, ma lasciando comunque uno spazio interpretativo. Personalmente so essere molto impulsiva nelle scelte che riguardano l’immagine o l’estetica: quando penso a un concetto lo vedo già svolgersi rispondendo a un’estetica intima, pubblicitaria, o popolare. Le immagini traboccano da un luogo che non conosco, ma poi mi fermo e mi chiedo se sia la strada giusta, o una delle strade giuste, per dire quello che vorrei dire; se quel tipo di estetica rispetta i punti cardine del lavoro. Quando si tratta di un’opera che parte da un laboratorio cerco di parlare delle mie intenzioni rappresentative all’inizio, ma solitamente quelle vengono completamente stravolte dal processo, e di nuovo nella fase di editing.
“Corpo vs percezione”. C’è molta tensione in ogni tuo lavoro. Una tensione corporea, fisica che restituisce la necessità di relazionare un corpo individuale (l’artista) con un corpo collettivo (il pubblico). All’origine di questa tensione sembra esserci una percezione del mondo alla quale sei arriva facendo esercizio “fisico”. Ci sono delle figure a cui fai riferimento e che ti aiutano a sciogliere questa tensione tra chi fa e chi riceve e, allo stesso tempo, partecipa a questa tensione?
Forse la miglior “palestra” è stata quella di famigliarizzare con diversi modi di insegnare / imparare. Ricordo un passaggio di The Modern School, un libro scritto da Francesc Ferrer i Guàrdia per spiegare le origini del suo pensiero pedagogico. In uno dei primi capitoli Ferrer descrive quando era un insegnante di biologia e descrive una lezione in una scuola pubblica. Mentre insegnava come venivano impollinati i fiori si era reso conto – e qui sto parafrasando quindi spero di non sbagliare – che il ticchettio che lo disturbava erano proprio le api che sbattevano contro i vetri della classe. Fu in quel momento che capì la necessità di un approccio diverso e iniziò a portare i bambini all’esterno perché potessero toccare con mano i fiori che stavano studiando. Gli aspetti tattili, fisici e la pedagogia, come l’esercizio teatrale, sono modi di ricollegare i corpi. Sicuramente non ci sono maestri, ma persone che possono aiutarci a “vivere” – e la vivibilità potrebbe essere la nostra più grande aspirazione.
“Motivazione.” Qual è la maggiore motivazione che ti spinge dopo dieci anni a fare questo lavoro?
Essere circondata da persone che fanno un lavoro incredibile come Manuel Arturo Abreu, Hannah Black, Jackie Wang; vedere le lezioni di Fred Moten; frequentare il Poetry Project alla Judson Church, e i luoghi più informali come Macao a Milano, o l’Artists Space e l’Anthology Film Archive a New York. Vivere a pieno l’essere vulnerabili, l’essere in errore, l’imparare. Tutti modi di sentire che permeano la mia esistenza grazie a questa professione, che ci chiede costantemente di osservare (e osservarci). Il fatto che in qualche modo questo lavoro mi dia vivibilità, in tutti i sensi.