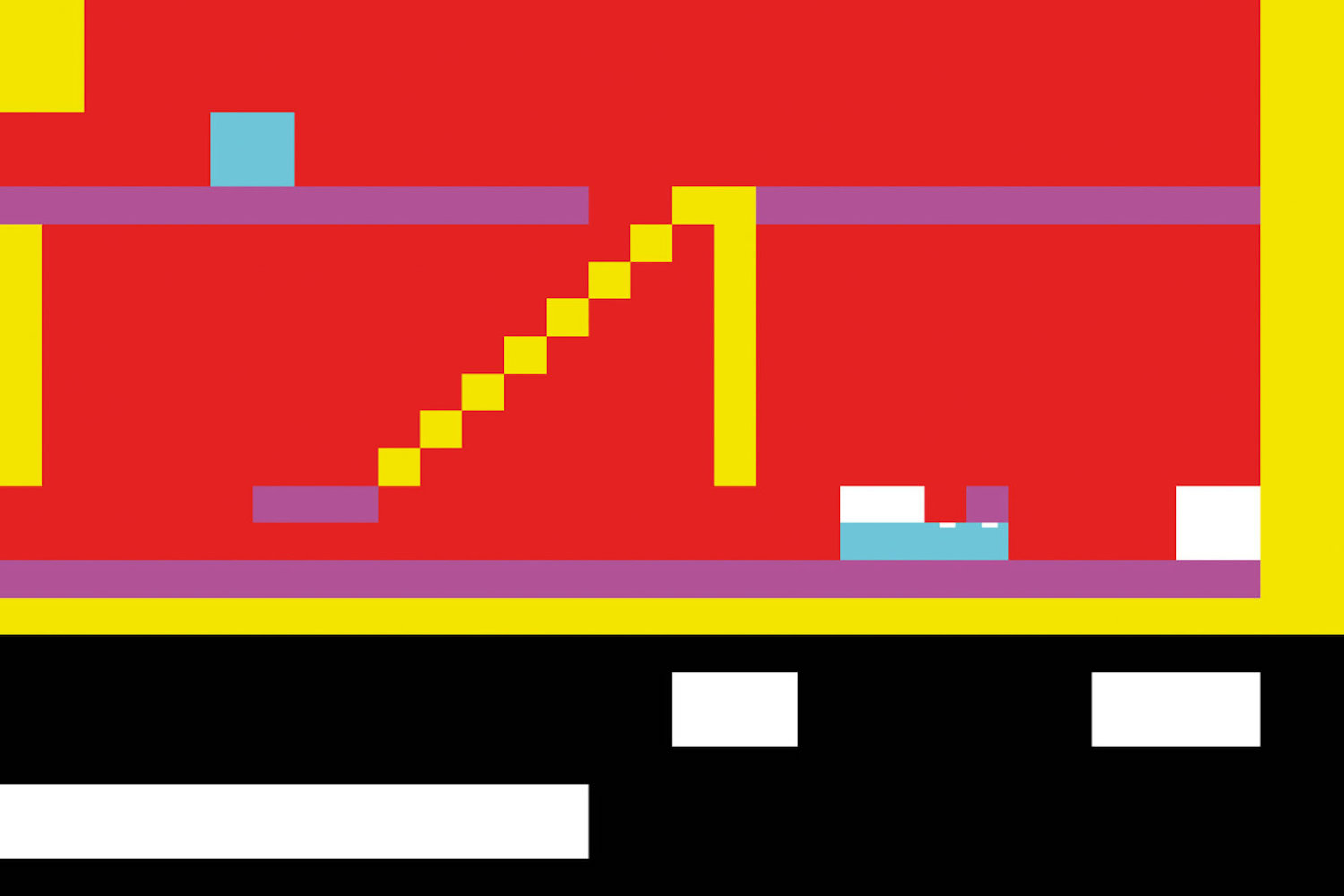Michele Robecchi: L’anno scorso si è svolta a Modena “Raccontare”, una mostra che riassumeva i tuoi primi dieci anni di lavoro. Che cosa racconti?
Adrian Paci: Quella del raccontare è vista come una sorta di vocazione che percorre il mio lavoro, da Albanian Stories a Piktori fino a Klodi. Il carattere narrativo si nota però anche nella pittura, come nella serie su Pasolini o in quella tratta dal matrimonio, che si presentano quasi come uno storyboard al contrario, con il video o il film a generare una narrazione pittorica. Doveva essere una mostra che dimostrasse come la versatilità formale che ha caratterizzato il mio lavoro in questi anni non fosse dovuta a pretese di virtuosismo, quanto alla necessità di uscire da determinati confini per rappresentare un tipo di attenzione, un’atmosfera o un’esperienza. A eccezione della pittura, che ho studiato per anni, con gli altri media mi sento un dilettante. Mi affido più alla forza dello sguardo che a dei trucchi tecnici.
MR: Quando hai presentato Albanian Stories alla Biennale di Venezia nel 1999, ti eri espresso in maniera simile. Avevi dichiarato di aver preso la telecamera in mano per la prima volta, costruendo una sorta di ready made. Questo dilettantismo tecnico contribuisce in modo decisivo alla realizzazione del tuo lavoro?
AP: Non credo nel dilettantismo in quanto forma espressiva autonoma. Avendo studiato per anni pittura, non posso ignorare un aspetto importante come la padronanza della tecnica che si sceglie. Il problema nasce quando questa padronanza si trasforma in abitudine e alla tensione della ricerca subentra il compiacimento. Capire la necessità del mezzo non ha a che fare con l’abilità tecnica, ma con la necessità di rispondere creativamente agli stimoli ricevuti. Per me cambiare modalità di espressione non è mai stata una scelta ideologica e premeditata. Forse ci sarà un momento in cui avvertirò il bisogno di fermarmi ed esplorare altre tecniche, ma per il momento posso dire che il rapporto con il video, per esempio, è servito a liberare la mia pittura da una certa chiusura e da alcuni “pittoricismi”. E allo stesso modo, credo che nei miei video si avverta uno sguardo da pittore.
MR: I tuoi lavori più recenti si discostano da quelli fatti in precedenza. Ha fatto ingresso una struttura cinematografica e teatrale molto più elaborata.
AP: Ci sono lavori che nascono da esperienze dove il tuo ruolo è più passivo, e altri invece dove contribuisci con scelte più determinanti. Albanian Stories non si appoggiava sulla mia creatività o sulle mie abilità cinematografiche. La forza di quel lavoro era nei racconti della bambina, nella sua capacità di stare a cavallo tra gioco e tragedia. Il mio ruolo era quello del testimone, di quello che ha trovato qualcosa e che si è reso conto della sua intensità. In Turn On la costruzione del lavoro parte da me. Il ritmo, i piani e la scenografia sono frutto di una mia scelta. Sono due tipologie di lavori diversi. Non penso però che questo passaggio rappresenti una direzione futura. Infatti dopo PilgrIMAGE ho voluto fare Klodi, dove ancora una volta mi trovo con una videocamera in mano nei panni del testimone di una storia straordinaria.

MR: Il che ci porta a Per Speculum, che è uno dei tuoi lavori più astratti.
AP: Quello che ho volutamente tenuto lontano da Per Speculum sono i riferimenti a un contesto preciso che potesse servire come chiave di interpretazione immediata, una cosa che ha spesso generato una lettura facile e a volte superficiale del mio lavoro.
MR: Hai messo spesso in discussione il ruolo dell’artista nel tuo lavoro. Penso a Piktori, Believe Me I’m an Artist, ma anche a Vajtojca.
AP: Il ruolo dell’artista è un problema che va oltre il mio lavoro. La messa in discussione del prodotto artistico ha messo a sua volta in discussione lo status del suo produttore, e questa è una delle eredità lasciateci dal XX secolo. Il mio approccio è di affrontare questa crisi dall’interno, cercando al tempo stesso delle aperture verso l’esterno. L’artista che esce dal contesto che lo legittima ed è costretto a stabilire un dialogo con un ambiente non necessariamente amichevole mi è sembrato un argomento interessante. Piero Manzoni lasciava le sue impronte consacrando oggetti comuni come opere d’arte. Quando ho lasciato le mie impronte nell’ufficio del commissariato di polizia a Milano per il rinnovo dei miei documenti, ho pensato: “Io non sono Manzoni”. E allora l’ho trasformato in un lavoro.
MR: Sia in Apparizione, che in Back Home e in PilgrIMAGE metti in scena delle riunioni virtuali. In PilgrIMAGE però tocchi anche un argomento spinoso come il legittimo possesso dell’opera d’arte e le conseguenze di anni di politica coloniale. È un aspetto che hai considerato consapevolmente?
AP: La leggenda sull’immagine della Madonna del Buon Consiglio rapita dagli angeli e portata nella Cappella di Genazzano è del XV secolo, non ha legami con la politica coloniale di cui parli. Più che fare un discorso sul diritto di chi deve possedere l’opera d’arte, volevo indagare la possibilità di realizzare uno scambio sia reale che virtuale. Mi interessava il desiderio nei confronti di un’immagine e la distanza che aumenta questo desiderio. C’è dunque la presenza sacra, ma anche una certa profanazione del sacro. Le immagini della gente di Scutari proiettate nella Cappella di Genazzano di fronte all’altare acquistano un’aurea di sacralità. Desideravo che tutto questo succedesse davvero, che avesse la forma di un rituale, ma che poi diventasse anche un video, in modo da avere più punti di vista; non c’è solo la folla che guarda l’immagine, e non c’è solo l’immagine che guarda la folla proiettata nella cappella, ma anche il fruitore del video, che diventa testimone di questo passaggio.

MR: La Madonna del Buon Consiglio, la lettera di San Paolo ai Corinzi in Per Speculum, il rito funebre di Vajtojca… Cosa ti attrae del rito religioso?
AP: A scuola appartenevo a quel gruppo di studenti che credeva che per essere un bravo artista bisognasse conoscere la Storia dell’Arte. E se studi la Storia dell’Arte capisci che i primi disegni fatti dall’uomo anticipavano un rito, quello dell’uccisione dell’immagine dell’animale prima di affrontarlo realmente nella caccia. Il rapporto che ha avuto l’arte con la necessità umana di affrontare i momenti importanti della vita e della morte attraverso l’immagine è fondamentale. Oggi che questo credo si è frantumato, non mi propongo di far rivivere i rituali, ma di analizzare questa frattura. Nel rito religioso mi affascina la collettività e la capacità di trasformare bisogni e domande fondamentali in segni visibili. Non mi ritengo un anacronista, semplicemente trovo sciocco ignorare una dimensione che ha accompagnato l’umanità per migliaia di anni in nome di un presente che, non avendo nessun rapporto con il passato, si vede negare anche qualsiasi prospettiva verso il futuro.
MR: Forse questo ha anche a che fare con il periodo storico in cui hai studiato. Oggi uno studente d’arte in Albania vede in te, Anri Sala o Edi Hila dei punti di riferimento. Voi però eravate dei pionieri.
AP: Sì, quando ho iniziato io i punti di riferimento erano i grandi artisti del passato. L’informazione sul contemporaneo mancava totalmente e quella sull’arte del XX secolo era molto scarsa e subiva delle censure. Dopo la caduta del comunismo c’è stata una voglia bruciante di capire quello che succedeva nel mondo e di recuperare il tempo perduto. C’era anche una dose di ingenuo entusiasmo in questo desiderio e a volte ne è risultata una grande confusione, che però a conti fatti considero salutare. Se dovessi scegliere tra una ricerca confusa e la chiarezza di un modello prefabbricato, preferisco di certo la prima.
MR: Una questione spinosa: come mai secondo te dall’Albania non sono emerse tante artiste donne?
AP: La società albanese è stata tradizionalmente dominata dagli uomini e l’emancipazione delle donne proclamata dal comunismo, anche se in verità ha portato dei risultati, non è riuscita a ribaltare questa tendenza. La caduta del regime ha aperto tante strade ma anche tante problematiche e le donne non sono state molto facilitate nell’affrontarle. Non ti saprei dare una risposta esauriente, ma credo che il grado di difficoltà che devono affrontare le artiste donne in Albania è più alto di quello degli uomini. Le scuole d’arte sono piene di ragazze ma quelle che continuano non sono tante e quelle che riescono ad affermarsi sono effettivamente poche.