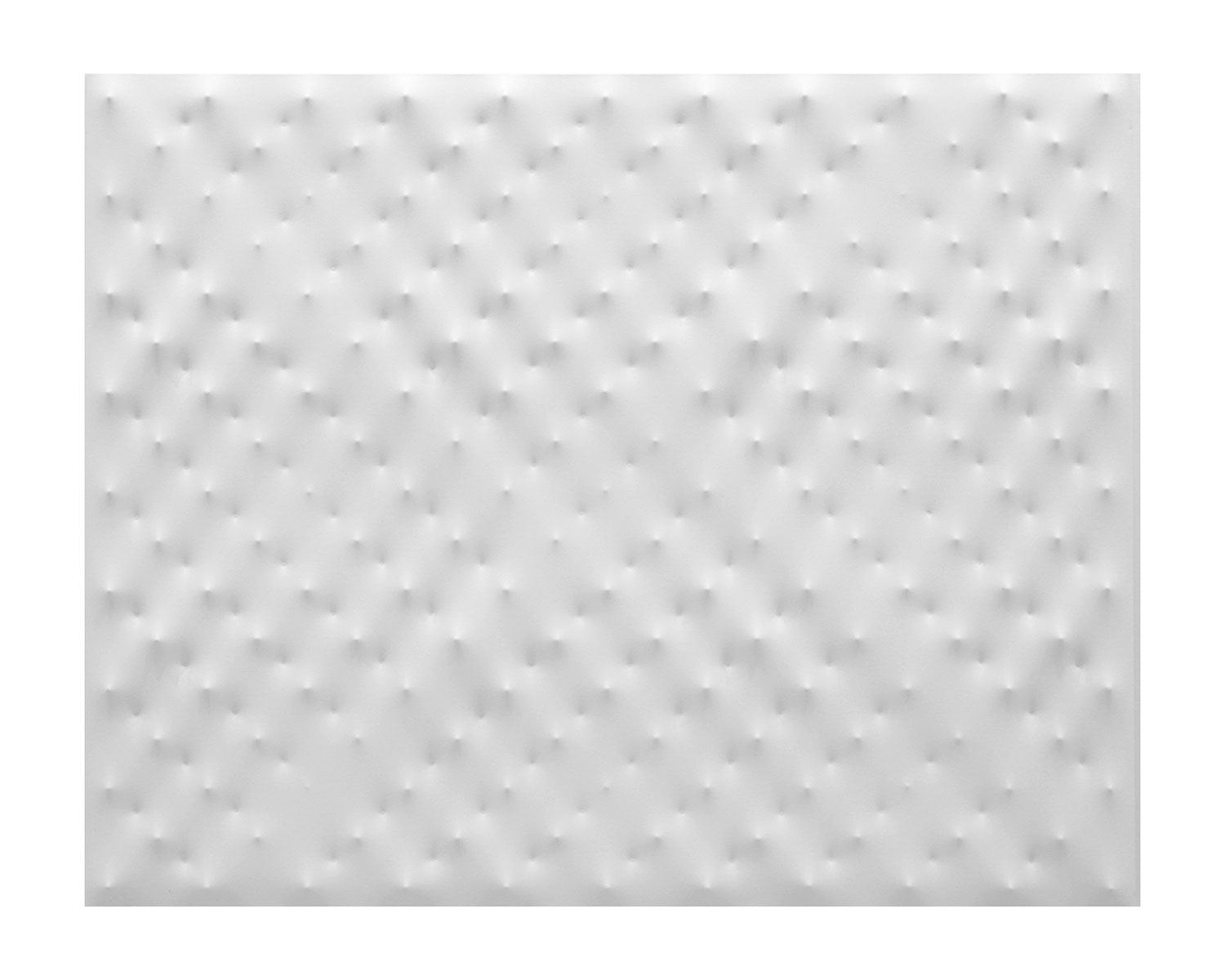Michele D’Aurizio: Ho recentemente visto alcune tue opere neon della serie “Potsherds and Gazes” (2012 – in corso). Erano esposte nella mostra “Ennesima” alla Triennale di Milano; e in particolare nella sezione “Per la scrittura di un’immagine”. Questa sezione individuava tra le caratteristiche preminenti dell’arte italiana quella di validare la produzione artistica tramite la definizione di un immaginario (di invenzione dell’artista o di derivazione) che preceda e in un certo senso orienti la creazione. Descriveresti il tuo immaginario?
Andrea Romano: Penso che quello che orienta e precede la mia pratica non sia tanto un immaginario ben definibile, quanto (l’interesse per) una serie di valori che comunemente si attribuiscono all’arte. Più che immagini o cose esistenti penso che i miei riferimenti siano i miti e i falsi miti che continuamente vengono trasmessi dalla nostra cultura.
Sicuramente il paesaggio che mi circonda ha un ruolo fondamentale – sempre che esso possa essere inteso come immaginario. In particolare i luoghi dove coesistono più aspetti e sensazioni, dove esiste una relazione tra potenza e vulnerabilità o tra un senso di cura e un senso di abbandono. Penso che questi siano elementi che spesso caratterizzano concretamente molte relazioni umane così come l’ambiente in cui vivo quotidianamente, come le strade che percorro tra il centro di Milano e la periferia in cui abito e in cui si trova il mio studio. In questo attraversamento di aree così esteticamente diverse, l’architettura, gli spazi verdi, le vetrine, si trasformano. Credo che queste ambivalenze e questa sorta di passaggi di stato influenzino profondamente il mio modo di pensare per immagini.
MDA:“Potsherds and Gazes” è una serie nata diversi anni fa sotto forma di disegni. Nel corso del tempo i disegni stessi hanno subito diverse trasformazioni: caratteristiche del tratto, formati, circuiti distributivi (sono stati presentati in mostre, incorniciati e senza cornice; come progetti editoriali, e quindi ‘digitalizzati’, ecc.). Oggi quei disegni sono evoluti in opere neon.
Mi domando quindi se i ‘passaggi di stato’ che rintracci nel paesaggio che ti circonda non vadano ad incidere sulla tuo stesso processo di creazione delle opere. In questo caso, allora, laddove la pratica consiste in una continua transustanziazione di immagini, è possibile parlare di un immaginario che sta all’origine, anche se questo è autoriferito alla pratica sola.
Qual è il soggetto di “Potsherds and Gazes” e qual è stato il tuo primo interesse in quello?
AR: Il soggetto della serie è la relazione tra corpi di esseri umani e dinosauri nel cartone animato The Flintstones, in particolare le scene nelle quali i primi usano i secondi come strumenti per soddisfare le necessità di una società più simile alla nostra – in altri termini, è la relazione tra un’idea di primitivo e un’idea di modernità. Da quelle scene, spesso caratterizzate da un rapporto tanto gerarchico da ricordare gesti violenti o di bondage, ho estratto solo le poche linee dove i corpi delle due creature si toccano o si sfiorano. Così ho creato una visione più allusiva, tanti ‘cocci’ di un passato e di una storia che non sono mai esistiti.
Mi sono allontanato sempre di più dalle immagini originali per vedere in che modo quelle linee potessero costituire un linguaggio autonomo e assumere altre valenze. I diversi formati che ho sperimentato appartengono a diverse fasi della ricerca, ma ho sempre concepito questi lavori in uno spazio astratto o neutro, come una sorta di vocabolario di segni. Quando producevo i primi disegni della serie, tra il 2011 e il 2012, sentivo già il bisogno di trovarmi dentro e davanti a queste immagini, così sono arrivato a pensare al neon, per amplificare una qualità ambientale e temporale del segno.
MDA: Parli delle immagini di questa serie in termini di ‘vocabolario di segni’; però si tratta di un codice di cui tu solo detieni la chiave. Certo, i neon suggeriscono una dimensione di riproducibilità tecnica che favorisce una maggiore ‘disponibilità’ verso lo spettatore, laddove nei disegni lo stile del segno tradisce inevitabilmente un virtuosismo del fare che può essere solo tuo. Mi domando quindi se questa serie è una forma di scrittura, ovvero una forma di comunicazione, seppur con la tua lingua – se quindi sottende un ‘messaggio’ – o se si esaurisce nella definizione formale del segno, che rimane quindi un segno muto.
AR: Non riesco a porre una distinzione netta tra le due possibilità, né sento queste due interpretazioni vicine al lavoro. I segni, che siano su carta o neon, non contengono ‘messaggi’ particolari, ma non credo nemmeno che siano muti – ad esempio, vi si può rintracciare un sapore pseudo-modernista.
Tuttavia, penso che la chiave sia semplicemente l’empatia. A volte combino i segni perché mi ricordano altre forme, altre volte cerco di esasperarne il sapore carnale, altre ancora quello frivolo. Dalla fase ideativa a quella espositiva, tutto passa attraverso l’azione del guardare; guardare e fare coincidono intimamente e di conseguenza il processo si traduce nella creazione di una visione.

MDA: Una delle tue produzioni più corpose è intitolata “Claque & Shill” (2011 – in corso). Ciascun elemento della serie é un disegno ‘incastonato’ in un blocco di pietra dura. Il titolo chiama in causa due figure il cui ruolo è falsificare la ricezione, l’una – la claque – di una rappresentazione teatrale, l’altro – lo shill – di un prodotto in distribuzione.
Quando ti riferisci alla partecipazione dello spettatore alle tue immagini, parli di ‘empatia’. Però tutto l’appartato discorsivo intorno a quelle é come se volesse indurre invece un atteggiamento di diffidenza. Insomma, io riconosco lo stimolo all’empatia, perché le tue sono sempre immagini ‘sensuali’. Ma mi pare quella un’empatia ‘televisiva’ più che ‘cristiana’, come invece intenderei io questo sentimento.
AR: La claque e lo shill sono figure che consciamente o meno influenzano la ricezione di una messa in scena, recitanti che si confondono tra il pubblico con lo scopo di produrre consenso. Come gli elementi che costituiscono l’opera, il disegno e la cornice, la claque e lo shill occupano una posizione ambigua nella rappresentazione, sono sia dentro che fuori. Nell’opera, la cornice, scavata in un blocco di pietra, blinda il disegno ma al tempo stesso lo amplifica nello spazio espositivo.
Per me l’empatia è una delle dinamiche fondamentali che determinano la nostra esperienza con ciò che ci circonda: è riconoscere nelle immagini e negli oggetti dei sentimenti o delle sensazioni. Pensare agli elementi che costituiscono un’opera, alla relazione tra determinate immagini e determinati materiali, significa esplorarne le potenzialità, siano esse morali, espressive o narrative. La mia intenzione quindi non è di ‘abbindolare’ lo spettatore, quanto di suggerirgli questa mia posizione indagativa.
MDA: Però, quello che percepisco in qualità di spettatore è che nelle opere esiste effettivamente una ricerca sul piano dell’immaginario, e che questo si compone di immagini che hanno un potere di ‘adescamento’. In “Claque & Shill” i soggetti sono sempre ‘attraenti’. Infatti basta una minima presa di consapevolezza della natura dei soggetti a esprimere quella funzione e rivelare invece l’opera come un dispositivo di messa in scena di una rappresentazione nel quale ‘tutti’ hanno un ruolo: l’artista, colui che espone l’opera (il curatore) e non da ultimo lo spettatore. É qui che credo che lo spettatore possa sentirsi tradito, perché quello che gli si richiede é fondamentalmente una performance.
In un certo senso questi lavori sono degli omaggi al sistema dell’arte. E mi ha fatto sorridere vederne un ciclo sempre nel contesto di “Ennesima”, una mostra di sistema in fondo. Quel ciclo è composto da ritratti di giovani donne che abitano la tua (la nostra) comunità artistica. Qui la loro rappresentazione chiama in causa solo una minima componente della loro umanità (l’espessivitá del volto), mentre esistono altre, più complesse storie che chi (come me) ha riconosciuto quelle persone nei ritratti non può non considerare… Questo però non é un lavoro sulla tua comunità, ma al tempo stesso non può vantare un’autonomia assoluta che si consuma solo nella visione. L’opera qui deve fare i conti con lo spettatore che ‘guarda’, e al tempo stesso con lo spettatore che effettivamente ‘empatizza’ con quei soggetti.
AR: Sicuramente in questi lavori esiste un senso latente di teatralità, dove tutti, consciamente o meno, hanno un ruolo. In questo senso diventa naturale parlare di un sistema e includerlo nella ‘scena’. Tuttavia più che al ruolo delle figure del sistema dell’arte, penso a come certi valori estetici vengono veicolati e catalizzati, a come la nostra esperienza e la nostra cultura influenzino il nostro modo di guardare.
La serie “Claque & Shill” – la mia ricerca in generale – ruota intorno alle cose che ‘adescano’ me prima di tutti gli altri. Dei soggetti delle opere esposte in “Ennesima” mi interessa la loro ‘aria’ e vedere come le diverse pietre delle cornici possano attribuire o suggerire una sorta di personalità e legittimare i soggetti. Ho immaginato una carrellata di sguardi, di espressioni a volte algide, a volte ammiccanti.
Naturalmente questi lavori assumerebbero una loro autonomia fuori dal contesto locale, ma in questo caso ho volutamente cercato di creare un paesaggio che una parte di pubblico potesse riconoscere in qualche modo. Tutto ciò mi fa pensare che a volte la sfida sia quella di fare un’arte il più possibile partecipativa ma senza chiedere alcuna interazione, ad eccezione della semplice contemplazione.