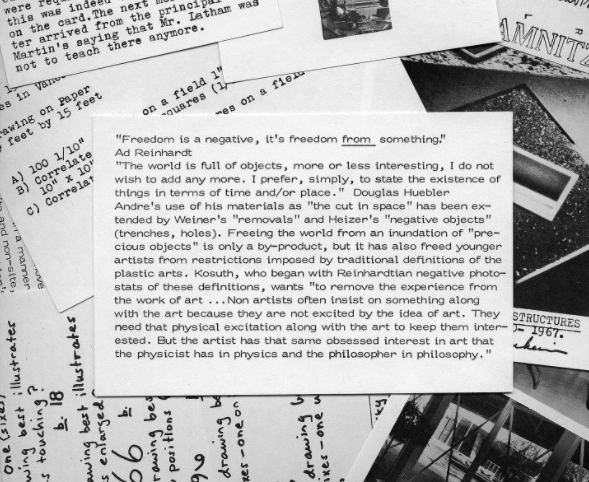Celebrare l’Arte Povera durante l’anniversario del 150mo anniversario dell’Unità d’Italia, dove alla retorica nazionale si mescola l’amaro della situazione socio-economica e cultural-politica in cui è ridotto il paese, non è esaltante. Se le origini remote da cui quell’arte è nata sono davvero quelle medioevali e rinascimentali, che rivendicano san Francesco e Jacopone, Fibonacci e Giotto, Masaccio e Piero della Francesca, Leon Battista Alberti e Donatello, dell’orgoglio d’aver avuto tali illustri antenati, dall’aria che tira, sopravvive uno sbiadito ricordo. Se si vuole comprendere allora da quali sedimentazioni, attraverso quali circostanze e tramite quali opportunità abbia preso vita, si sia sviluppata e infine definita l’Arte Povera, si devono prendere in considerazione altri fattori imprescindibili, nonché una serie di cause, apparentemente secondarie ma non meno determinanti, per la sua affermazione e diffusione a livello internazionale. Si deve anzitutto tener conto non solo del quadro storico entro il quale si sono manifestate le opere e gli eventi cui hanno dato corpo le azioni suscitate da essi, ma altresì quel contesto generazionale da cui provenivano i suoi protagonisti.
In un’Europa investita in primis dal tragico secondo conflitto mondiale e poi da un lungo “dopo dopoguerra”, in paesi come l’Italia e la Germania, contrassegnati da un’umiliante miseria eppure da un fervore ricostruttivo, il fenomeno della Guerra Fredda è qualcosa che attraversa le coscienze e il sentimento di autonomia e libertà del paese, mentre in esso si comincia a percepire, favorito dagli Stati Uniti, un benessere economico dispensato insieme con un’egemonia politica, tecnologica e culturale decisa da quel paese. Nonostante ciò, sugli esiti straordinari di riqualificazione del linguaggio visivo spaziale e materico raggiunto con radicale determinazione da artisti come Lucio Fontana e Alberto Burri, senza voler trascurare altri generosi contributi (Colla, Melotti, Capogrossi, gli artisti del gruppo Forma1, Pinot Gallizio, ma anche Rotella e perfino Emilio Villa) avevano innestato il loro disegno di azzeramento linguistico non meno risoluto, tra il 1958 e il 1960, tanto Piero Manzoni, Enrico Castellani e Dadamaino, affiancati da Vincenzo Agnetti, quanto Giuseppe Uncini, Francesco Lo Savio, Mario Schifano, Getulio Alviani, Gianni Colombo e i gruppi cinetico-programmatici.
Tra gli obiettivi condivisi da quasi tutti questi artisti, vi è il congedo dalla sensibilità informale nell’intento di concepire e realizzare un’arte ridotta alla semanticità del proprio linguaggio.

Ma tra il 1959 e il 1960 si erano ugualmente incamminati su un’altra strada alcuni artisti attivi soprattutto a Torino e a Roma — da Michelangelo Pistoletto a Jannis Kounellis, da Giulio Paolini a Pino Pascali —, viaggio che li avrebbe condotti, negli anni successivi, a convergere sulla koiné poverista, seppur con molte differenze.
La formazione delle molteplici sensibilità distintive dell’Arte Povera appare dunque scaturire dalla successiva grande presa di coscienza, nel giro di pochi anni, dopo quella del Gruppo Azimuth, del valore dell’esempio fornito dai maestri Fontana e Burri, in continuità obiettiva con un fondamento di tradizione ininterrotta dell’arte europea e soprattutto italiana, nonché da una vasta congiuntura di fenomeni sociali, culturali ed esistenziali che, dai blocchi opposti USA e URSS, investe la Francia, la Germania, l’Olanda e l’Italia.
Un tale risveglio si attua pienamente in un frangente in cui diviene evidente che, se nel corso degli anni Quaranta-Cinquanta l’egemonia artistica dell’Europa era passata agli Stati Uniti, nella prima metà del 1960 essa veniva sancita sia dal dilagare dei segni dell’American Way of Life in ogni aspetto della vita sociale, sia da alcuni concreti e ineludibili segnali come lo sbarco alla Biennale di Venezia nel 1964 della Pop Art statunitense — ora sappiamo per certo promosso dal governo americano e dalla CIA —, culminato col premio per la pittura conferito a Robert Rauschenberg.

Ma seguiamo intanto i percorsi individuali dei protagonisti della formazione “povera”.
Quando, nel 1961, con il dipinto su tela Il presente, Michelangelo Pistoletto giunge alla concezione del fondo pittorico riflettente, realizzando l’anno successivo il primo “quadro specchiante” — un’opera che doveva costituire nella sintesi pittorico-plastica un’autentica macchina di spazio-temporalità inedita — l’esperienza internazionale di Azimuth a opera di Manzoni e Castellani si era da poco avviata. Gli artisti italiani, dopo gli anni del dopoguerra e di ricostruzione del paese, avevano ripreso il gusto di viaggiare e scambiare le proprie ricerche con quelle dei colleghi olandesi, tedeschi, francesi, spagnoli, belgi, danesi, dei gruppi Zero, GRAV e altri, dilatando le proprie conoscenze e ambizioni.
A seguito della realizzazione del dipinto a olio Il presente, 1961, Pistoletto prosegue infatti, tra il 1962 e il 1965, le sue ricerche, giungendo ai “quadri specchianti” (1962), i “Plexiglas” (1964) e gli “Oggetti in meno” (1965-66). Con le lamiere d’acciaio inox lucidate a specchio, sulle quali colloca dipinta una figura umana o gli oggetti, Pistoletto enuncia una nuova dimensione temporale, scaturita dal “rapporto di istantaneità” che si produce tra lo spettatore, il suo riflesso nello specchio e la figura dipinta su di esso, integrando al presente il passato e il futuro. I “quadri specchianti” hanno il merito di aver portato alle estreme conseguenze, dopo le premesse della prospettiva pierfrancescana, gli sviluppi di continuità spaziale e di sintesi dinamico-plastica intuite da Medardo Rosso e sviluppate dal Futurismo, ma soprattutto di aver dischiuso una nuova dimensione prospettica spazio-temporale per l’azione artistica, dopo le drammatiche conclusioni estetiche ed esistenziali cui era giunto l’Informale. Nella realizzazione dei “Plexiglas” e poi degli “Oggetti in meno” si pongono alcuni elementi di base di quella sensibilità “poverista” di cui Pistoletto si rivelerà a Torino un propulsore. La sua opera successiva, a partire dalla creazione della compagnia teatrale Lo Zoo (1967), fino ai cicli di scultura degli anni Ottanta e all’ideazione dei cantieri scaturiti dal “Progetto Arte” che ha dato vita a “Cittadellarte”, si è attuata sotto il segno della collaborazione, investendo il sociale in tutti i suoi aspetti. Ma nei primi cinque anni della decade del Sessanta, molti degli artisti dell’Arte Povera, eccetto Calzolari, Penone e Prini, sono già in procinto di definire il proprio lavoro con precise modalità e fisionomie. Con Disegno geometrico (1960) prende avvio l’azione di Giulio Paolini che traccia una tantum quell’emblematica “tabula” referenziale di tutta la sua opera successiva e con essa — anche se il suo precoce metodo d’indagine analitica degli strumenti ed elementi impiegati nella messa a punto per la “visione” di un’immagine giungerà a un primo compiuto episodio espositivo con la mostra personale alla galleria La Salita di Roma nel 1964 — il suo lavoro ha già un destino configurato. Da allora infatti l’interrogazione che proviene dagli amletici lavori di Paolini osserva una vertigine enunciativa che le parti e gli elementi elaborati nell’opera, come facce di un prisma cristallino, si fanno carico di visualizzare, al tempo stesso, la complessità e la chiarezza. Intimamente sorretta dal sentimento indiziario, che il suo artefice ha disseminato in essa, l’opera di Paolini si dimostra eraclitea ed enigmatica. Ogni volta essa annuncia qualcosa che si ha la sensazione di percepire come entità inesauribile. Un incessante quid a cui l’artista stesso, prima di ogni altro osservatore, presta orecchi e occhi senza giungere a esiti definitivi. L’essenza manifesta in tutte le sue opere si nutre dunque di una radice di possibilità eventuali, praticamente infinite, e la sua qualità risiede proprio in quel dispositivo visivo che annuncia, di volta in volta, l’enigmatico quesito presente in una certa immagine, ma anche in quella immediatamente successiva, senza soluzione di continuità. Tale concatenata struttura delle sue concezioni lascia serpeggiare nelle opere una sottile vena d’inconoscibile sull’esistente o su ciò che è stato e tornerà a essere (eterno ritorno?), anche se in modi diversi. Proprietà, questa, spesso presente nei processi della natura come anche della storia, della memoria e infine del sentimento premonitorio. Entro questo inquieto teatro di ombre che attraversano la mente, l’opera dischiude una pausa, così luminosa e stupefacente, quanto arcana. La circolarità del sistema linguistico concepito e attuato da Paolini allude a una qualità temporale non meno conclusa che, come nell’opera di De Chirico, diviene sospensione pneumatica ed estetica, sfera autonoma, hortus clausus. Sempre in quegli anni si definiscono anche le proposizioni di tutti gli altri protagonisti, da Kounellis a Pascali, da Pistoletto a Merz, da Boetti a Fabro, da Anselmo a Zorio.
L’ambiente culturale torinese era stato propizio non solo alla rivelazione di talenti come Paolini e Pistoletto, ma anche di altri artisti che in quella città maturano la propria identità. Fra questi, Mario Merz, che aveva già offerto esempi efficaci di pittura “a-formale” negli anni Cinquanta, perviene a una nuova formulazione del suo lavoro, mediante un ciclo di opere definite “strutture aggettanti” (1964-65), la cui caratteristica è l’estensione della bidimensionalità pittorica verso lo spazio ambientale. A partire da quelle “strutture”, Merz troverà, nel biennio successivo (1965-67), la libertà di realizzare un’importante serie di lavori che, assumendo l’aspetto di opere plastiche costituite da “insiemi” a base oggettuale, si affrancano da quest’ultima attribuzione, grazie all’impiego di neon che “velocizzano” e cancellano ogni funzione e inerzia congenita all’oggetto. Le conseguenze delle implicazioni che queste opere comportano, in quanto “gruppi di senso” (Celant), costituiscono la base dell’azione successiva di Merz e il suo iniziale contributo alla formazione del movimento dell’Arte Povera. Esse recano, perciò, direttamente alle invenzioni degli “Igloo” (1967), delle “Proliferazioni Fibonacci” (1969-70), dei “Tavoli” (1973) e a rinnovate concezioni della forma pittorica (dalla seconda metà degli anni Settanta in poi).
Nel 1960 esordisce anche il lavoro di Jannis Kounellis che, a partire dal 1956, giunto dalla Grecia, ha scelto di vivere e lavorare a Roma, dedicandosi alla nuova dimensione di una pittura che da premesse di rapporto spaziale con la parete si distacca successivamente per attuarsi con mezzi e modalità diversi, nell’ambiente, con la chiara volontà di “uscire dal quadro”. L’opera di Kounellis non prescinde da quel traguardo che assicura alla lingua visiva la sua dignità. Sin dalle prime tele degli anni 1959-60, montate direttamente sulla parete e dipinte con impronte di smalti neri raffiguranti cifre, lettere e frecce, il processo di formalizzazione nell’opera di Kounellis assume un valore centrale. Ma ben presto, nell’elaborazione del proprio lessico e con modi autonomi, Kounellis giunge a metà di quello storico decennio degli anni Sessanta, alla chiara determinazione di portare nel libero spazio le intuizioni degli esordi. Nel 1967 realizza una serie importante di opere in cui l’abbandono e l’“uscita dal quadro” si rendono espliciti, adottando quali supporti spaziali il pavimento, le pareti e, tra i materiali, alcune nature vive. Così dal Senza Titolo (carboniera) (1967) al Senza Titolo (pappagallo) (1967), al Senza Titolo (campi) (1967), al Senza Titolo (cotoniera) (1967), al Senza Titolo (fuochi) (1969), alimenta una tensione poetica fino all’episodio dei “Cavalli” (1969) che suscita reazioni emotive e polemiche per l’evidente abnormità dell’associazione ideativa e l’implicazione spaziale. Ma Kounellis, che ormai ha coniugato la propria opera a quella di altri suoi coetanei, tra cui Pascali, e alla compagine degli artisti poveristi in fase di aggregazione, non interrompe più quel processo di costruzione linguistica in cui tuttora è impegnato con un crescendo di rapidità nelle attuazioni che ha assunto valenze drammatiche, dimensioni a volte titaniche e spesso soluzioni audaci. Affrontare direttamente i luoghi-teatro della sua azione, senza alcuna progettualità, ma solo a partire dai dati della propria costante elaborazione, sembra essere diventata la condizione nuova della sua pulsione operativa, non senza un sentimento di rischio in ogni episodio.

Aderente alle proprie radici mediterranee antropologicamente pervase dall’apparizione dei miti delle culture egizie, greche e romane, Pino Pascali è giunto a Roma dalla Puglia per studiare all’Accademia di Belle Arti, iscrivendosi alla scuola del pittore Toti Scialoja. Insieme a Kounellis, compagno di corso e di lavoro, è presto attento alla sensibilità materica del vivente. Dopo le prime esperienze di carattere neodada compiute tra il ’59 e il ’64, di cui si ricordano i lavori Pinguino (1959), l’Angelo vigile (1959), e l’Araba Fenice (1960), diversamente da Kounellis egli rivolge il suo epos immaginario all’acqua, alla terra, ma anche agli animali e al mondo ludico dell’infanzia, che aveva avuto in Savinio un precursore e nei critici Maurizio Calvesi, Giorgio De Marchis, Alberto Boatto, Cesare Vivaldi e Vittorio Rubiu, attenti lettori critici sulla scena artistica romana.
Il breve arco di anni di attività di Pascali dunque considera i cicli di opere dei “Quadri Oggetti” (1964), le “Armi” (1965), le “Finte Sculture” (1966). Accanto a numerosi e originali aspetti che distinguono queste opere dagli “Oggetti in meno” di Pistoletto o altre di Kounellis, si può affermare che Pascali ha costruito con centine in legno e tela o altri materiali come lana d’acciaio, tessuti spugnosi, foglie, alluminio zincato, pelo acrilico, residuati meccanici e altro, forme inscritte in una spazialità che può essere definita barocca o più precisamente barocco-paleopoverista. Suggerire una tale appartenenza deriva precisamente dalla costruzione delle “Finte sculture” stesse, che sono portate a far mostra di un corpo senza che esso sia realmente tale, in termini di consistenza. Perfino il Metro cubo di terra al suo interno è vuoto. In effetti, le finte sculture non mancano di rievocare le macchine sceniche del teatro barocco italiano, in particolare quello romano del Seicento, macchine note per la loro forza allegorica e la loro natura effimera.

Sin dall’inizio degli anni Sessanta si erano affacciati sulla scena milanese anche artisti come Luciano Fabro e critici come Carla Lonzi e Tommaso Trini. Seppur attivo dal 1963, marcando la sua prima uscita pubblica con una mostra personale alla galleria Vismara nel 1965, in realtà Fabro orienta assai presto la sua ricerca verso la qualificazione spaziale e ambientale, con l’intento di sviluppare le più avanzate concezioni ed esperienze fornite da Lucio Fontana e da Piero Manzoni in quella Milano dove egli stesso, provenendo dal Friuli, era approdato in gioventù. Così, dopo le prime formulazioni di “misurazione” sensibile e denotativa della spazialità, il suo lavoro si orienta decisamente in senso fenomenologico, cercando con l’opera esiti ontologici ed esperienze che lo mettano in grado di riappropriarsi di “regole” artistiche che guidino la futura azione. Dal Raccordo anulare (1963) a In cubo (1966), dall’Italia d’oro (1968) ai “Piedi” (1968-71), dagli “Attaccapanni” (1976) agli “Habitat” (1980), sino alle più recenti creazioni dei “Computers” (anni Novanta) e alle recenti sculture, la speculazione di Fabro segna uno degli orizzonti più qualificati e nevralgici nella ridefinizione dell’evento plastico perfino a fronte di eventi traumatici e distruttivi della realtà fisica (come Chernobyl, 26 aprile 1986), che hanno minacciato radicalmente l’idea di integrità della forma. Dopo Chernobyl, Fabro elabora opere che risentono dell’entrata in crisi della forma. Tra essa Prometeo, 1986, che “mette in visione” una caduta. Successivamente, C’est la vie, 1986, ma anche Efeso, 1986, l’Infinito, 1989 provocano sentimenti di smarrimento e domande enigmatiche per la loro indeterminatezza. Negli ultimi anni, prima della sua improvvisa scomparsa, nel 2007, intensifica accanto al lavoro un’attività teorica e maieutica. Il ruolo di Fabro nella compagine poverista, sia per quanto riguarda il rinnovamento della concezione di forma e di spazio, nonché dell’idea di habitat secondo i criteri albertiani della ratio civitatis, sia per quanto riguarda la considerazione dei materiali e lo sviluppo della produzione teorica sulla cultura del lavoro artistico, è di portata considerevole e particolarmente incisivo.

Dell’opera di Alighiero Boetti, mancato prematuramente nel 1994, si può affermare che essa appare come un’incessante ricerca di incontro con le realtà del mondo, disponendosi con una vivace e poetica attenzione alle più sorprendenti scoperte. Autore di importanti opere che sin dal 1966 hanno determinato aspetti inconfondibili dell’Arte Povera, Boetti ha predicato e raggiunto le “felici coincidenze” attraverso le quali, con atteggiamento ludico, ma non meno conoscitivo, scoprire il mondo circostante o quello che dalla sua opera veniva rivelato. A partire dall’uso di materiali industriali di pronto impiego (dal cartone ondulato, al cemento eternit, al tessuto stampato e altro), Boetti tra il 1966 e il 1967, anno della sua prima mostra personale presso la Galleria Christian Stein di Torino, si applica alla presentazione materiale di concetti e idee, prima tra tutte “il superamento delle antinomie” che sembra alla base di ogni realtà e di ogni logica. Il tempo, l’identità, i gradi della percezione, l’alterità, l’ordine e il disordine, la complessità del numero, il valore della parola, la codificazione cifrata e altre problematiche divengono i territori della sua ricerca. La sua pionieristica frequentazione dell’Oriente e di alcune regioni di esso, come l’Afghanistan, oggi al centro delle tragiche vicende di guerra e terrorismo, lo impone all’attenzione dei giovani artisti, sui quali ha esercitato più influenza di qualsiasi altro protagonista dell’Arte Povera. Da quei viaggi sono nati le “Mappe” (1971) e i ricami di “Ordine e Disordine” (1973), “Tutto” (1987) e i “Lavori Postali” (1972) dall’Afghanistan. Proprio in questi giorni, la fortuna critica dell’opera di Boetti cresce con intensità analoga alla crescita di attenzione verso Kabul e quei territori che sono diventati la seconda patria di Boetti. Anche per Gilberto Zorio l’attività artistica ha inizio nei primi anni Sessanta. Essa si rivela immediatamente come indagine costante della materia interrogata a partire dalle proprie qualità e sollecitata dall’azione catalizzatrice dell’artista che ne mette in vibrazione ogni molecola. Il procedimento è quello della trasmissione di energia dall’autore alla materia apparentemente inerte. Gli stati d’animo, non meno delle energie fisiche, entrano nel gioco della trasmutazione che reca all’opus. Zorio è attento ai modi con cui si dispone la materia quando egli la sollecita a una reazione. Osserva i suoi depositi, le sue accumulazioni, le sue inerzie e gravità, le sue tensioni, le sue consumazioni, la durata e l’estinzione della sua presenza per rinvenire, a ridosso di ciascuno stato di essa, una conoscenza appropriata che ne controlli con forza e grazia le possibili manifestazioni vitali. Dall’Asse spezzato (1966) al Letto (1966), alla Tenda (1967), ai Piombi (1968), all’Odio (1968), alla Macchia (1968) ogni opera si rivela intrisa di un’immediatezza e di una libertà sorprendenti. Tutta la sua capacità tecnica è al servizio di un’energia poetica che sgrava ogni peso di cui pur la materia e le sue costruzioni aeree sono portatrici. Nel 1971 l’incontro con il suo Pugno fosforescente alla Biennale di Parigi produce in chi scrive un’autentica emozione per il lampo con cui l’opera di Zorio si congiunge con quella di Boccioni, senza sforzo e senza artificio, quasi naturalmente. L’impiego della resistenza elettrica o del laser, di forme come la canoa o la stella, del giavellotto o dell’alambicco, che attraversano lo spazio, lo configura come poche altre forme negli ultimi trent’anni; i suoi crogioli, le sue pelli, non meno del sibilo delle sue sirene, comunicano una grande pazienza d’artefice e una grande impazienza da rivoluzionario della forma.
Facendo uso di alluminio o filo di nylon, di tondini di ferro o filo di rame, di paraffina, o carta da spolvero, di un foglio di carta, una tela e una matita o di argilla e cera, ma anche di acqua o vetro e altro come l’oro, per Marisa Merz l’obiettivo sembra quello di riuscire a far dimenticare con cosa lei suscita la grazia, o lo stupore, il senso del dono e quello prezioso della cura posta nel lavoro. Il quale alla fine deve anch’esso ritrarsi perché finalmente, quando riuscito, appaia allo sguardo di chi lo incontra come indiscutibile presenza interrogativa. Ma nelle forme elaborate Marisa Merz dimostra le industrie più antiche e tanto la geometria quanto l’organico; e inoltre si coglie la naturale esperienza, l’impiego del tempo lungo, non alienato, liberato, autonomo. Marisa Merz lascia trapelare le affinità tra gesti e facoltà, dimostrando che si può disegnare con la grafite, ma anche con i ferri per creare la maglia; che non c’è gerarchia né distinzione di qualsiasi genere nell’atto artistico. A lei si deve una valenza di attenzione nel processo significativo che si rende palpabile e non sottinteso. La collaborazione estesa al lavoro di Mario Merz è anch’essa un dato antropologico sensibile che ha fatto la differenza nell’Arte Povera e non sembra elemento trascurabile, dunque è qualità del suo linguaggio. Alle forze presenti, dentro e fuori di noi, alle energie in atto o trattenute nelle cose, all’instabilità più prossima o a quella più distante, all’elementare o complessa partecipazione del nostro corpo e della nostra mente all’esistente e presente o al sensibile ma assente, al visibile come all’invisibile, al finito come all’infinito, Giovanni Anselmo dal 1965 orienta la sua nuova azione. La coscienza raggiunta in quegli anni, il sentire, l’avere motivazioni e l’agire entro una complessità di flussi, di energie e forze che circondano ogni propria manifestazione vitale, a partire dalla stessa energia del pensiero, induce Anselmo a un affinamento dell’attenzione verso quell’instabilità permanente che tutti avvolge e conseguentemente ad atti di verifica di quelle entità con cui interagiamo con la percezione e la sensibilità del nostro corpo e della nostra mente. Ciò spiega in modo eloquente il perché, nell’indicazione dei materiali impiegati in alcune delle sue prime realizzazioni Senza Titolo (1965) e Senza Titolo (1966), rispettivamente costituiti da un sottile tondino di ferro con antiruggine il primo e di un simile tondino in ferro teso in verticale su una base di legno il secondo, vi sia anche indicata la “forza di gravità”. Invisibile ma esistente, quanto quella sua ombra del 1965 proiettata dai primi raggi del sole dalla cima dello Stromboli verso l’infinito, la forza di gravità come anche la forza di coesione delle molecole del ferro è opportunamente considerata da Anselmo quale concausa presente e attiva di quelle elevazioni metalliche nello spazio. Si fa viva nell’artista la convinzione obiettiva che nella realtà una grande quantità di processi giunga alla percezione umana e che attraverso la sua stessa catalizzazione continui e, oltrepassando l’uomo, raggiunga ogni latitudine visibile e invisibile del cosmo. Con il volgere delle esperienze, si evidenzia che nella ricerca di Anselmo si incrociano gli antichi quesiti del pensiero presocratico, parmenideo ed eleatico, insieme a una coscienza relativistica dell’attualità e a un’attenzione e presenza fenomenologica alla realtà. In senso più vasto, quello di Anselmo è un ritorno alle cose in quanto manifestazioni della realtà nella coscienza. “Io, il mondo, le cose, la vita — dichiara Anselmo in quegli anni — siamo delle situazioni d’energia e il punto è proprio di non cristallizzare tali situazioni, bensì di mantenerle aperte e vive in funzione del nostro vivere”.
Una sensibile quantità di ragioni poetiche matura in Pier Paolo Calzolari al suo ritorno a Bologna dopo un’infanzia trascorsa a Venezia. Nel corso degli anni 1965-67, segnati da due mostre personali presso lo studio Bentivoglio, Calzolari ha tempo di formarsi e strutturare il proprio piano-base di carattere artistico estetico e letterario che può, in sintesi, essere considerato quello di una fluidità artistica consistente in una processualità psicodinamica con implicazioni fisiche — gli “atti di passione”, così definiti da Calzolari stesso — che sono cosa diversa dall’azione scenica spettacolare o retorica. Con tali presupposti aderisce all’Arte Povera nel 1968. Egli è incline a una necessità liberatoria della pittura e di se stesso secondo un’orizzontalità di incontro con le cose al fine di realizzare un’opera o altre attuazioni in un movimento ininterrotto “con la stessa metodologia con cui esco, prendo il giornale, entro in una chiesa gotica, incontro un cane, saluto qualcuno”. La riflessione sull’impiego del movimento introdotto nella concezione plastica, non come espediente cinetico, ma come addizione corporea che mette in azione ed esibisce psicoforze riconducibili al fenomeno percettivo-visivo è un dato precoce nella base linguistica di Calzolari. Egli introduce nel lessico poverista il sensuale, l’emozionale, l’organico per traslare dalla forma un’idea sublimata di essa. Inventa le strutture ghiaccianti per una qualità del bianco altrimenti non esistente; lavora con lo stagno, il piombo, il rame, i vegetali (tabacco, trifoglio, petali di rose, muschio), la luce elettrica, il neon, il sale, il burro e altri materiali che, impiegati nell’opera, risarciscono il suo desiderio di saturazione verso qualità impalpabili, invisibili.

Originalissima e innovativa per indirizzo, l’azione di Giuseppe Penone, tra le altre cifre plastiche poveriste, dischiude un’incessante indagine osservativa, e non solo, della Natura e perciò della Materia in tutte le sue forme vegetali, minerali e animali, come “fornitrici” di qualità e quantità da elaborare con “modi” suggeriti, ricavati e conquistati, come veri e propri “segreti”, al fine di ricavarne regole e leggi-guida nella creazione delle forme. Principi tattili, normatività regolatrici di funzioni, processi, esiti di catene biologiche e fisiche e altre induzioni provenienti da un’esperienza diretta compiuta nell’elaborazione assidua della materia sono osservati da Penone, per rivelare antiche e nuove proprietà esistenti in natura di cui impossessarsi e impiegare nella creazione della scultura. Egli è il più giovane esponente dell’Arte Povera e vi aderisce a partire dal 1968 con un primo ciclo di opere, intervenendo direttamente su alberi di un territorio a lui familiare nei boschi di Garessio, assai prossimi al luogo in cui l’artista è nato e vissuto a lungo. Le azioni rivolte a lasciare una traccia nella crescita dei vegetali considerati sono da lui documentate in una serie d’immagini fotografiche dal titolo “Alpi marittime”. Lavora con le pietre e gli alberi, ma anche col tatto e una manualità rabdomantica che gli fa percepire ciò a cui dedica azioni e riflessioni. Celebri sono le sue sculture “Alberi”, 1969, l’opera Rovesciare i propri occhi, 1970, Svolgere la propria pelle, 1970, Palpebre, 1978, i “Soffi”, 1978 e i “Grandi gesti vegetali” (1983-84) e numerose altre. Di tale articolato fermento, e soprattutto della sensibile varietà di formalizzazione che distingue un artista dall’altro, si fa carico colui che più di ogni altro nel tempo e con maggiore assiduità nel seguire, coordinare criticamente gli sviluppi, favorire gli scambi, ne promuove le circostanze: Germano Celant. Il giovane critico genovese, già vicino allo storico Eugenio Battisti, conia la nomenclatura “Arte Povera”, pur mutuandola dal “Teatro Povero” di Grotowski, ma ne arrischia anche le motivazioni critico-ideologiche con alcuni testi ormai passati agli atti come storici, nonostante talune vistose obiezioni portate a essi da alcuni studiosi. Un vasto e complesso dibattito segna non solo le tappe dei percorsi espositivi del movimento — numerosissimi in Italia e all’estero, talvolta anche di considerevole respiro, di cui sarebbe lungo elencare la bibliografia — ma ne mette altresì in risalto le contraddizioni, le incoerenze e alcune divergenze all’interno del “non gruppo”. Attraverso insofferenze intestine, preoccupazioni per le tattiche e strategie intraprese dal suo “portavoce-critico” in continua oscillazione tra gli USA e l’Italia (soprattutto nei confronti dell’arte concettuale e minimal americana verso cui questi è ugualmente proteso e afflitto dalla litigiosità dei pochi galleristi che nei primi anni del fenomeno non riescono a imporre e affermare sui mercati internazionali il lavoro di questi artisti), e nonostante tutto ciò, l’Arte Povera riscuote lentamente un credito internazionale che coniuga questa esperienza con i più importanti sviluppi dell’arte dal Futurismo alla Metafisica con il resto dell’arte a livello mondiale. Permangono vistosamente aperti alcuni problemi che riguardano la gestione etica e la portata estetica dell’Arte Povera, messi in evidenza sin dalle prime uscite pubbliche collettive come la mostra “Arte Povera e Im-Spazio” (ottobre 1967), presso la Galleria La Bertesca di Genova, l’articolo “Appunti per una guerriglia” di Germano Celant apparso su Flash Art alla fine del 1967, la mostra presso la Galleria De’ Foscherari di Bologna (febbraio 1968) e il successivo sintomatico dibattito dal titolo “La povertà dell’arte” (settembre 1968), nonché la manifestazione “Arte Povera + Azioni Povere” dell’ottobre 1968, organizzata ad Amalfi da Marcello Rumma. Tra i nodi che da ciascuno di quegli episodi emergono, risaltano soprattutto le questioni di fondo del “poverismo”: anzitutto la sua proteiforme identità; da essa le tensioni nord-sud (Torino-Roma); poi l’opposizione dialettica all’Arte Minimal e Concettuale. Qualcuno sostiene perfino che questa sia, tra le altre, una delle cause della nascita dell’Arte Povera, ma non è così; poiché i suoi protagonisti non sono singolarmente mossi da esigenze di “reazione” e la loro spinta ad agire, sensibilmente condivisa, è notoriamente affermativa di un’autentica volontà di vita nuova. Inoltre, vi è il problema dell’effettivo “organico” del movimento poverista che ha avuto nelle sue fila, in alterne fasi, l’adesione partecipe, ma anche l’allontanamento, di artisti di valore: da Piero Gilardi a Emilio Prini, da Gianni Piacentino a Paolo Icaro, da Mario Ceroli a calibri come Eliseo Mattiacci e Giuseppe Uncini, i quali avrebbero potuto benissimo far parte dell’Arte Povera per più qualità, ma evidentemente fecero o furono indotti a fare altre scelte. Infine, il rischio più frequente che l’Arte Povera corre risiede proprio nelle letture fuorvianti o limitanti delle quali spesso si sono resi responsabili illustri curators e musei di rango, come nell’ultimo caso di “Zero to Infinity”, osservato prima alla Tate Gallery di Londra (2001), poi a Minneapolis, Los Angeles (2002) e Washington (2003).