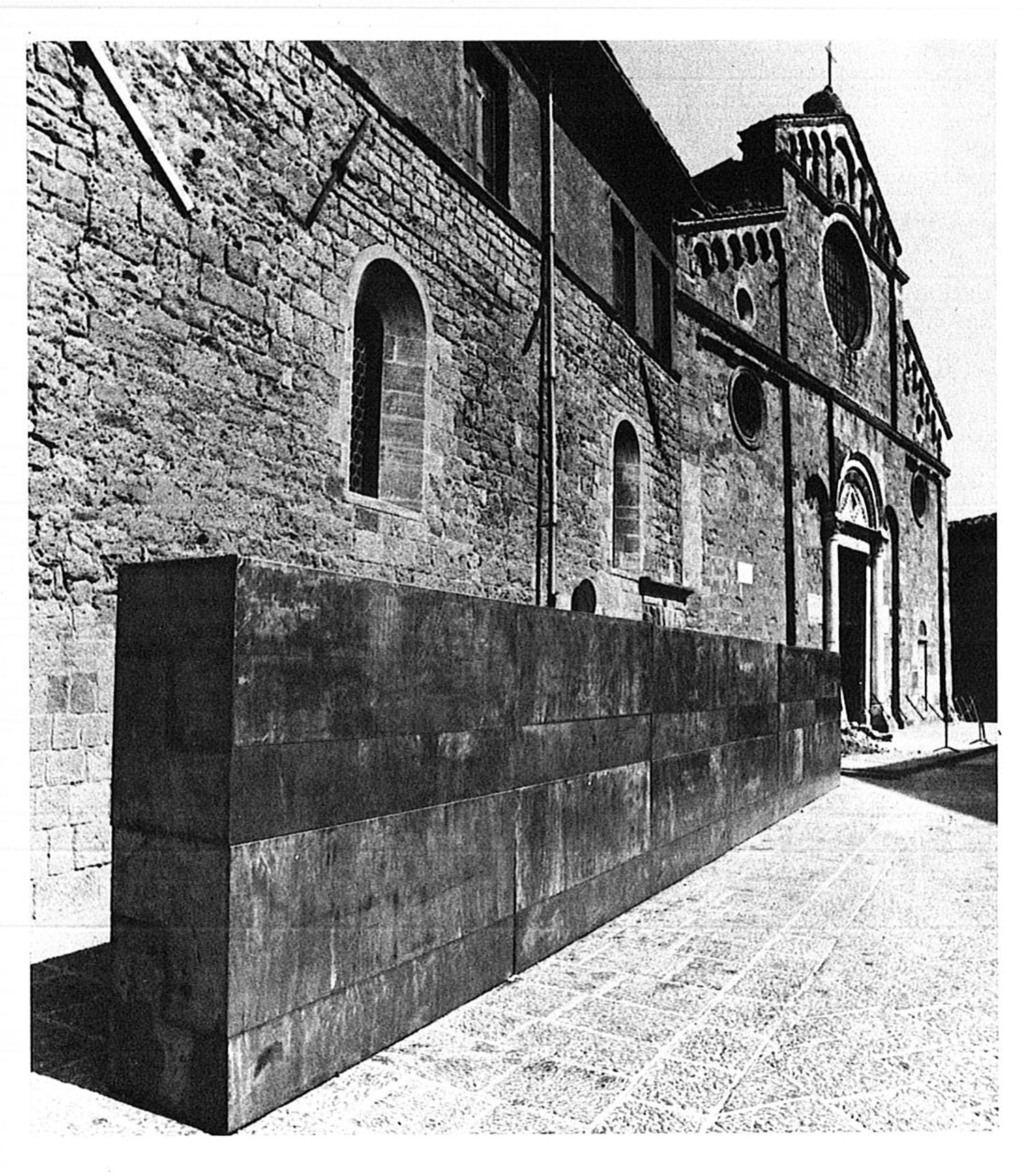Benni Bosetto (Milano, 1987; vive a Amsterdam) indaga concetti quali contrasto e ambiguità tra realtà e finzione attraverso la creazione di dispositivi che raccolgono insieme disegno, scultura, installazione e performance. La sua ricerca dà forma a una narrazione inedita e intangibile, situata tra l’onirico e il reale, in cui sembra possibile sperimentare una dimensione comunicativa primaria grazie a un linguaggio pre-verbale che interessa il gesto e il corpo, elemento centrale nella pratica dell’artista. Un particolare aspetto della sua ricerca si concentra sulle relazioni variabili che scaturiscono dal rapporto tra opera, spazio e pubblico.
Laura Perrone: Vorrei aprire questo dialogo partendo dai dispositivi narrativi che caratterizzano la tua pratica artistica. Nascono da un processo di decostruzione, ri-assemblamento e restituzione dei materiali che scegli di raccogliere, attivando una ricerca che spazia dal materico-formale al letterario-mitologico. Ci puoi parlare del processo che accompagna la costruzione di un tuo lavoro?
Benni Bosetto: Raccogliere informazioni, storie e immagini provenienti da fonti differenti e apparentemente scollegate, corrisponde alla creazione di un serbatoio da cui attingo per sviluppare un linguaggio puramente soggettivo che ha la funzione di indagare l’essere umano. Tali fonti sono selezionate mediante un metodo puramente intuitivo e si convertono in “hyper-collegamenti” e “hyper-narrazioni”, in cui etnologia, antropologia, leggende, miti, fatti di cronaca e credenze religiose vengono utilizzati come strumenti di lavoro, come una sorta di tavolozza dei colori. Raccolgo, assemblo e combino immagini che vengono infine analizzate e decodificate attraverso il disegno, ed è mediante il disegno che subiscono una trasformazione, liberandosi dal peso della storia, dei contenuti originari, del futuro o del passato che rappresentano. Questo processo si manifesta in una forma-pensiero di tipo narrativo, strettamente connessa allo spazio in cui dovrò intervenire.
Nella tua ultima personale, “Gli imbambolati” (2018) presso ADA Project a Roma, elementi scultorei in ceramica sono innestati all’interno del disegno di una griglia prospettica. Le minuziose linee del reticolato si estendono da pavimento a parete. È qui che il disegno si arricchisce di alcuni elementi architettonici che sembrano convergere in una dissoluzione sempre più forte del reale. Qual è la relazione che lega il disegno allo spazio?
Nell’ultima fase della produzione di un mio lavoro, il disegno deve confrontarsi con lo spazio fisico per espandersi nella terza dimensione. L’obiettivo di questa fase è far entrare in contrasto immaginazione e realtà, andando a creare un’esperienza di sospensione per lo spettatore. Quando vidi per la prima volta la galleria, immaginai fin da subito un’installazione scultorea a pavimento. In questa cornice, il disegno della griglia mi ha permesso di utilizzare gli archi come elementi di rottura prospettica, andando così a formalizzare quell’uscita dal reale che permetteva allo spettatore un’immersione totale nella narrazione.
Stabilisci delle regole da rispettare nel tuo processo di creazione?
Per me è importante che ogni processo avvenga tramite il mio corpo e i miei limiti, per questa ragione tendo a utilizzare i media tradizionali. Ovviamente questo può comportare dei compromessi legati al tempo, alla fisica, alle mie possibilità. Ad esempio con l’installazione Allegro ma non troppo (2018), che ho prodotto per la mostra collettiva “That’s IT!” al MAMbo di Bologna, ho pensato a una grande vetrata leggera, “fai da te”, in gomma PVC e stoffa; forse perché credo che l’arte non debba più spaventare, come è stato nel passato, né dimostrare che le cose siano impossibili da compiere.
Come mai nei tuoi lavori prevale la scelta di una palette neutra?
Non usando il colore il gesto non subisce modifiche né deviazioni, rimane fedele all’immagine pura e si rafforza. Comunque, non considero questa scelta come un’imposizione nel mio lavoro. Infatti, parte dell’installazione presentata al MAMbo è stata rivestita con un tessuto color carne. Il colore in questo caso è diventato essenziale ed è la chiave comunicativa dell’opera.

La presenza del gesto nella tua pratica artistica è preponderante; lo ritroviamo nel tratto che realizzi con il disegno, nei corpi dei performer che abitano i tuoi lavori, così come in alcuni elementi che caratterizzano le tue installazioni. Cosa ricerchi esattamente attraverso il gesto?
Attraverso il linguaggio visivo cerco di distruggere il normale codice di comunicazione, dando spazio alla creazione di un pre-linguaggio di tipo affettivo. In questa ricerca, il gesto è una sorta di codice vivente; è lo strumento con cui riesco a concepire il legame tra immaginazione e realtà. Nel mio lavoro, il disegno è quel punto di transizione in cui gli elementi narrativi si uniscono con il tentativo di trasformare differenti realtà in una materia unica, incerta e ambigua; attraverso il gesto mi approccio al corpo nascosto, ovvero a ciò che tendiamo a evitare, ciò che ci infastidisce, che è troppo banale, troppo alto o troppo basso. È quell’elemento in cui entrano in gioco dimensioni più lontane, impossibili da comunicare attraverso le parole.
Un ulteriore elemento che mi colpisce della tua ricerca è la riflessione sull’utilizzo del corpo da parte dell’uomo contemporaneo. In alcuni dei tuoi lavori tale riflessione è restituita attraverso performance semi-statiche. Ad esempio, in We burn our dreams to stay warm (2017) e in Florida (2016), ritroviamo personaggi sospesi nell’inoperosità, una permanenza in se stessi che Giorgio Agamben teorizza come forma di resistenza a un potere che invece attualizza, mette in opera e attiva¹. Come si situano nel tuo lavoro ozio, inerzia, riposo?
Quando ho deciso di utilizzare delle figure umane nelle mie installazioni intendevo mettere in luce l’importanza del corpo inerte e passivo come generatore benefico di un’altra forma di intelligenza dinamica: l’immaginazione. Volevo mostrare la possibilità di una diversa prospettiva della realtà, aperta e semplice da comprendere, rallentando e dilatando la percezione del tempo al quale siamo abituati.
La relazione e il contrasto che riesci a creare tra spazio pubblico e spazio dell’intimità nei tuoi dispositivi narrativi producono una sospensione del tempo cronologico che permette di entrare in sintonia con un tempo a-storico, capace di far percepire la durata che scorre in noi. Che genere di esperienza contemplativa speri di attivare in chi osserva i tuoi lavori?
Da sempre cerco di utilizzare un linguaggio intimo e a-temporale tramite una comunicazione di tipo rituale. La prima volta che ho presentato dei disegni su tessuto con il lavoro Teared up, teared down, teared apart, with a big smile on the face, esposto ad Amsterdam nel 2017 durante una mostra collettiva notturna nata da una collaborazione tra il Sandberg Institute e il De School, i disegni di grandi dimensioni (350 ´ 260 cm) rappresentavano figure antropomorfe e mitologiche, scene sacrificali e rituali di purificazione. Erano appesi alle pareti di una grande stanza che aveva una vetrata dalla quale si poteva vedere all’interno. Nella stanza si poteva accedere uno per volta, e i disegni erano filtrati da una torcia che ogni visitatore indossava sulla fronte. Come in una caverna, i segni erano esplorati grazie alla temporalità propria a ogni singolo corpo in movimento. Era una sorta di rituale animistico dove i personaggi disegnati erano attivati da una carica catartica. In questo caso ciò che mi interessava era la relazione che si veniva a creare tra opera ed esperienza del pubblico, interno ed esterno allo spazio espositivo. Volevo interrogarmi sulla relazione tra osservatore e opera e domandarmi se la condizione di intimità con l’opera restituisse qualcosa di più forte dell’opera stessa.