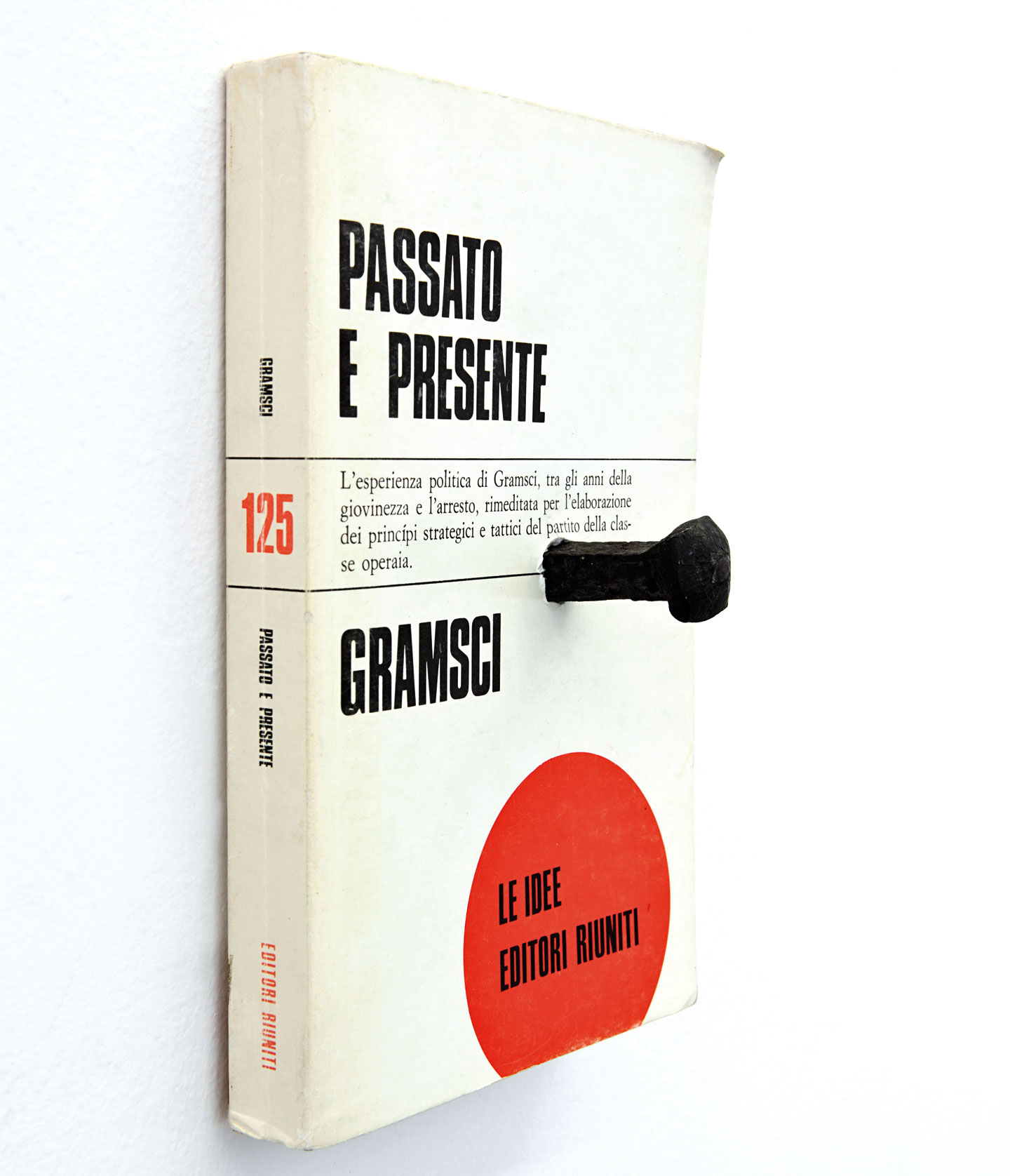Viviana Birolli: Stando al suo percorso, la si potrebbe considerare sia come un artista del suono che come un musicista dello spazio. Come concepisce questa duplicità tra elemento plastico e musicale?
Céleste Boursier-Mougenot: Mi considero un musicista, non un “artista del suono”: le questioni che affronto e i metodi che adotto sono e restano quelli di un compositore. Allo stesso tempo, lavoro direttamente allo sviluppo di dispositivi che generano forme musicali o sonore nello spazio: la dimensione plastica è perciò un completamento naturale della mia ricerca. Direi che sono un musicista che coniuga, sviluppa, dà a vedere e a intendere nello spazio i tre termini che sono le modalità di produzione di un’opera sonora o musicale (dispositivo e processo), la sua presentazione e la forma che ne risulta e si offre all’ascolto in un contesto dato. Da qualche anno a questa parte, noto delle forti similitudini tra i miei primi lavori sonori o musicali e le mie “coreografie indirette” — traduzioni dinamiche del rumore ambientale, della fluttuazione di una fonte sonora, della velocità del vento: i suoni che compongono una musica lungo un percorso spaziale e le traiettorie del movimento nello spazio sono per me due facce della stessa medaglia. A conti fatti, questa distinzione tra musica e arti plastiche non m’interessa granché… Ho sempre saputo di voler diventare un musicista, ma ho anche capito presto che non sarei mai stato un bravo strumentista: quello che m’interessava allora, e che m’interessa tutt’oggi, è il rapporto allo strumento come corpo sonoro, oggetto la cui architettura meravigliosa è determinata in ampia parte dalla necessità di produrre un suono.
VB: Com’è nata la sua pratica dello spazio e del suono e come si articola concretamente?
CB-M: Dal teatro: tra il 1985 e il 1994 ho collaborato come compositore per la compagnia ”Side One Posthume Théâtre” e il direttore, Pascal Rambert, mi dava sempre carta bianca. Concretamente sviluppavo i miei progetti musicali in piena autonomia e solo in seguito armonizzavamo il piano musicale, quello scenico e quello drammaturgico. Probabilmente è da qui che deriva il mio interesse per i “sistemi di compatibilità”: la ricerca di un accordo, di una sorta di aggiustamento tra il suono e lo spazio. Quella della spazializzazione del suono è una questione che m’interessa da sempre: un effetto di modulazione legato alla nostra percezione del movimento, lo spostamento di un suono, può essere considerato come un cromatismo dello spazio. Mi ricordo che anni fa mi sono imbarcato nella trascrizione su una sola nota di una suite per violoncello di Bach: da un brano di musica tonale estraevo una frequenza unica, proiettata nello spazio tramite un sistema di trasposizione che, a seconda della dinamica e della durata, attribuiva a ogni nota un valore temporale e una posizione in uno spazio scandito da 12 altoparlanti (corrispondenti all’intervallo cromatico, ovvero l’ottava divisa in semi-toni). Ho abbandonato questi esperimenti perché conducevano inevitabilmente alla determinazione di un punto d’ascolto ottimale, mentre nelle mie opere voglio che l’ascolto sia possibile ovunque, favorendo una deambulazione libera e aperta. È così che sono giunto all’elaborazione di dispositivi o di sistemi modulari con delle macchine “détournées”, sfruttate solo per il loro inatteso potenziale musicale — come nel caso delle 13 armoniche-aspirapolvere di harmonichaos (2000). Analogamente vanno intese tutte quelle installazioni in cui il compito di produrre fisicamente i suoni è affidato a degli esseri viventi privi d’intenzionalità musicale, come gli uccelli. In ogni caso, parto sempre dall’architettura di uno spazio e accordo i miei dispositivi sonori seguendone le linee direttrici. Come dico spesso, mi basta seguire le istruzioni…

VB: Si sarebbe tentati di definirla un traduttore: agente attivo del passaggio da un codice e da un canale all’altro, tra fedeltà alla fonte e tradimento.
CB-M: Penso di essere io stesso un medium, in senso paranormale ma anche materiale di traduttore e trasduttore: i miei esperimenti su Bach di 25 anni fa si costruivano già intorno a una circolazione incessante tra testo originale e testo secondo. Le traduzioni, però, sono reversibili, mentre nelle mie trasposizioni il messaggio originale non può essere restaurato e il significato risiede nel processo, nel flusso: in questo senso parlerei piuttosto della proiezione di un oggetto tridimensionale su un piano, della sua ombra. In prototype pour index, per esempio, l’origine della partitura musicale è un testo, ma un testo qualunque, a condizione che qualcuno lo stia battendo su una tastiera: ho bisogno di quest’azione concreta, fisica, viva, irregolare per produrre l’asse temporale all’origine della musica. Se ogni spartito è un dispositivo, il significato risiederà nell’adozione di un certo materiale e nel suo processo di trasformazione: io non controllo la fonte, ma determino le regole perché, tramite una serie di azioni e di filtri d’analisi, il pianoforte suoni come voglio io. Un testo ne conterrà allora infiniti altri, ma il significato si troverà tra i due, sospeso. Le nozioni di ciclo e di feed-back sono fondamentali da questo punto di vista: nei video di videodrones, per esempio, l’accostamento di frammenti di realtà colti in tempo reale fornisce gli elementi di una narrazione potenziale determinata di volta in volta da chi osserva. Il risultato è un loop senza fine che mantiene il fruitore in uno stato alterato, di suspense e tensione permanenti, rendendolo parte integrante dell’opera per il tempo in cui resta seduto: è una sorta di trappola per l’ascolto, in cui sono predisposte le condizioni per favorire l’infiltrazione del suono, che ha un tempo più lento, meno immediato dell’immagine.
VB: Le sue opere sono dei dispositivi, ma anche dei veri e propri strumenti: penso a from here to ear, ma anche a keyboardchairs (1997-2006).
CB-M: Le chaises à clavier sono degli oggetti ibridi esito dall’accoppiamento di una sedia e di una piccola tastiera acustica tipo armonium: sedendovisi, il visitatore non solo attiva l’opera, ma realizza anche una fusione fisica e simbolica tra orchestrali e uditorio. Quando ho realizzato per la prima volta d’ici à ici a Montreuil, nel 1995, una voliera piena di uccelli e la fonte sonora corrispondente erano separate: tutta l’installazione si costruiva intorno a questo iato, all’impossibilità per il visitatore di misurare l’effetto della propria presenza sui volatili. Poco tempo dopo, ho realizzato sans titre, la mia prima installazione di tazze di porcellana in una piscina: questa volta, la dissociazione tra acustica e dispositivo era semplicemente impossibile. È in quest’occasione che mi sono interrogato per la prima volta sulle mie idee preconcette, in particolare la convinzione che l’arte dovesse necessariamente essere anti-spettacolare, per non dire deludente. Quando ho presentato per la seconda volta from here to ear, il suono e la fonte erano riuniti: improvvisamente la necessità di una copresenza sonora, ma anche spaziale, il bisogno di sentire e di mostrare il meccanismo, mi sono sembrati evidenti.
VB: In harmonichaos (2000-2006) è la contraddizione fra diversi accordatori digitali spinti al loro punto di esitazione che genera il suono. In effetti, la maggior parte delle sue opere ha a che fare con dei sistemi, ma anche con quello che li trascende, con il colpo di dadi che non abolirà mai il caso.
CB-M: Mi piace pensare che un insieme di operazioni logiche applicate a una situazione possa sfociare nel paradosso di una forma aperta: l’idea di esaurimento dei possibili è fondamentale nel mio lavoro. È quello che accade in opere come sans titre o clinamen, dove scelgo i materiali e creo le condizioni affinché le occorrenze sonore frutto dell’incontro tra gli oggetti in porcellana esauriscano il ventaglio delle combinazioni possibili. A ben vedere si tratta di un modo di pensare abbastanza classico: Bach fa la stessa cosa con Sonate e partite per violino solo — prende tutte le tonalità e le forme ritmiche del suo tempo e, tramite la scrittura tonale, esaurisce tutte le possibilità del materiale-violoncello per produrre una forma, un’esperienza estetica. Per me, l’idea di forma sonora vivente non è aleatoria, ma risponde a un vero bisogno di sistemi capaci di rinnovarsi senza sosta: dispositivi semplici, alimentati da azioni fisiche concrete che circoscrivono una serie di dati nel reale — e non nella rappresentazione — per produrre una forma la cui complessità assomiglia alla vita. Modellizzare questi dispositivi e le forme che generano è impossibile, ci sono troppi parametri e il margine d’imprevedibilità è troppo alto; eppure l’esperienza, il suono, è lì.

VB: La maggior parte delle sue installazioni esiste soltanto nella relazione, nella percezione fisica, sensoriale e intellettuale dello spettatore.
CB-M: Quest’approccio riflette il rapporto che intrattengo con il mio lavoro: le mie opere non esistono quando le fisso su un supporto, esistono solo nel presente, in atto. È una cosa di cui ho preso coscienza rapidamente, quando ho capito che non sarei mai stato uno strumentista ma che mi sarei piuttosto dedicato ad accordare degli strumenti per gli altri “a modo mio”, determinando delle regole per filtrare, trattare e trasformare tutte le eventualità affinché il materiale scelto possa svilupparsi e vivere. Nelle mie opere la presenza dello spettatore è fondamentale: il dispositivo non è dissociabile dalle sue circostanze e dalla forma che ne risulta, e lo spettatore fa parte dell’opera per la sua semplice presenza nello spazio. Come nel teatro, non c’è opera al di fuori del presente perché l’opera stessa è il presente: bisogna che ci sia un orecchio che ascolta, un testimone. Paradossalmente mi si potrebbe considerare un compositore reazionario: un musicista che si serve raramente dei mezzi di riproduzione meccanica, preferendo restituire il momento presente.
VB: Potrebbe parlarmi di Rêvolutions, il suo progetto per la Biennale di quest’anno?
CB-M: Il Padiglione per la Biennale è aperto alla circolazione e agli elementi, concepito per essere un luogo ospitale, in cui si ha voglia di restare: immerso nella penombra su dei gradini soffici prodotti da Smarin, il visitatore assiste da una delle logge laterali alla coreografia di un albero mobile, al centro, il cui movimento è determinato da quello di altri alberi che deambulano su delle piattaforme all’esterno, secondo il ritmo del loro stesso metabolismo. Ho anche voluto misurare e trasporre in vibrazione sonora la corrente elettrica che scorre nelle piante che si trovano intorno al Padiglione: tutto il progetto verte intorno a questa antinomia tra movimento, elettrico e vegetale. TransHumUs è un work in progress che ho iniziato di recente e che spero di poter sviluppare nei prossimi anni. Le piante si moltiplicano, e in un certo senso si spostano, grazie all’azione degli insetti impollinatori, del vento, etc.; senza occhi e nell’ombra, gli alberi sanno da dove viene la luce e, di conseguenza, in che direzione crescere. Mi sono chiesto se ampliare le possibilità di movimento degli alberi non potesse segnare l’emergere di una nuova forma di determinismo, diversa da quelle che già conosciamo.