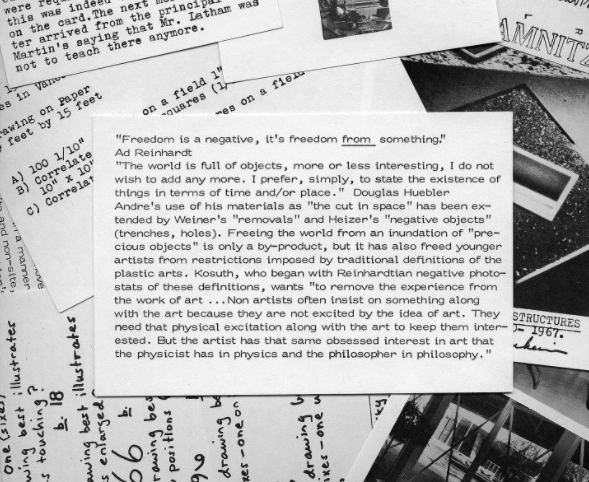Francesca Nicòli: Parliamo della tua mostra che è stata inaugurata lo scorso 12 maggio presso la galleria nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder di Vienna. Come è stata concepita?
Daniel Knorr: La prima sala era anche la prima accessibile al pubblico, e qui c’erano le “Missing Arms” della Venere di Milo che ho fatto fare in marmo e che erano adagiate sul pavimento in parquet. Questa sala di 60 metri quadri è la più grande della galleria, un piccolo gioiellino della Vienna Liberty. Nella seconda sala trovava posto un’enorme matrioska bianca e nera di circa due metri di altezza dentro la quale vi erano altre diciotto matrioske. La più piccola è alta solo 5 centimetri; è stata realizzata in cartapesta da me e dai miei assistenti. Nell’ultima sala, infine, altri due lavori: il primo consisteva in una piccola luce led fissata al muro, connessa alla rete elettrica e a un interruttore GSM attraverso un sistema invisibile. Ogni mattina appena sveglio, dovunque io mi trovassi, mandavo un sms a questo sistema via cellulare e la luce si accendeva. Ogni sera rimandavo un messaggio prima di coricarmi, e la luce led si spegneva. Quando il lavoro sarà acquistato, io dovrò continuare questo rito di accendere e spegnere finché vivrò. E quando non ci sarò più, il dispositivo rimarrà così come l’ho attivato l’ultima volta. L’ultimo lavoro era un monitor che mostra una pistola bianca con all’interno pallini rossi che si muovono. Questa che sembra una pistola in realtà è la forma della Kunsthalle Basel, e i pallini rossi sono i visitatori della mostra a Basilea, sorpresi mentre si muovono all’interno degli spazi espositivi. Il monitor è connesso a un piccolo computer il quale è a sua volta connesso a Internet. A Basilea c’è uno scanner laser che conta il numero dei visitatori mentre entrano, escono e si muovono nella Kunsthalle. Abbiamo scoperto l’esistenza di questo dispositivo a Basilea con Adam Szymczyk, che ha curato la mia mostra a Vienna.


FN: Mi pare che l’opera Venus Arms abbia, nel contesto che mi descrivi, un ruolo portante, e sembra un po’ diversa dagli altri lavori: vuoi parlarmene più nello specifico?
DK: Nella mia ultima produzione in realtà il background era simile a quello di altri miei lavori precedenti. Di base c’è sempre uno schema di riferimento concettuale attraverso cui reagisco alle situazioni più diverse, e attraverso il quale ogni lavoro assume una portata universale. Per questo definisco il mio metodo di lavoro una sorta di “materializzazione”. Penso che materializziamo il modo in cui percepiamo le cose, il mondo e noi stessi; questa tecnica si ritrova in tutti i miei lavori; in ogni caso l’idea di fondo, lo scopo ultimo, è quello di sovvertire un sistema prestabilito in modo da aprire a modi nuovi di leggere la stessa opera. Non sono un formalista, mi interessano sia le forme che le tecniche, ma questi parametri sono interessanti solo in quanto poi rimandano a concetti, ossia finché rendono possibile la materializzazione di cui ti sto parlando. Per questo motivo uso tecniche e materiali diversi, ognuno dei quali è la risposta specifica a quel preciso concetto. Penso che l’arte sia l’espressione più alta e più sofisticata con cui la nostra società si rappresenta, ed è soprattutto il luogo in cui la critica e il rinnovamento agiscono libere dal sistema politico. Tornando all’idea su cui si basa il lavoro delle “Venus Arms”, si tratta di una questione vicina anche alle tematiche tipiche del femminismo. Da una parte vorrei rendere finalmente autonoma la scultura, darle una compiutezza che ora non ha, e al contempo m’interessa il fatto di armarla, dandole braccia mancanti. Da quando è stata trovata nel 1820, la Venere di Milo ha rappresentato il canone della “bellezza” classica ed è diventata un riferimento d’obbligo quando si parla di un corpo bello e armonico, concetto che poi in realtà sottende alla rappresentazione della donna come oggetto. Queste braccia ritrovate, abbandonate per terra, mostrano anche una mancata abilità nell’agire, una specie di impotenza, anche se in modo solo “rappresentativo”. Infine, con un occhio rivolto al futuro, quest’opera acquisisce una carica sovversiva. Il tempo “comprime”, e se queste braccia “sopravvivranno” nei prossimi 2000 o 3000 anni, allora l’opera materialmente si ri-aggiusterà da sola, entrando in una sintonia spontanea con la Venere di Milo che si trova al Louvre. Forse nel tempo la scoperta verrà formulata dicendo: “Bene, ora finalmente abbiamo scoperto anche le braccia, le abbiamo ritrovate in una collezione privata”. In questo caso, il potenziale sovversivo funziona attraverso la capsula del tempo: più invecchia il pezzo nuovo, più sarà vicino a uno che in fondo è stato scoperto solo duecento anni fa.

FN: Come definiresti in poche parole la tua missione di artista concettuale, se a partire da questo concetto di “materializzare l’opera” che ci hai appena spiegato in relazione alle “Venus Arms”, arrivi a chiamare in causa la compartecipazione del tempo alla creazione del lavoro, al di là del suo aspetto fisico?
DK: Per il mio lavoro e più in generale per me è molto interessante aggiungere la dimensione del tempo alle opere d’arte. Penso che nel presente che stiamo vivendo adesso, c’è molto di quello che materializzeremo in futuro. Cosa succede a quest’opera nel tempo? Come sarà percepita e dentro quale contesto si ritroverà? Sto lavorando a un libro in cui con altri colleghi e amici analizziamo la natura della cultura. Ho fatto molte esperienze ed esperimenti che mi hanno dimostrato sempre più che la cultura è basata su codici naturali che evolvono sotto la spinta di una molteplice varietà di motivi e ragioni come la tradizione, l’educazione e le situazioni ambientali. Penso che chi realizza l’opera sia l’osservatore, cioè colui che la inserisce in un proprio contesto culturale dandogli un senso di volta in volta diverso, “ri-materializzandolo” ogni volta diversamente. Sto cercando una pratica per il futuro che consenta questo processo, questa partecipazione del tempo all’opera. Inoltre, penso che tutti siano artisti concettuali: l’opera esiste per la prima volta nella testa di chi la sta guardando, ovvero è prima nella testa dell’artista, ed è qui che trova il suo momento più puro. Dopo che l’artista la mette in opera, la materializza usando i media più disparati, e si materializza agli occhi di chi la guarda. L’osservatore crea con la sua partecipazione un canone culturale della percezione.