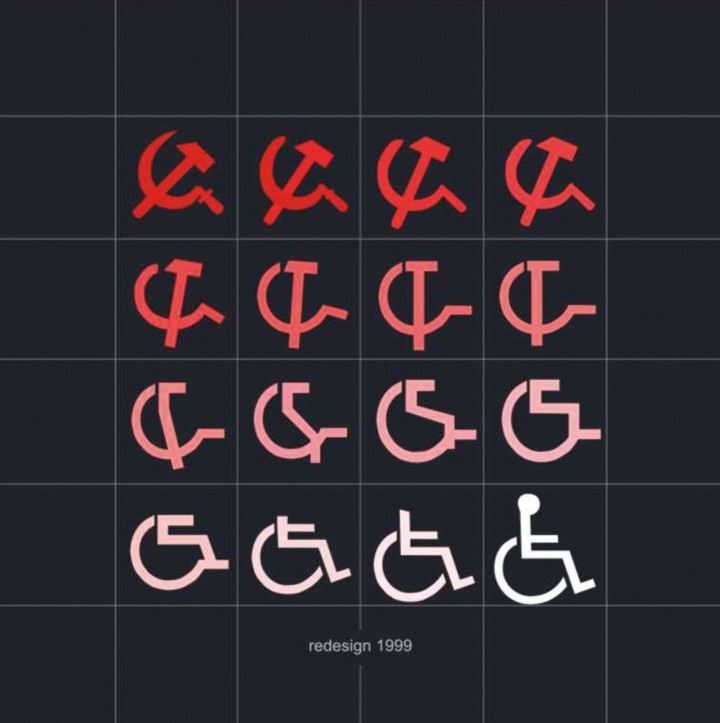Chiara Martinoli: In un intervento artistico del 1973, alla Biennale di Milano, lei chiedeva ai visitatori “Che cos’è l’arte?”. Mi sembra inevitabile cominciare l’intervista riproponendole la stessa domanda.
Davide Boriani: Le risposte possibili sarebbero molte, e nessuna esaustiva. Ne tento qualcuna: una metafora della realtà. Il più bel mestiere del mondo, fino a che lo fai per te; una forma di prostituzione se lo fai per soldi; il rischio di diventare un trombone se perdi la creatività per inseguire il successo. Agli studenti del mio corso di Design dicevo: il designer deve avere le conoscenze tecniche e la fantasia necessarie a risolvere un determinato problema sul piano della funzione e della comunicazione. Lo stesso vale per l’artista, con la differenza che l’artista deve inventarsi anche il problema.
CM: In un suo breve scritto, lucido e irriverente, racconta in sintesi la storia delle Nuove Tendenze, fatta di momenti di gloria e declino, luci e ombre. “C’era una volta l’arte cinetica, l’arte programmata, l’Op Art, e tutto quello che per comodità chiameremo le Nuove Tendenze.” C’era una volta il gruppo T. Che cosa ha portato al suo scioglimento intorno al 1968?
DB: Prima, e dopo il 1968, il mercato privato era la sola fonte di sostentamento economico del lavoro degli artisti. Di conseguenza nell’opera d’arte finalizzata al collezionismo prevaleva il valore di merce, bene d’investimento, status symbol. La spinta innovativa della ricerca artistica restava un valore accessorio, congelato nei salotti o nei caveau delle banche. Oppure portato a conoscenza del più vasto pubblico dei musei, ma come spesso accade in Italia, con anni di ritardo. Nei gruppi di arte cinetica, nell’arte programmata e nel movimento internazionale della Nuova Tendenza era presente invece l’istanza a sviluppare la ricerca in un contesto sociale più vasto, a superare steccati disciplinari per una riqualificazione estetica della comunicazione, dell’ambiente, degli spazi di vita collettiva. Nel 1968 una presa di posizione non soltanto formale circa il ruolo sociale dell’arte e dell’artista apparve improcrastinabile anche per il Gruppo T. Si trattava di scegliere tra due istanze che non coincidevano più: da una parte la produzione di opere, sostenuta e condizionata alle finalità, ai riti e ai miti del sistema dell’arte; dall’altra l’imperativo morale, o l’utopia d’ogni avanguardia a cambiare un po’ il mondo. Purtroppo ci si dovette rendere conto che non la pensavamo più tutti allo stesso modo. Il gruppo non si sciolse, collaborammo ancora in qualche occasione, ma da allora ognuno iniziò ad andare per la propria strada.
CM: Quali erano le diverse posizioni, e chi le sosteneva?
DB: Nel gruppo io sostenevo la necessità di cambiare dall’interno il sistema dell’arte, per sviluppare in un più vasto ambito sociale istanze già presenti nel lavoro di gruppo, nel coinvolgimento del fruitore, negli ambienti interattivi. Colombo mi opponeva, lucidamente, che cercar di modificare il sistema fosse una perdita di tempo, che impediva di trarre numerosi vantaggi dal mondo dell’arte. Con Colombo, anche Varisco continuò a operare all’interno del mercato dell’arte, con evidente coerenza in questo. Anceschi già nel 1966 aveva optato per il lavoro di designer, e praticamente sospeso l’attività di artista. Con De Vecchi e pochi altri artisti, mi ritrovai dunque a combattere qualche eroica battaglia contro i mulini a vento. Naturalmente non è servito granché, ma andava comunque fatto.

CM: Le sue idee e la sua presa di posizione dopo il 1968 riproponevano le istanze che erano state proprie fino a quel momento del Gruppo T. Ma il gruppo T non c’era più: come ha concretizzato il suo ideale di un’arte sociale?
DB: Cercai di resistere sulle mie posizioni evitando di seguire la strada che il nuovo contesto politico e culturale sembrava voler suggerire. Dal 1968 non ho più fatto mostre personali. Nel 1970 ho rifiutato l’invito a esporre come artista alla 35ma Biennale di Venezia. Ho accettato invece l’incarico di curare, come designer, l’allestimento della mostra “Ricerca e progettazione” nella stessa edizione della Biennale. Molti dei miei interventi negli anni Settanta furono concepiti per lo più come critica dall’interno del sistema dell’arte (Peinture en plein air, Gli adepti ai lavori, Che cos’è l’arte?), altri come applicazione della ricerca estetica in spazi di uso collettivo. Si tratta di interventi realizzati per lo più in piccoli centri, lontani dai riflettori delle cronache d’arte, spesso in collaborazione con gli studenti del mio corso all’Accademia di Brera. Con i quali ho ritrovato il piacere del lavoro collettivo che era stato del Gruppo T negli anni Sessanta.
CM: Lei ha avuto molteplici contatti e occasioni di collaborazione con Fontana. Qual era il vostro rapporto?
DB: Fontana è stato il primo ad acquistare una mia opera cinetica, il che certamente mi ha incoraggiato a proseguire. Il nostro rapporto era basato sull’amicizia, il rispetto reciproco, il piacere di lavorare assieme. Noi eravamo artisti alle prime armi, lui un maestro affermato che ci trattava come suoi pari. Non si dava arie, non pontificava ma faceva domande, lanciava ipotesi suggestive che poi sviluppavamo assieme. Il suo Ambiente a luce nera del 1949 era per noi una leggenda, prima di diventare un punto di riferimento. Un giorno mi chiese se con le calamite si poteva fare una sfera sospesa nello spazio. All’epoca mi sembrava impossibile. Oggi, come tanti, ho in casa un piccolo mappamondo che ruota, sostenuto nello spazio da campi magnetici. Un aneddoto a proposito dei nostri rapporti? Un giorno passavo per Corso Monforte e decisi di andare a trovarlo. Quando arrivai mi chiese di che cosa avevo bisogno: risposi che non mi occorreva nulla, ero solo passato per salutarlo. A questo punto lo vidi illuminarsi “Finalmente qualcuno che non viene a chiedermi dei soldi, o di fare una mostra!”. Alcuni mesi dopo mia madre ricevette la telefonata di un certo Lucio: voleva annunciarmi che il Gruppo T era stato invitato alla Biennale.

CM: Tra i diversi critici, chi, a suo avviso, ha saputo interpretare al meglio la sua concezione artistica?
DB: Sono stato trattato molto bene dalla critica. Diversi critici italiani (da Ballo a Crispolti, da Eco a Dorfles, da Argan a Caramel, e molti altri) hanno evidenziato aspetti diversi e complementari dell’arte cinetica e del mio lavoro. Ma le critiche più inattese e sorprendenti sono state quelle di due critici americani, che non ho mai avuto il piacere di conoscere. Il primo, John Dorsey, vide nell’ascesa e caduta della polvere di ferro della mia Superficie Magnetica una metafora della vicenda umana. Il secondo, David Rimanelli, che si definisce “critico marxista”, in un articolo del 2007 diede una vivace descrizione degli effetti psichici del mio ambiente stroboscopico, che va molto al di là di quanto io stesso avevo immaginato.
CM: La sua volontà di dar vita a un sistema dell’arte che esca dai salotti e dialoghi con la società, fa pensare all’ottimistico slancio comunicativo proprio del Costruttivismo. Chi sono i suoi riferimenti “storici”?
DB: La visione utopica delle avanguardie storiche si proponeva la distruzione del vecchio per la costruzione del nuovo. Con questa duplice accezione mi limito a elencare i miei riferimenti storici: i futuristi (Boccioni), il Dada (Arp, Schwitters, Duchamp), i costruttivisti e il Bauhaus. Tra i contemporanei Munari, per la sua ricerca a cavallo tra arte, design, didattica, e per la proposta di un’arte moltiplicata, cioè alla portata di tutti. Devo aggiungere che la mia idea di arte, e anche qualche mio lavoro, è stata influenzata dalla nostalgia di un ritorno, impossibile, al ruolo che ha avuto l’arte dall’antichità classica al Barocco. E da un confronto, impari, con opere e artisti su cui si è basata la mia formazione, e che ancora oggi hanno il potere di affascinarmi.

CM: Ritorniamo al suo testo: oltre che di arte lei parla di politica attuale, alludendo a un nano furbo e imbroglione (e il riferimento è evidente) che fa a pezzi la vita degli italiani. Quanto il mondo dell’arte, oggi e in Italia, è connesso alla sfera politica?
DB: Oggi il capitalismo è la sola ideologia dominante, la politica è sempre più limitata dal prevalere di logiche, poteri e interessi privati. Uno degli uomini più ricchi del paese blocca da vent’anni la politica italiana. I banchieri a Bruxelles decidono le condizioni di vita dei popoli europei. La finanza prevale sull’economia reale, e le crisi conseguenti ricadono su chi lavora. Con le risorse economiche accumulate, le banche si sostituiscono allo stato anche nella politica culturale. Non c’è manifestazione artistica che non sia sponsorizzata. Lo stato non riesce a tutelare il grande patrimonio culturale italiano, e si prospetta l’ipotesi di vendere il Colosseo. La situazione mi sembra efficacemente sintetizzata dal dito medio di Cattelan eretto davanti alla Borsa di Milano. L’amministrazione pubblica potrebbe completare il concetto erigendo in qualche piazza un monumento in bronzo, che raffiguri un pensionato intento a rovistare nel cassonetto delle immondizie.