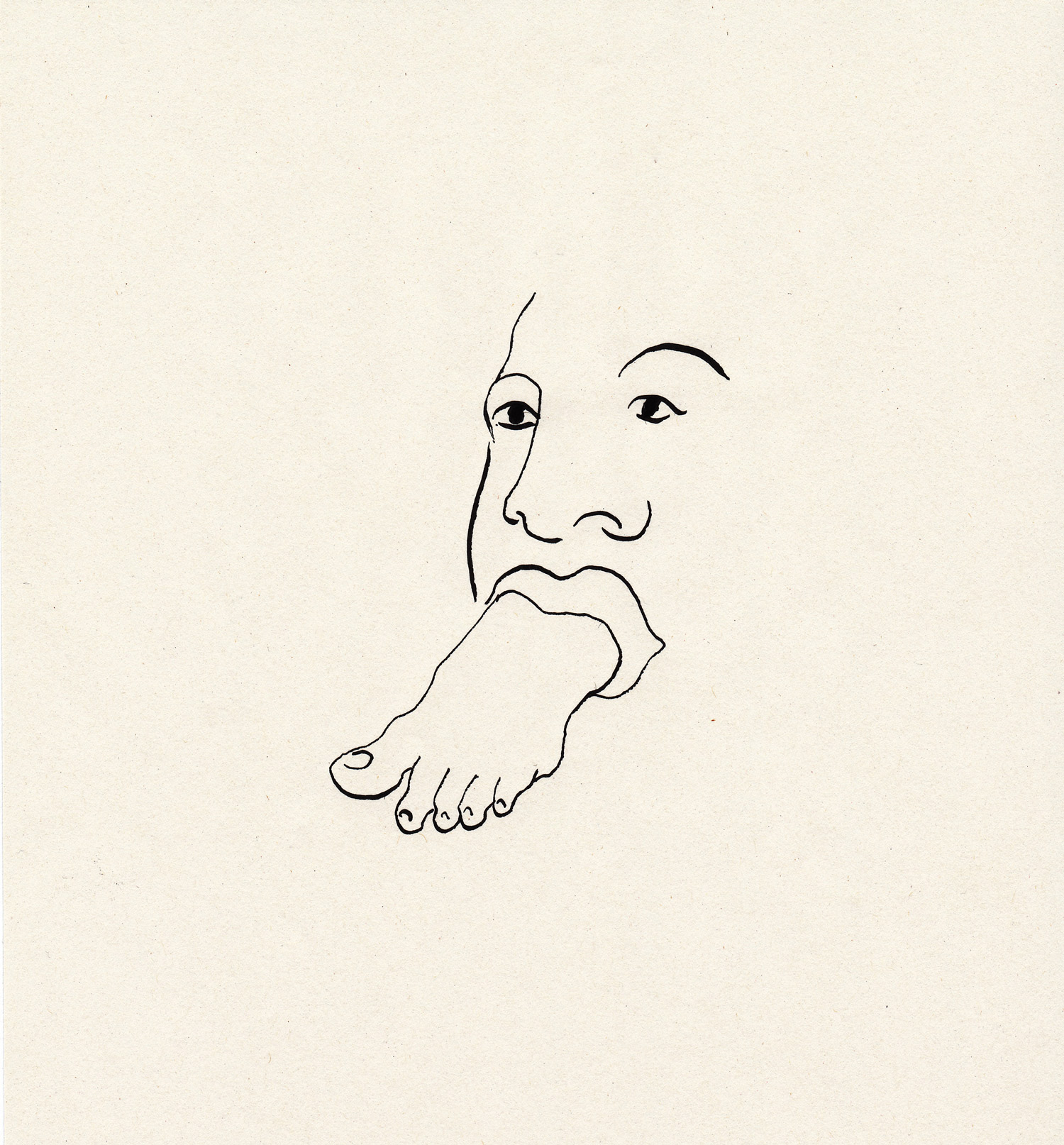Marco Tagliafierro: Analizzando la ricerca che stai portando avanti ho riscontrato un costante uso del collage, inoltre il tuo lavoro rivela una straordinaria sensibilità nel combinare segni dissimili, sia per provenienza che per forma. Mi chiedo se per te il collage rappresenti un metodo di lavoro oltre che essere un mezzo espressivo impiegato.
Davide Cascio: Sicuramente l’uso del collage rappresenta una parte fondamentale del mio metodo di lavoro, anche se non posso dire che ci sia un’esatta coincidenza tra l’utilizzo della tecnica del collage e il metodo di “costruzione” delle mie installazioni, tuttavia i due sistemi dichiarano alcune similitudini. La presenza stessa del collage o più in generale di immagini all’interno delle installazioni spesso ha la funzione di un’interferenza o di una contrapposizione, piuttosto che quella di evidenziare una coerenza di metodo. Il costruire per associazioni è un elemento in comune ai due sistemi, ma questi ultimi esprimono piuttosto due aspetti opposti di un unico metodo “associativo”: da un lato lo sviluppo teorico e tecnico di elementi spaziali, molto progettuale e razionale, dall’altro il collage che segue i canoni classici della tradizione dadaista e surrealista: riutilizzo diretto di immagini, procedere istintivo per tentativi, utilizzo di coincidenze e contrasti formali, il tutto amalgamato da una quasi totale assenza di progettualità.
MT: Talvolta le tue composizioni sembrano non tener conto della semantica tradizionale dei materiali e dei colori. Cosa ti affascina in questa sovversione linguistica?
DC: Non parlerei di sovversione linguistica, forse di costruzione di una semantica personale. Quello che mi affascina è il potenziale evocativo dei materiali: per esempio, l’utilizzo del legno nel mio lavoro fa riferimento a certe esperienze utopiche legate al rapporto con la natura, riferite a Henry David Thoreau, al Cabanon di Le Corbusier o alle architetture delle comunità Shaker di Hancock, N.Y. La combinazione di elementi storico-geografici e di conseguenza dei loro linguaggi estetici, apparentemente lontani o addirittura contrastanti, genera dei punti di contatto e un linguaggio di transizione.
MT: Molti artisti della tua generazione che partecipano al dibattito riguardante il concetto di modernità sono soliti fare riferimento al movimento modernista, tu invece ami citare gli architetti Radical. Questo perché sei alla ricerca di “zone” più aperte, di maggiore sensorialità, soprattutto di maggiore disponibilità a un destino meno controllato?
DC: Sono sempre stato affascinato dall’architettura non realizzata, dai progetti visionari di Claude-Nicolas Ledoux alla New Harmony di Robert Owen, ad Antonio Sant’Elia ecc. Partendo dalla Gerusalemme Celeste descritta nell’Apocalisse si potrebbe scrivere una “Storia Universale dell’Architettura mai realizzata”. Credo che tutto questo sia più importante di quanto è stato effettivamente costruito, con dentro tutto il fascino del fallimento, un fallimento esemplare è sicuramente più difficile da raggiungere di una riuscita esemplare. La scoperta di Superstudio, Archizoom, Ant Farm, è stata una sorta di folgorazione, quello che dei loro progetti mi ha affascinato sin dall’inizio è stato l’enorme potenziale, un potenziale che non si è esaurito nella realizzazione ma è rimasto vivo e attuale, aperto e percorribile; un potenziale che in qualche modo ho cercato di fare mio. Prima di questa scoperta avevo una visione dell’architettura come di un campo molto chiuso, pragmatico e fortemente condizionato dalla tecnica del costruire. Potrei dire che il mio interesse per l’architettura si ferma al progetto, al modello architettonico.