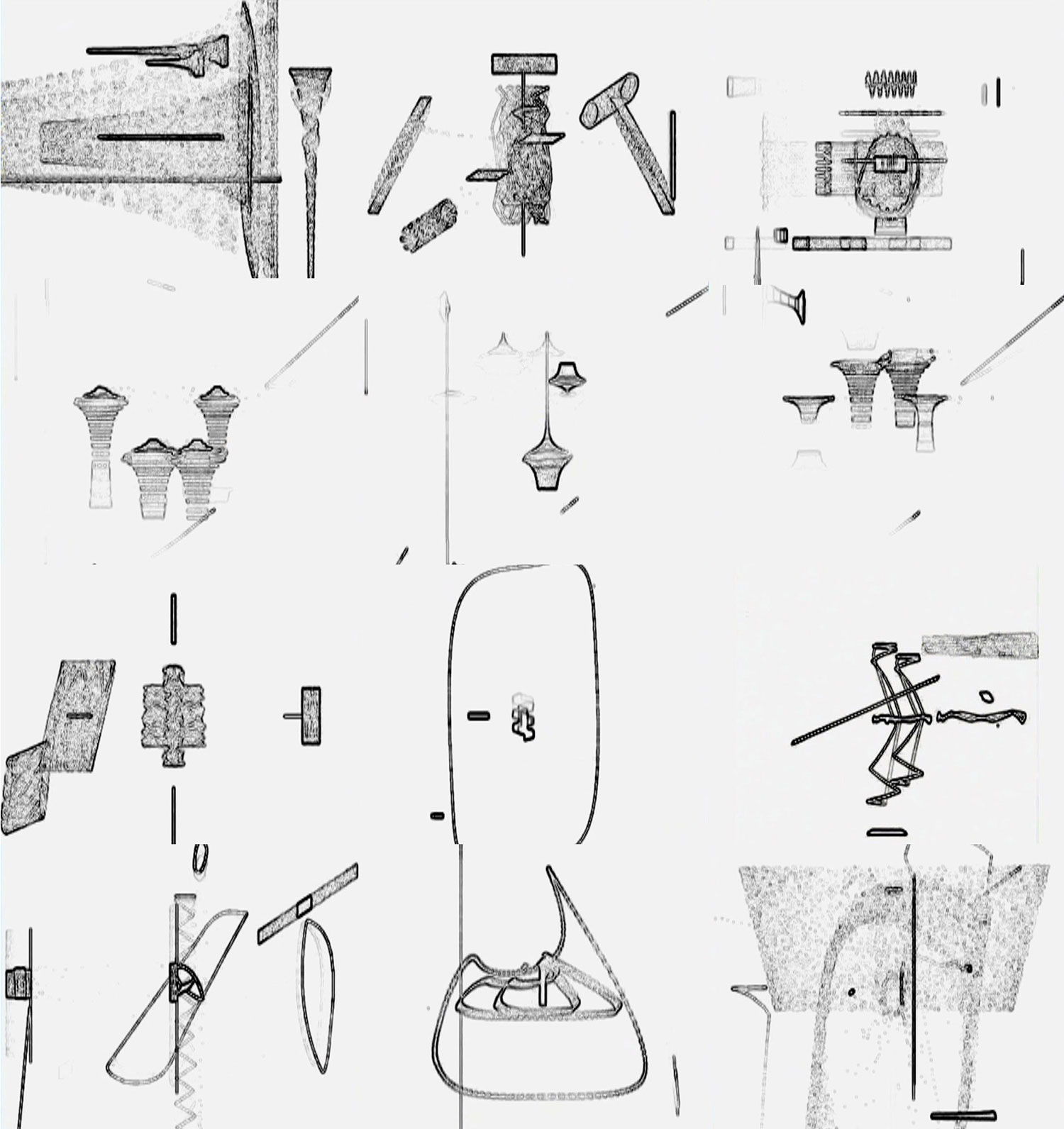I primi episodi della serie televisiva L’amica geniale sono appena stati proiettati nei cinema italiani e le quattro protagoniste della prima stagione salutano dai red carpet e rilasciano interviste. Un nuovo pubblico di spettatori si aggiunge a quello già folto dei lettori della tetralogia di Elena Ferrante (L’amica geniale, 2011; Storia del nuovo cognome, 2012; Storia di chi fugge e di chi resta, 2013; Storia della bambina perduta, 2014, edizioni e/o, Roma). e l’evento mediatico richiama di nuovo l’attenzione sul ruolo dell’autrice nella costruzione dell’identità femminile contemporanea. Lo pseudonimo “Elena Ferrante” sembra infatti rifrangersi e agire da collante su una moltitudine di donne – lettrici, attrici, giornaliste, spettatrici, traduttrici, critiche – che riconoscono nei romanzi della scrittrice qualcosa che le accomuna e che finora era stato colpevolmente censurato nella narrazione maschile del mondo. E se l’hashtag #FerranteFever non ha avuto certo la risonanza politica del successivo #MeToo, i due movimenti appartengono senza dubbio allo stesso clima di rivendicazione.
Coerentemente con questo tipo di ricezione, e probabilmente di conseguenza, anche il dibattito accademico su Ferrante si è interessato fin dall’inizio alla questione del pensiero femminista dell’autrice. Un punto ormai assodato è che la corrente di pensiero che più ha influenzato Ferrante è stata quella della “seconda ondata femminista”, e specialmente la riflessione filosofica che va sotto il nome di “pensiero della differenza”. Luce Irigaray, Luisa Muraro e Adriana Cavarero sono i nomi che ricorrono più spesso negli articoli e nelle interviste.[i] Il loro insegnamento sviluppa in modi diversi un’idea fondamentale, quella che il soggetto neutro sia un’invenzione maschile e che l’identità sessuale porti con sé un proprio linguaggio, un proprio ordine simbolico, una propria verità.

Questo non significa che i romanzi di Ferrante siano pamphlet per la lotta al patriarcato camuffati da storie. Il pensiero della differenza, piuttosto, ha permesso a Ferrante di creare con consapevolezza i propri personaggi e di dare il giusto rilievo al rapporto madre-figlia nella formazione delle protagoniste. Inoltre, nonostante la critica si sia finora concentrata sul femminismo come premessa ideologica, nella tetralogia dell’Amica geniale il movimento sessantottino diventa oggetto della narrazione e rappresenta un punto di svolta nella storia della protagonista Elena. La forza della tetralogia sta nel fatto che i due aspetti si completano a vicenda: la ricostruzione finzionale del femminismo storico permette a Ferrante di dire qualcosa non solo sull’identità della donna, ma più in generale sul cambiamento della traiettoria del mondo dagli anni Settanta in poi. E questo qualcosa, come vedremo, è molto vicino alla “verità femminile” che pensatrici come Muraro e Irigaray hanno teorizzato e che nei romanzi è incarnata dalla co-protagonista, l’amica geniale Lila.
Elena e Lila hanno entrambe sei anni quando fanno amicizia, ma il loro legame è già estremamente complesso: Lila è un modello per Elena, che si sente in dovere di emulare le azioni dell’amica, soprattutto quando si deve sforzare per vincere le proprie paure. Non solo: Elena accetta coscientemente la propria subalternità e decide di “regolarsi” su Lila per sfuggire all’influenza deleteria di sua madre, che con il suo strabismo, la sua “gamba offesa” e la sua parlata napoletana rappresenta tutto ciò a cui Elena ha paura di assomigliare. In questa prima fase si forma quindi fra le due bambine un rapporto che si può definire di affidamento sulla scorta del concetto formulato da Luisa Muraro negli anni Ottanta.[ii] Lila diventa cioè la madre simbolica di Elena, con tutta l’ambiguità del sentimento di amore e odio che questo comporta. Un altro tratto fondamentale della loro amicizia è che Elena e Lila sono capaci fino alla tarda adolescenza (e raramente in età adulta) di comunicare tra loro in modo fluido e intuitivo. Quando le loro teste “urtano”, le due ragazze entrano in uno spazio “smarginato” in cui i pensieri dell’una e dell’altra si mescolano in un movimento incessante e perfettamente simbiotico, simile a quello che sperimentano le due amiche/amanti descritte da Luce Irigaray in Quando le nostre labbra si parlano.[iii] Secondo Irigaray, le amiche acquisiscono due identità distinte solo perché una delle due si conforma all’ordine patriarcale, proprio come fa Elena quando, per primeggiare a scuola, cerca di darsi “capacità maschili” e di modellare sé stessa secondo la ragione degli uomini, “la più irragionevole”.
Il conflitto tra l’ordine artificioso di un’educazione imposta dall’alto e la realtà incoerente e non lineare incarnata da Lila (e da Napoli più in generale) è sotteso a tutto il romanzo. Nella prima parte, però, il disordine del rione e della città Partenopea è descritto dalla narratrice in termini esclusivamente negativi. L’obiettivo costante di Elena in L’amica geniale e Storia del nuovo cognome è quello di allontanarsi dal caos della propria città materna e di salire verso un grado più alto di istruzione, una classe sociale più elevata, un luogo più a Nord nella penisola italiana. Di conseguenza, la sua paura più grande è quella della regressione; il rione, Lila, la madre sono forze pericolose che se non contenute rischiano di trascinare di nuovo Elena verso il basso. Il punto di svolta in questo percorso di progresso sta nel terzo libro della tetralogia, Storia di chi fugge e chi resta, che racconta le proteste del Sessantotto e l’incontro di Elena con il femminismo. Il quarto volume, Storia della bambina perduta, segna infatti sia il ritorno verso Napoli sia lo “scantonamento” dei numerosi viaggi all’estero. Entrambi i movimenti interrompono e contraddicono la linearità del progresso/ascensione che fino a quel momento era stata la struttura portante della trama.
È stato detto spesso che la rappresentazione degli eventi storici dal dopoguerra a oggi è la parte più fragile della scrittura di Ferrante. Stereotipica e poco incisiva, la grande Storia sembra avere nella tetralogia un unico pregio, quello di mostrare quanto gli avvenimenti pubblici siano marginali nella vita delle persone comuni. Tuttavia, la discontinuità della trama e il fatto che, come accennavo, il punto di rottura sia situato attorno al Sessantotto indicano che Ferrante affronta il problema storico in modo più profondo, riproducendo in maniera convincente il passaggio dalla modernità alla postmodernità.
I primi due libri sono costruiti sull’opposizione rione/scuola, madre/maestra, dialetto/italiano, Sud/Nord, passato/presente. Queste dicotomie, tipiche della modernità, schematizzano una declinazione particolare dell’ideologia del progresso che gli Stati Uniti hanno reso egemonica dopo il 1945, il developmentalism. Secondo questa visione del mondo, lo sviluppo del capitalismo tramite l’esercizio della ragione illuministica avrebbe permesso alle aree sottosviluppate di raggiungere per tappe successive il benessere economico e la democrazia liberale, a patto che le nuove generazioni ricevessero un’educazione efficace e si lasciassero alle spalle i residui retrogradi della propria regione di appartenenza. Questa è la dottrina progressista che la protagonista sposa inizialmente senza reticenze, impegnandosi in un percorso esemplare: l’eccellenza a scuola all’interno del rione, il passaggio dal rione ai quartieri alti di Napoli durante il liceo, il trasferimento più a Nord per frequentare un’università d’élite, l’ingresso tramite matrimonio in una delle famiglie più prestigiose d’Italia, il contratto con una casa editrice di Milano.

È nel corso del terzo libro, e quindi nei tardi anni Sessanta, che questa ideologia viene messa in discussione. La storia della protagonista è in questo perfettamente parallela alla storia mondiale: proprio in quel periodo non solo l’egemonia americana ma anche il marxismo ortodosso vengono attaccati contemporaneamente da più fronti. Le grandi narrazioni universaliste che avevano promesso un futuro di emancipazione per tutti – un paradiso in terra raggiungibile attraverso la costanza del progresso o della lotta – sembrano ora soltanto uno scaltro camuffamento per giustificare il dominio di un piccolo gruppo di maschi bianchi sul resto del mondo. La rivoluzione del Sessantotto segna l’emergere di quei gruppi (minoritari per identità sessuale e di genere o per etnia) le cui cause erano state accantonate in nome dell’unica lotta “giusta” della modernità. Questi gruppi, tra cui appunto il femminismo, insistono sull’equivalenza di tutte le lotte e oppongono all’universalismo della razionalità scientifica la sensibilità della propria esperienza particolare. In una formula nota, rifiutano il “globale” in nome del “locale”.
Nel terzo volume dell’Amica geniale Elena abbraccia le ragioni di questa rivoluzione, facendo propria la prospettiva femminista sul mondo. La coltissima cognata Mariarosa diventa ora un modello sconcertante di “ritorno al locale”, con il suo linguaggio sboccato simile a quello che Elena aveva faticato tanto per dimenticare (“Lila non aveva mai cessato di parlare così; e io cosa dovevo fare, ridiventare come lei, tornare al punto di partenza?”, Storia di chi fugge e chi resta, p. 231). Ma ancora più importante è il momento in cui Elena legge Carla Lonzi e si convince della necessità di disimparare: “Sputare su Hegel. Sputare sulla cultura degli uomini, sputare su Marx, su Engels, su Lenin. […] Deculturalizzarsi” (Storia di chi fugge e di chi resta, p. 254). E se l’educazione ricevuta fino a quel momento aveva portato Elena dalla periferia verso il centro, la decostruzione femminista la riporta a vivere prima a Napoli e infine nello stesso rione in cui è nata.
Il ritorno alle origini è però soprattutto un ritorno a Lila, l’autodidatta per eccellenza che non si allontana mai da Napoli e che parla in dialetto pur padroneggiando un ottimo italiano; l’amica geniale che ha solo la quinta elementare ma apre con il compagno Enzo Scanno il centro IBM più avanzato d’Italia, dimostrando con la propria vita la falsità della narrazione lineare del mondo. Sono infatti i quaderni di Lila, che Elena legge nel 1966, a instillare nella protagonista il dubbio che la meritocrazia dell’università sia solo di facciata e a farla diventare insofferente verso la propria carriera. Lila, che possiede istintivamente una verità locale e quindi femminista, svilisce sistematicamente tutto ciò che Elena considera come successo. Ad esempio, quando Elena pubblica il suo primo romanzo e va a trovare l’amica in quel “rivolo del tempo passato” che è San Giovanni a Teduccio, l’incontro è deludente, e la protagonista deve ammettere di essere arrivata “piena di superbia” in quella periferia degradata solo per mostrare all’amica “ciò che lei aveva perso e ciò che io avevo vinto.” Lila le spiega invece che “che al mondo non c’era alcunché da vincere,” che la vita è un insieme di “avventure diverse e scriteriate” e che “il tempo semplicemente scivolava via senza alcun senso, ed era bello solo vedersi ogni tanto per sentire il suono folle del cervello dell’una echeggiare dentro il suono folle del cervello dell’altra” (Storia del nuovo cognome, p. 464).
In quel momento Elena rifiuta la visione del mondo folle e caotica di Lila. È solo dopo il Sessantotto che la periferia diventa ideologicamente il posto “giusto,” e la protagonista accetta la verità anti progressista e anti globalista dell’amica. La storia del mondo, come quella di Napoli a cui Lila si appassiona, è fatta di cicli imprevedibili di distruzione, un flusso di “onde, calma piatta, rovesci, cascate” (Storia della bambina perduta, p. 418). Il problema non è più fuggire dalla periferia, perché tutti i luoghi del mondo sono anelli di un’unica catena, e “non è il rione a essere malato, non è Napoli, è il globo terrestre […]. E l’abilità consiste nel nascondere e nascondersi lo stato vero delle cose” (Storia di chi fugge e di chi resta, p. 19). Lila – come riconosce Elena in vecchiaia – “aveva capito tutto da ragazzina, senza mai muoversi da Napoli”.
La tetralogia di Ferrante, spesso sminuita come edulcorato global novel che attrae il pubblico anglofono per la propria ambientazione esotica, dà quindi al locale un ben diverso spessore: la periferia è il luogo privilegiato da cui guardare il mondo perché le menzogne globaliste sono lì messe in crisi da un’irriducibile realtà amorfa. E se questa visione particolare può essere compresa universalmente e diventare un successo globale è perché rispecchia una consapevolezza ormai condivisa che il Sessantotto e il movimento femminista hanno contribuito a creare.