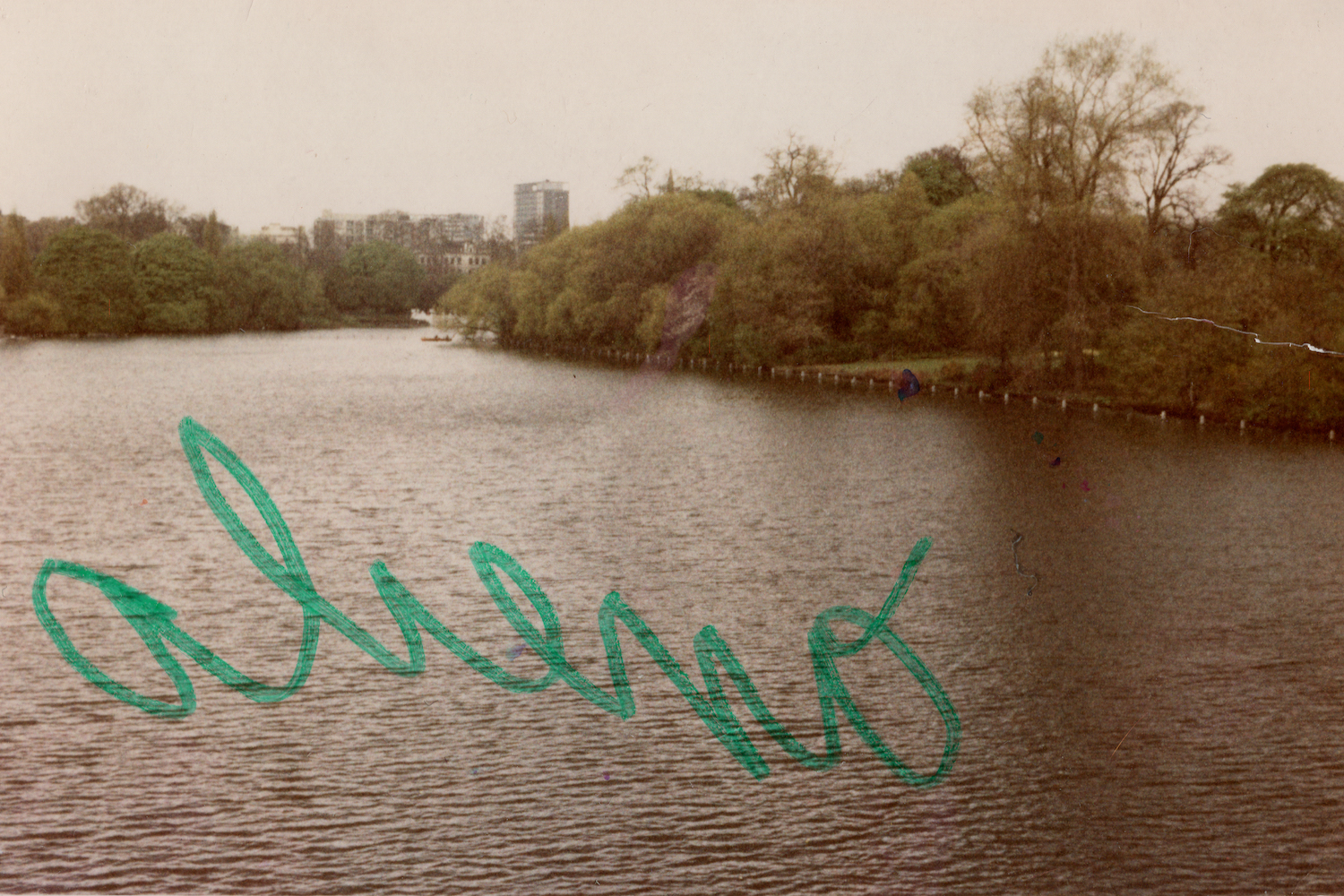In una fotografia in bianco e nero Emilio Prini scriveva con una Olivetti Lettera 45 al centro di Is space bent or straight? (1967), l’igloo con lo scheletro di ferro e la calotta a moduli di vetro di Mario Merz, che concentrato lo osservava da fuori.
È una delle immagini, questa, in grado di raccontare l’amicizia fra i due artisti e una di quelle che ha ispirato Timotea Prini e Beatrice Merz per la mostra che la Fondazione Merz ha dedicato al lavoro di Emilio Prini, con un corpo di quaranta opere del periodo tra il 1967 e il 2016.
È un’occasione speciale e molto attesa per indagare un artista dalla poliedricità espansa, definito in vita enigmatico, schivo, sfuggente, ingannevole, elusivo e criptico.
L’arte di Prini non si ossida in linguaggi determinati ma, sempre a rischio di smaterializzazione, porta avanti la distruzione dell’oggetto artistico come un gioco molto serio.
La presenza in mostra di lavori di Mario e Marisa Merz restituisce una dimensione emotiva forte nella forma di dialoghi sottilissimi, che si concretizzano di sala in sala, tra le loro attitudini, il loro pensiero.
Se il Bicchiere trapassato (1967) di Mario Merz è la dichiarazione di un agire distruttivo nei confronti degli oggetti, come unica possibilità per trasformarli in qualcosa di diverso, per Prini gli studi dello spazio attraverso il calco sono l’unica possibilità di (ri)produzione artistica, che rileva il reale e lo imprime in una visione nuova.
Il calco è il mezzo con cui rivedere, e rileggere in maniera ogni volta diversa, la realtà di uno spazio, sia esso quello della città di Genova (Muro in curva e Strada franata, 1967-1995) o quello di un foglio vuoto (Manifesto Bianco, 1980).
Prini procede per sottrazione, che è fisica quando elimina gli oggetti dallo spazio, e lo disegna attraverso scatti sonori e intermittenti di luci al neon (Perimetro d’aria, 1967), e che in La Pimpa e il Vuoto (2008) diventa narrativa, attraverso lo svuotamento del colore, la decontestualizzazione delle immagini e la sostituzione delle parole.
Il suo è un agire che si concretizza intorno alla negazione, all’elusione e quindi al vuoto vissuto come più pieno, alimentato da una pratica costante della contraddizione e del dubbio. Il cartello del film non fatto (1967-1968) ne è il manifesto.
La pratica del ricalcare porta con sé anche un’idea di consunzione, molto chiara nell’uso che Prini fa del mezzo fotografico, e il dittico di stampe con fondo oro del 1969 è emblematico in questo senso. La fotografia di una macchina fotografica è affiancata da diversi strumenti tecnologici molto cari all’artista (macchina da scrivere, registratore, proiettore e videocamera). Le due stampe sono la traccia del tentativo operato da Prini di usare questi strumenti in maniera estenuante fino alla smaterializzazione delle specifiche forme di registrazione audio video in immagini e scritti, e del completo logorio della tecnologia usata. Con un riferimento chiaro al consumismo, Prini porta anche avanti una riflessione sulla deperibilità del mezzo e dell’oggetto artistico.
Una coscienza che sorride al lavoro di Marisa Merz, che ha incarnato nelle sue opere l’ordine effimero delle cose, nella loro mobilità e fragilità come condizione stessa dell’esistenza, di cui Prini mette in salvo soltanto una traccia, un’impressione da consegnare al tempo.