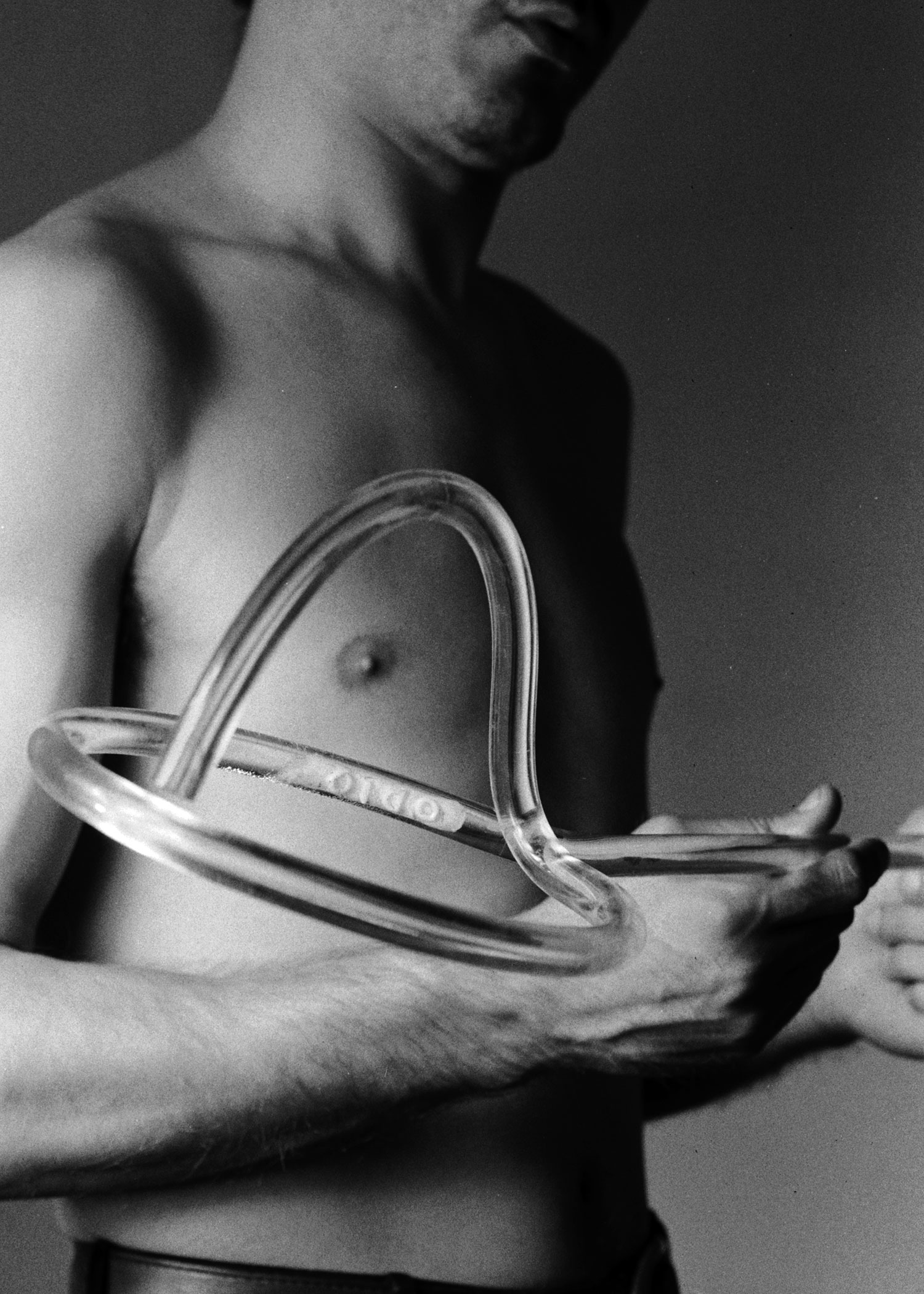Vidi per la prima volta i quadri tridimensionali di Enrico Castellani alla Biennale di San Marino del 1963, che segnava una svolta decisiva nel superamento delle ambiguità pittoriche del persistente Informale. A un solo anno di distanza da quella presentazione, Castellani già si affermava sulla scena internazionale grazie alla partecipazione a due esposizioni collettive al Guggenheim di New York e alla Biennale di Venezia, nonché a “The Responsive Eye”, seminale mostra del MoMA (1965) dedicata alle tendenze Optical – anche se in quell’ambito si capì subito come l’oggettualità programmata dell’opera di Castellani era più connessa all’essenzialità minimale che alla giocosità di quel movimento.
Un altro versante della ricerca castellaniana emerse nella mostra del 1967 “Lo spazio dell’immagine”, a Palazzo Trinci di Foligno, dove nell’Ambiente bianco Castellani inglobò la dimensione architettonica che gli era congeniale, avendo egli conseguito una laurea in architettura. Nel 1969, quando con Gillo Dorfles e Filiberto Menna curai l’VIII Biennale di San Benedetto del Tronto, intitolata “Al di là della pittura”, che dava spazio alle nuove esperienze di discipline creative limitrofe all’arte, tra gli artisti invitati avrei voluto che ci fosse anche Castellani, che però in quel periodo di contestazioni evitava di esporre perché concentrato sull’impegno civile: l’artista aveva assunto la posizione dell’intellettuale responsabile che aspirava a profondi cambiamenti del sistema socio-culturale, proseguendo l’azione controcorrente iniziata nel 1959, con Piero Manzoni, sulle pagine della rivista Azimuth.
Nella primavera del 2001, quando Castellani viveva già appartato a Celleno, nella Tuscia, gli chiesi un’intervista, ma tergiversò: “Ho sempre trovato qualche difficoltà e una certa noia a parlare di me e del mio lavoro; ora con il passare del tempo e l’inevitabile storicizzazione di un periodo lo trovo anche inutile”. Ricordandogli i nostri trascorsi dal 1967, riuscii a convincerlo ed ebbi modo di rivolgergli soprattutto domande che potevano provocare risposte su certi moventi fondanti della sua opera. Non si sottrasse, anzi si espresse con generosità, senza derogare dall’abituale sobrietà.
Tra le tante sue esposizioni degli ultimi tempi va citata l’esemplare personale (con opere molto differenziate del passato e altre più recenti) del 2016 alla Dominique Levy Gallery di New York – basata sulle possibilità della pittura di occupare lo spazio, fondendo forma e concetto – e il suggestivo Spazio Ambiente, totalmente bianco, nell’esatta ricostruzione di quello del 1970, che si imponeva con silenziosa eleganza nel rumoroso gigantismo della sezione “Unlimited” di Art Basel 2017.
A uno sguardo retrospettivo si può dire che nella seconda metà degli anni Sessanta, con il revisionismo dettato dall’Arte povera e dall’Arte concettuale, Castellani – sebbene vi fosse una sostanziale incompatibilità tra la sua progettualità razionale e l’esasperata soggettività dei poveristi e dei concettuali in ascesa – veniva collocato in area neutrale per l’autorevole individualità. A Castellani furono riconosciuti tutti i valori della sua moderna classicità: l’alta qualità dell’opera, compiuta e al tempo stesso indefinita; la fedeltà alla metodologia teorico-pratica; la capacità di visualizzare un processo mentale in costante tensione verso l’assoluto.
Nel contesto culturale di oggi le opere di Castellani non hanno lo stesso impatto della fase in cui egli andava definendo le coordinate della sua identità. Tuttavia, il rigore operativo e l’indiscutibile raffinatezza estetica (tutt’altro che rappresentativa e priva di intenzionalità ideologiche) le idealizzano, conferendo loro totale autonomia e perfino valenza etica. Anche da questo punto di vista la loro qualità pittorico-plastica, dalla “ripetizione differente”, così strutturale e insieme sensibile, risulta sottilmente propositiva.
Castellani, dunque, è riuscito a oltrepassare, con naturalezza e consapevolezza, le convenzioni linguistiche delle neoavanguardie, a essere al di sopra della realtà quotidiana privilegiando il senso e l’essenza, la sapienza artigianale e la purezza, i bisogni spirituali ancorché non dichiarati. Dopo tanti anni le calibrate e armoniose tele monocromatiche dalle estroflessioni ritmiche resistono alle mutazioni del gusto, anche perché evidenziano un’eccezionale corrispondenza tra gli elementi costitutivi dell’opera e le caratteristiche dell’autore. Alludo, in primis, alla geniale semplicità, alla riservatezza e al candore dell’uomo, del quale sentiamo più forte la mancanza.