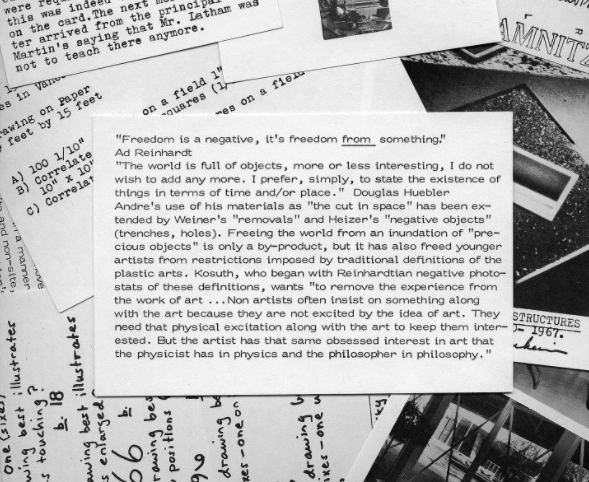Questo testo del noto scrittore Aldo Busi, nella sua forma e nei contenuti, non è condiviso dalla redazione di Flash Art. Come pure le opere del giovane artista. Ma Flash Art ama la diversità e la dialettica delle contraddizioni. Per questo, pur prendendone le debite distanze, lo pubblica volentieri, affidandone il giudizio finale ai propri lettori.
Giancarlo Politi
Fabio Romano! Alla luce di certi miei ultimi scontri con una nota mancata artista presto centenaria, peraltro tecnicamente di notevole talento, mi si è fatta più chiara l’identità ideale dell’artista, l’ideale al quale io mi sono ispirato e indefessamente tenuto in tutti questi decenni, e ancor più quando apparivo in programmi televisivi che di artistico, se erano interessanti e di sicuro successo più grazie alla mia presenza che a quella altrui, non avevano nulla, a parte, per l’appunto, me, che restavo io e non cambiavo di “una virgola” neanche lì, contesto in cui nessun testo ha valore, rilevanza, “identità”, e in cui le teste presentate all’utenza dai pixel giocano un ruolo infinitamente meno importante dello sfondo e del linoleum per terra. Ma l’effimero televisivo è ben più informante della contemplazione della Cappella degli Scrovegni, e avere la meglio sul primo, che detta la grana della democrazia possibile in un Paese di analfabeti per vocazione, è infinitamente più difficile che non farsi sopraffare dalla seconda, che spariglia solo l’estetica tra permanente e transeunte e mai per più di dieci aristogatti per volta.
Proprio come da un punto di vista formale (che da solo non sta in piedi, ma è giusto per intenderci) l’artista è colui che toglie anziché aggiungere, così da un punto di vista esistenziale l’artista è colui che mette tutta la sua vita nella sua opera, non nella sua vita, cioè colui che sottrae dalla sua vita tutto ciò che lo allontana dalla sua opera, ovverossia gli orpelli sociali, mondani, economici, diciamo onorifici, di riconoscimento pubblico immediato, sincronico alla biografia dei suoi bisogni materiali e immateriali, cioè alle sue psicotiche vanità di eterno bambino ancora in vita che vuole richiamare l’attenzione su di sé anche se sta facendo solo un’altra cacca nel solito vasino che per lui, il divino donatore, è una rara e insostituibile pioggia di ambra.

Una volta, anni fa e di nuovo l’altro ieri, dissi alla nota mancata artista, di cui peraltro sono discreto collezionista, “Tu mica stai sacrificando niente per essere un artista”, e lei mi rispose, “Cosa mai dovrei sacrificare?”, “Qualsiasi cosa: la famiglia, i figli cui attribuisci una genialità che non sono tenuti ad avere e pertanto a conformarsene, la ricchezza da rendita parassitaria, il personale di servizio al quale dai amabilmente del tu esigendo però il ‘lei’ più timoroso, le cene nelle ambasciate, le puntate al casinò , certe amiche opusdeiste troie di regime patentate, un marito monogamico, i viaggi interplanetari già prenotati, l’istruttore di aerobica in studio per te e alcune sparute principesse, la tua ospitalità nella dimora al mare a persone scelte in base più all’allure sociale che alla concretezza intellettuale, che ti inventi tu per giustificarla, visto che sono tutti intellettuali organici a un clan e quindi di comodo, mai che tu inviti un terapista, un meccanico, una spazzina, una commessa… Stai bene attenta a non inficiare la tua ‘sicurezza’ globale acquisita e mai messa in discussione, infine. ‘Fare arte’ per te rischia di essere visto come un di più, il passatempo e la fuga di una annoiata signora di ampi mezzi, mentre io lo vedo come una ‘finzione’, inutilmente penosa, che non ti porta a dire alcuna verità fino a ora ‘irrivelata’ e nell’ambito della tua esistenza sociale e in quello, di conseguenza, della tua arte. Sei tanto brava quanto oleografica per inconscio partito preso da cui niente e nessuno potrà mai smuoverti e, contrariamente a quanto dice la Bibbia, ‘Avrai o la gloria o la gioia’, a me sembra che non hai né l’una né l’altra, perché non schiacci il pedale sino in fondo, perché galleggi tra la tua vita, poco artistica come quella di chiunque, e la tua aspirazione artistica sempre a metà che di necessità produce un’arte a metà, ovvero media, alla ricerca della massima propaganda ormai perduta. Fai troppa altalena tra i tuoi porci comodi e quelli che presupponi degli altri che pensi possano giovarti, e quando uno pensa di trovarti in un punto dell’arte, sei in un altro dell’esistenzialismo e così si smette di inseguirti. Sei talmente concentrata sulla strategia per imporla… la tua arte…che ti dimentichi che prima dovresti farla a fondo e che, prima ancora di farla, dovresti metterti in grado di essere artista fino alle estreme conseguenze… Solitudine, emarginazione, sfida del ridicolo e una presunzione celestiale e odiosa a fare da defogliante su ogni claque intenzionata ad annetterti come è stato per me. Dovresti cimentarti una volta per tutte in alcunché che non sia l’ennesima tartina al caviale con altri ingredienti per gli stessi ospiti e, si spera, critici e clienti da inchiodare al ricambio di favore”.
Be’, tanto non capì, al solito mi rispose che ero un moralista, schiavo dei miei pregiudizi populisti eccetera. A una quasi centenaria che dice che per niente al mondo rinuncerebbe ad avere una cameriera, che è fiera del fatto di essersi potuta permettere una cameriera anche nei tempi più tenebrosi (comunque sempre illuminati da grandi lampioni se non proprio da lampade Gallé e poi Barovier) e che, se cadesse in totale disgrazia, pur di averne una sarebbe disposta “a qualsiasi cosa”, parlare di “sacrificio” è come proporre un patto col diavolo in cambio dell’eterna vecchiaia però con effetto immediato. Trasforma la malafede in una scienza molecolare e disporrai della logica da passeggio più ferrea e inscalfibile.
Infine, se uno è un artista e si disperde nei meandri della strategia dell’autoaffermazione in quanto tale, tanto artista non è, sarà un artista per come si districa nelle pubbliche relazioni e per i lavori che fa all’inclita committenza del momento, non certo per l’opera che lascia. Se un artista è una pedina su una scacchiera su cui muove in entrambe le direzioni il gallerista, l’artista sarà il gallerista e l’artista un mero artigiano pompato ad arte. Vale la pena di essere artista per interposta persona? Ed è mai esistito un artista che sia stato anche il solo e unico mediatore e mercante di se stesso? Fino a che punto è arte un’arte non fruibile, non desiderabile e quindi non monetizzabile? Se l’arte è l’arte che si vende e fintanto che si vende, l’arte che non si vende non è tale e quindi non esiste un’arte fuori dal suo mercato. Che tu ti pieghi al mercato o che il mercato si pieghi a te, mi sembra una sfida, e un’ubbia a pari merito, in cui il tuo ruolo resta comunque secondario. Il rischio di diventare una marionetta mi sembra davvero alto e mi chiedo a che valga arrivare alla più alta delle altezze se essa è solo proporzionata alla lunghezza e alla ramificazioni dei fili mossi da altri. Perché purtroppo, nell’iniquo asse gallerista/artista, vale per l’arte quanto Francis Darwin scrisse (Eugenics Review, 1914) per la scienza: “Il merito se lo prende chi convince il mondo, non il primo che ha avuto l’idea”. Insomma: a Margherita le idee, la purezza d’intenti, la poesia più gratuita, a Mefistofele l’azione, i fatti, il maneggio col dio Mammona. Ma l’artista che non assume entrambi i ruoli e che non è il fatto della sua idea è, per l’appunto, un artigiano in conto vendita col valore aggiunto da un imbonitore di mestiere che spenna gli allocchi con l’omertosa complicità del farabutto che gli fornisce le esche. Resta molto da indagare nelle tenebre del desiderio del possesso se dedotto o indotto: uno compra un quadro del tale (parliamo di arte contemporanea svincolata da ogni parametro di bellezza oggettivo, non certo di quella di un Tintoretto o di ogni altra, anche moderna, già storicizzata) o perché gli è venduto dal tale? Io, nell’incertezza, preferirei impagliare le sedie e insisterei affinché non costassero mai e poi mai un centesimo in più di quanto costa una comune sedia impagliata.

A forza di pensare al mio passato, vedo, per esempio, che, come inevitabilmente ero latino-eurocentrico e pensavo che la culla della civiltà fosse la Grecia perché, come tuttora penso, la più grande e unica vera letteratura nasce da lì (ma chi se ne frega della letteratura, mica è l’unico parametro per giudicare una civiltà! I cinesi duemila anni fa avevano tecniche agricole che in Occidente arrivano nell’Ottocento e gli arabi nei cosiddetti Secoli bui avevano sviluppato una matematica che resiste fino al Novecento) e sebbene sia stato di vent’anni in anticipo sulla filosofia della globalizzazione e quindi contro il mito dell’universale Superiorità dell’Occidente (di rigore greco-rinascimentale e niente più), anch’io ho dato corda da ragazzo a un tentativo di “strategia del successo”, ma molto incertamente e con nessun successo per come lo si intende, perché non ci credevo, non volevo disperdermi, non volevo modificarmi, non volevo permettere e permettermi, ecco, di manipolare la mia psiche scritturale (ecco perché, allorché pubblico il primo romanzo, ne ho altri tre già pronti nel cassetto, e questo da uno senza scolarizzazione che lavorava per campare e che proveniva da una famiglia povera, per certi versi meschina, che gli dava del magna a sbafo perché non aveva interrotto gli studi alla quinta elementare e s’era messo ad andare addirittura alle medie; insomma: a me di frequentare “gli ambienti giusti” nemmeno passava per la testa, e se li avessi anche solo sfiorati un minuto di troppo per “promuovermi”, non avrei certo potuto e lavorare per mantenermi di giorno e scrivere tutte quelle migliaia di pagine di notte), e anche dopo la pubblicazione dei primi due romanzi, pur facendo per dovere qualche cosa per l’ufficio stampa dell’editore, ogni vera e pianificata strategia “di mercato” mi è rimasta aliena; per esempio, l’editore mi diceva, “Devi scrivere su un giornale a tiratura nazionale, non c’è direttore che non ti accoglierebbe a braccia aperte… tu scrivi lì sopra e ogni volta che pubblichi un libro, hai un trattamento di favore, recensito subito e positivissimamente”: mai fatto per due settimane di fila, alla prima censura di una virgola me li toglievo tutti dai piedi, tirandomi contro il loro odio e, di conseguenza, la loro indifferenza e astiosa sufficienza verso la mia opera di pubblicazione in pubblicazione. Era più forte di me: non provavo che disprezzo verso un’accoglienza “critica” falsata alla base dal fatto di appartenere a una confraternita autoprotezionista, la cosa avrebbe avuto un senso se, in quel dato contesto giornalistico-politico in cui mi fossi trovato, si fosse usata la recensione per stroncare un mio romanzo, se se lo fosse meritato, ma ciò era ed è impensabile, e una lode per principio mi dava sola nausea, ne avrei sentito lo sporco addosso per secoli.
Anche la non strategia sarà una strategia a lungo, lunghissimo andare, ma di certo io non mi sono mai messo su alcun trenino altrui e la mia meta, visibile o invisibile, è restata mia. Non è che mi abbiano scaraventato giù, anzi, mi davano pure il sedile imbottito di ermellino: ho tirato io il freno d’allarme sempre in tempo e sono sceso.
Man mano che maturavo o, meglio, che disintroiettavo i luoghi comuni ricevuti col latte materno e sempre più mi allontanavo dal complesso di inferiorità del proletario povero, cattivo e frustrato nato, sempre meno importanza ho dato al contesto (al luogo eletto in cui, meschinizzandomi, potevo scrivere di tanto in tanto un articolo per avere in cambio paginate di apprezzamenti dopati), perché per me il mio testo (la mia opera letteraria organica e predeterminata nella mia psiche emotiva e volontà civile inamovibile nel suo stesso divenire) era tutto e non permettevo che venisse dimezzata di una sola virgola… Ma ci sono parti del discorso anche minori, quale la virgola omessa per alterare o ribaltare il senso dell’enunciato, figuriamoci una frase o un concetto o una formulazione.

Infine, la scelta era presto fatta: a un contesto in cui, per dire il mio pensiero nella mia forma, dovevo adeguare forma e pensiero al dettato del padrone del medesimo contesto, ho sempre preferito il mio testo — il mio pensiero nella sua forma integrale da me decisa, non dico totalmente senza autocensure, che sono inconsapevoli e di cui prendi coscienza e te ne liberi solo col tempo (mentre altre si installano a tua insaputa), ma di sicuro senza tenere conto a priori della censura esterna cui sarei stato vincolato per stare in quel dato contesto, il quale, se non avessi provveduto da me all’autocensura, a censurarmi ci avrebbe pensato da solo — “d’ufficio”, contrazione pur sempre di Sant’Uffizio.
Tuttavia, io ho quasi il triplo dei tuoi anni e i modi attuali di appropriazione del sapere rispetto alla proprie ambizioni sono completamente diversi — e molto più ambigui e infidi e inaffidabili — dai miei alla tua età, e non devi prendere niente alla lettera, ma non è il mio il peana alla vanità del tutto del debosciato stressato che ha avuto fin troppo, perché a me sembra di averlo avuto per meccanicità del caso, non mi ci sono affatto spaccato la testa a rischio di venderla a pezzetti al miglior offerente. Ti sto solo dicendo che io la mia vita di “artista totale” me la sono goduta e me la godo pienamente, ecco tutto, che sono rimasto un artista e della vita e dell’opera, un artista organico al mio esserci sulla Terra, senza schizofrenie a discapito o a preferenza di una parte sull’altra. Non ho mai messo il mio essere scrittore a servizio di me uomo, sempre viceversa, ecco. Se qualcosa mi conviene personalmente o mi diletta sessualmente ma urta la mia estetica civile, mi urta e mi ripugna e non mi conviene affatto. Come se fossi stato un pittore o un fotografo non avrei mai attirato nel mio letto qualcuno con la scusa di fargli il ritratto, così non ho mai una sola volta acconsentito a trasformare la mia opera nella pania per incollare un lettore al muro.
L’ho scritto: pensaci in tempo al tuo passato, e il futuro verrà da sé nel tuo stesso presente.
Del resto, fosti tu stesso, a quella cena in piedi in quella casa romana domotico-babilonese, a farmi notare come se ne stessero lividi, infelici e “arrivati” senza niente da dire (e senza più nessuno disposto ad ascoltare la loro tiritera sulla loro ultima mostra perché altro argomento, tipo l’ultima volta che hanno fatto un esame di coscienza, non troverebbero mai) due dei più considerati artisti italiani aggiungendo, “Io non voglio ‘arrivare’ se poi devo ridurmi così. Guarda come si spegne quello quando non deve più posare da san-Giuseppe-falegname perché nessuno se lo fila. E quell’altro, il panzone ubriaco fradicio che ridacchia a crepapelle senza un perché e senza convinzione? Ce ne vuole per spanciarsi dalle risate senza convinzione”, “È la sua forma di salamelecco per ingraziarsi gli ottusi d’alto bordo affinché continuino a credersi irresistibilmente spiritosi”, “ E guardali adesso come guardano nel vuoto!”, “Bella forza, stanno guardandosi dentro”.

Stavano facendo quello che ci si aspettava da loro: le belle statuine Glorietta e Gioietta nel presepio predispostogli da altri. Ma io stavo pensando ad altro, cioè mi preoccupavo per te, perché non capivo se c’era o no abbastanza invidia nelle tue parole o se, peggio, non ce n’era proprio: con chi ti saresti misurato allora? Ma basta, lo saprai tu e ti regolerai come ti pare o come potrai con gli inchini dovuti o negati. Magari ti sentirai importante anche solo per le umiliazioni che ti verranno elargite dal tuo contesto mercantile di riferimento: il masochismo, come apre le porte dei calendari, apre anche quelle dei Guggenheim e delle Tate Gallery.
A me, se mai mi ha interessato, da decenni e decenni non interessa più dove cade un mio pensiero e nemmeno se ha un posto in cui cadere: non è il posto-contesto che lo fa accadere, il mio pensiero-testo è già accaduto in sé, qualcuno lo raccoglierà, anche se lo butto nella carta straccia chiamata “archivio” — roba per i posteri, figuriamoci. Posteri per un po’ lo siamo tutti, se siamo almeno bibliograficamente intelligenti e grati a chi ci ha preceduto per tutto quanto ci ha lasciato da leggere, e a questi io mi rivolgo, ai posteri-contemporanei, i soli vivi in grado di capire il possibile grado di una verità estetica e quindi di civiltà raggiunto da un Artista o da uno Scrittore, che sia morto o addirittura vivo.
Se fosse per i contemporanei-contemporanei, tanto varrebbe per te fare l’arredatore di interni e per me l’azzeccaslogan in un’agenzia di pubblicità.