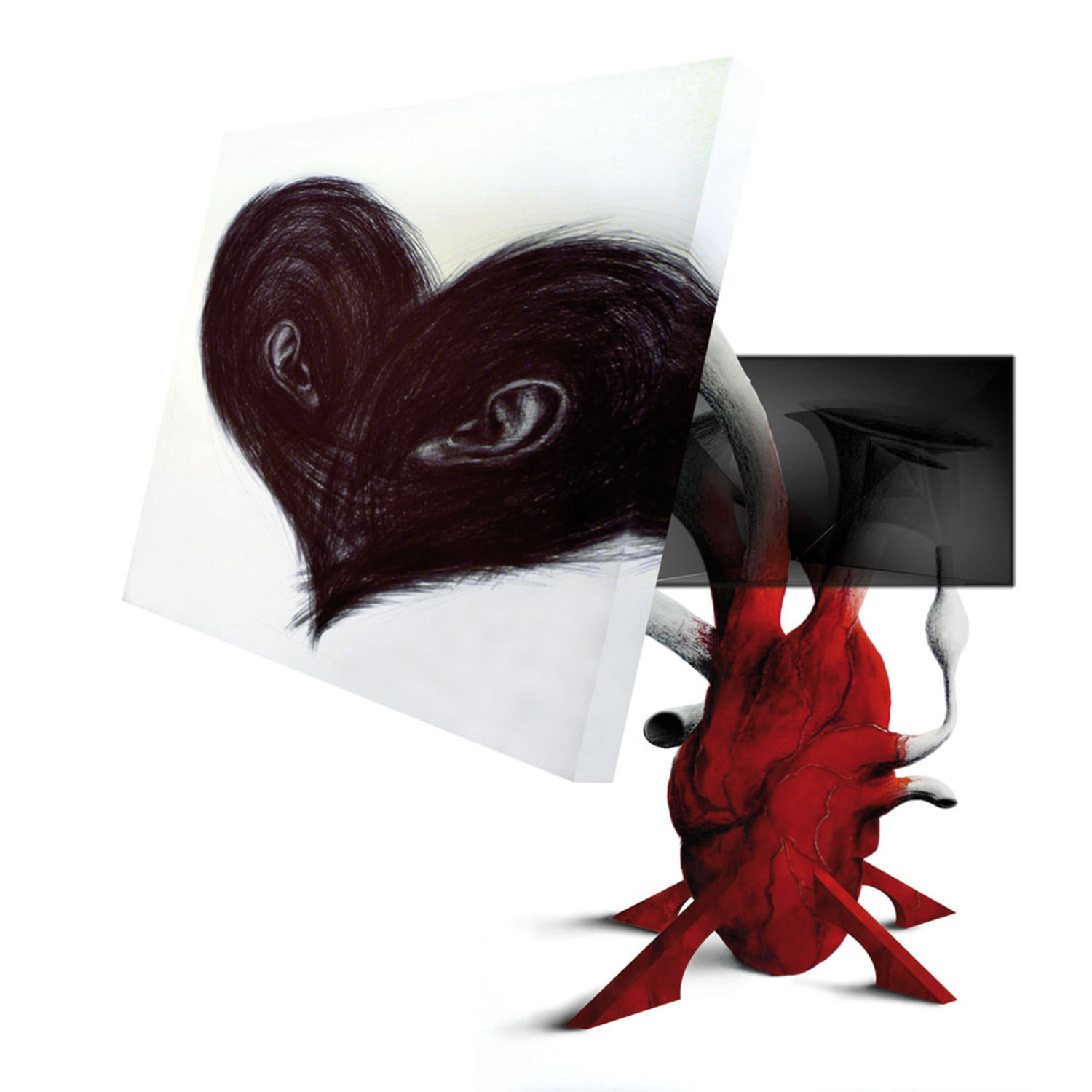Giancarlo Politi: Oggi che tipo di sviluppo e lettura delle tue opere ci puoi indicare? Da vent’anni a questa parte c’è stato un cambiamento? Di che genere?
Ettore Spalletti: Ricordo che per il mio primo catalogo ho mischiato le immagini di tutti i lavori senza tenere in considerazione l’anno di realizzazione, proprio per sottrarmi all’idea di tempo. È difficile fare una distinzione tra i lavori degli anni Settanta e quelli di oggi, perché li conservo tutti con molta cura; per me è come se non fossero mai finiti. Le opere vivono molto più di noi. Credo che la luce sia un elemento fondamentale, mi dà la sensazione di poter accostare opere diverse. Tutte le mattine, entrando in studio, provo un senso di meraviglia nel guardarle. Le trovo sempre diverse rispetto al giorno prima. Questa è, in sintesi, la storia di tutto il mio lavoro.
GP: Il tuo approccio nei confronti del quadro si è modificato? In che modo?
ES: Non c’è stato un cambiamento, forse un approfondimento.
GP: Quindi il processo della creazione di un’opera è uguale a quello degli esordi?
ES: All’inizio ero molto timido. Poi, con il passare del tempo, amicizie e incontri mi hanno dato forza. Il quadro, la superficie e l’oggetto sono tutti elementi che richiedono un tempo di lavorazione molto lungo. Dopo aver dipinto per dieci giorni e aver controllato i tempi di essiccazione, si passa all’abrasione. In questa fase i pigmenti si rompono e viene fuori il colore. Prima non riuscivo a capire le tonalità che avrei ottenuto alla fine, ma ora, dopo quarant’anni di lavoro, so sempre cosa mi restituirà il processo. Di solito uso l’azzurro, il rosa e il grigio, colori che non esistono in natura. Il primo è un colore atmosferico. Uso sempre azzurri diversi e anche poche gocce di cobalto orientano il colore. Il rosa è il colore dell’incarnato e il grigio, infine, ha la capacità di accogliere tutti gli altri colori. Dentro tutti i miei colori si trova il bianco. La superficie restituisce una leggera polvere bianca che viene dall’interno.
GP: Il tuo lavoro è sempre stato caratterizzato da una certa fragilità, forse quella della vita umana. Anche fi sicamente appare molto fragile. Nel tempo si è rafforzato? E tu, ti sei rafforzato?
ES: Il mio lavoro ora non ha più bisogno di me. Si è liberato dell’artista, e questo mi dà sicurezza. Conosce la luce dello spazio e sa come esporsi. Per esempio, all’Henry Moore Institute ho vissuto una bella esperienza. La direttrice del museo è riuscita ad allestire la mostra senza di me, prima del mio arrivo.
GP: Di fronte all’opera ti poni sempre con lo stesso entusiasmo?
ES: Certo, ogni volta che inizio un lavoro provo la stessa emozione dei primi anni. Vivo nel mio studio anche quando non lavoro.
GP: Ti fa piacere lavorare? Enzo Cucchi dice di soffrire quando lavora.
ES: Se soffrissi, sicuramente non farei arte. La prima cosa che faccio la mattina è andare nel mio studio. Mi piace vederlo con colori e luci sempre nuovi: essere accolto.
GP: La tua giornata come si svolge?
ES: Mi sveglio tardi perché mi addormento tardi. Poi resto in studio tutto il giorno e la sera ceno con gli amici di sempre. Dopo torno a casa, leggo un po’ con un disegno di Giorgio Morandi che mi tiene compagnia. Credo che l’intimità sia l’unica cosa che ti libera e ti rende forte.
GP: Sei abituato a vivere una vita da grande solitario. I luoghi diversi dal tuo ti mettono a disagio?
ES: Semplicemente, credo che la pratica del viaggio non mi appartenga, a differenza di tanti altri artisti.
GP: Hai qualche rimpianto?
ES: Sì, rimpiango alcune cose di cui forse non saprei nemmeno parlarti. Per il futuro mi piacerebbe realizzare una sorta di piccolo paese dentro un capannone. Ricreare uno spazio simile a quelli rinascimentali, in cui poter essere attorniato dalle opere.
GP: Credi che avresti potuto vivere in una grande metropoli come New York?
ES: Non lo so. Quando ho presentato la mostra a New York, ho pensato di trasferirmi lì. Per me era tutto faticoso, anche attraversare la strada. Tempo fa avrei voluto vivere a Lucca ma, pur avendo comprato una casa lì, non mi sono mai trasferito. Secondo De Dominicis, Lucca per me era già una metropoli.
GP: Lavori tutti i giorni?
ES: Sì, anche quando sono a casa. Mi piace spostare le cose e ricomporle.
GP: Qual è il punto di partenza per creare un’opera?
ES: Sento la forza dell’immagine che è dentro di me e cerco di restituirle tutti i valori del colore. In mostra invece hanno importanza altre componenti, in particolare lo spazio e la luce.
GP: Parti da un progetto, da un disegno o da un oggetto fisico?
ES: All’inizio ho un desiderio e prendo degli appunti. Partendo da un disegno, in linea di massima so quale sarà l’opera fi nale. Anche se possono verifi carsi degli errori. D’altra parte, il lavoro è un percorso modifi cabile con il tempo.
GP: Lavori su più opere contemporaneamente? Intendo dire in serie.
ES: Sì, c’è spesso una relazione tra un’opera e l’altra. I colori si dispongono, anche se su tavole diverse, uno dopo l’altro, come in un grande affresco. A volte la relazione si interrompe, ma credo che un’opera da sola si offra più facilmente alla contemplazione che alla spettacolarizzazione.

GP: Nasce prima il colore o la forma?
ES: Nascono contemporaneamente. Quando vado dal falegname per far tagliare il legno ho già in mente il colore che userò. Le forme sono costruite tutte geometricamente. Il colore che nutre la forma rompe la geometria. Quando uso l’alabastro sono affascinato dal desiderio che esprime la pietra di sciogliersi da un momento all’altro e tornare a essere acqua.
GP: Come nasce la forma? Sulla base dell’idea di una mostra?
ES: Quelle colonnine che vedi lì, per esempio, sono nate dall’idea di creare una forma che contenesse tutte le linee geometriche. L’idea era quella di poter tagliare la pietra e trovarci dentro il colore.
GP: Quei due quadri azzurri sono nati come dittico?
ES: No, ma effettivamente stanno bene insieme. Questo succede quando i colori vengono uno dopo l’altro. L’arte contemporanea, secondo me, si assume la responsabilità dello spazio, a differenza di quella antica, in cui esso viene delimitato dalla cornice.
GP: Quando un’opera è completa secondo te? Anche qui possiamo parlare di caso?
ES: L’opera per me si rivela, se riuscita, nell’istante fi nale in cui l’abrasione libera i pigmenti di colore sulla tavola. A volte un quadro sembra finito, poi però, se lo sposti e lo metti tra gli alabastri, per esempio, acquista un altro valore.

GP: Ti è capitato di provare emozioni diverse o di rimanere deluso guardando un tuo quadro fuori dallo studio?
ES: Certo, è un problema di attenzione e di cura nei confronti delle opere. Alcune opere sono conservate per il piacere di possederle e saperle vedere, altre volte sono tenute in cantina. In questi casi si tratta di un percorso economico, niente di più.
GP: Come mai hai deciso di fare il pittore?
ES: Non ho deciso, andavo a scuola perché costretto da mio padre. Frequentavo il liceo artistico e spesso la mattina, anziché seguire le lezioni, preferivo andare al mare. Il preside poi mi veniva a cercare lì per riportarmi a scuola. Quando ero ancora giovane, ho incontrato Mario Pieroni e Lucrezia De Domizio Durini, che discutevano spesso d’arte con Getulio Alviani. Si profilava l’idea delle gallerie. D’altra parte, l’unica cosa che c’era a Pescara era l’edicola di Cesare Manzo. Lui si occupava già di arte e ci faceva sempre leggere riviste e libri di settore. Allora era già malato d’arte, una bellissima malattia.
GP: Quindi, in un certo senso, queste persone che si occupavano d’arte ti hanno aiutato?
ES: Ci siamo aiutati a vicenda. Mi pare che la galleria di Cesare Manzo sia stata una delle prime a Pescara. Poi c’era anche la casa al mare di Lucrezia, dove si organizzavano alcune mostre. In seguito le gallerie si sono trasferite in via delle Caserme, una vecchia strada della città, allora abitata da soli artigiani.
GP: Quali sono stati gli artisti che hanno influenzato il tuo percorso?
ES: Sicuramente Elio Di Blasio, il mio professore del liceo artistico. Mi portava con la sua Bianchina alla Biennale di Venezia. Qualche tempo dopo ho conosciuto Jannis Kounellis, che comprò casa vicino alla mia. Mangiavamo insieme e mi raccontava, disegnando su alcuni fogli di carta, le sue mostre. A Roma, invece, ho conosciuto Pino Pascali. I miei amici, quelli che ho frequentato di più, sono stati Gino De Dominicis ed Emilio Prini. La sera, dopo cena, ci incontravamo sempre, anche senza concordare un appuntamento.
GP: Quali artisti hanno caratterizzato la tua giovinezza?
ES: A scuola mi parlavano di Michelangelo e Leonardo. Non capivo, a me piaceva molto di più Raffaello. Ho amato anche Masaccio, Jan Vermeer e Caspar David Friedrich. Ho amato Morandi e la tela 70 x 100 di Fontana con un solo taglio centrale. Ricordo quando ho visto il primo quadro di De Dominicis alla Galleria Sperone. Ne sono rimasto molto colpito. L’opera non aveva bisogno di nient’altro. Nel ’92 a Kassel ho incontrato nella mia sala Brice Marden, che indicava il mio lavoro con un titolo figurativo: Annunciazione. Con Lothar Baumgarten invece, che esponeva in una sala vicina, decidemmo di far dialogare le nostre opere. Lothar è ancora un caro amico. Con Haim Steinbach ho lavorato al Guggenheim di New York e con Joseph Kosuth a Pescara, accanto a un lavoro di Morandi.
GP: Quali sono i tuoi prossimi progetti?
ES: Ho in mente un piccolo progetto che per certi versi interesserà l’architettura. Non ne parlo ora. Presto vi inviterò tutti.
GP: Il tuo percorso è stato molto intenso. Dal Liceo Misticoni a oggi hai vissuto molte esperienze. Parlamene.
ES: Sì, l’esperienza a Pescara è stata molto bella. In quel liceo abitava l’amore per l’arte. Il liceo, in origine, è nato a casa di Giuseppe Misticoni. Mi dispiace che la città non gli sia abbastanza grata. Adesso posso dirti che il mio lavoro si basa sulla rifl essione. Quando hai meno forza fi sica capita di avere più forza mentale e di stare più a lungo affacciato alla fi nestra a pensare.
GP: Oggi, quando visiti una mostra, ti appassioni guardando qualche giovane artista italiano o internazionale?
ES: Non lo so. Nel 1997, alla Biennale di Venezia di Germano Celant, insieme a me e a Enzo Cucchi c’era Maurizio Cattelan. Mi piaceva avere accanto Maurizio, ma mi accorgevo di quanto fosse diverso da me come artista. Ho guardato anche il lavoro di Vanessa Beecroft. Apprezzo la sua capacità di conferire storicità all’immagine, sia che essa appartenga all’ambito della moda sia a quello della vita quotidiana. Penso alle parole del regista Takeshi Kitano, secondo cui la forza di un’immagine ben riuscita vale quanto un intero film. Francis Bacon diceva di aver avuto un unico rammarico: non essere mai riuscito a fermare l’immagine. Quella stessa immagine che aveva sempre bisogno di spazzolare e cancellare. Tempo fa ho avuto il piacere di visitare lo studio di Henry Moore. Durante il tragitto ho notato tutte le colline che stavano intorno. Vi era una scultura proprio in cima a una delle colline e il prato era gremito di pecore che brucavano l’erba. Le aveva volute lui perché amava guardarle dalla finestra con il cannocchiale. Da quel momento ho guardato con occhi diversi il suo lavoro.
GP: La tua vita quotidiana ruota attorno al lavoro oppure ogni tanto guardi la TV?
ES: Le partite di calcio mi annoiano. Solo una volta sono andato a vedere Maradona. Lo stadio era bellissimo. Seguo con piacere il ciclismo, il Giro d’Italia e il Tour de France. Prima guardavo anche alcune trasmissioni che trattavano di politica, ora non più. È difficile districarsi dalle bugie.