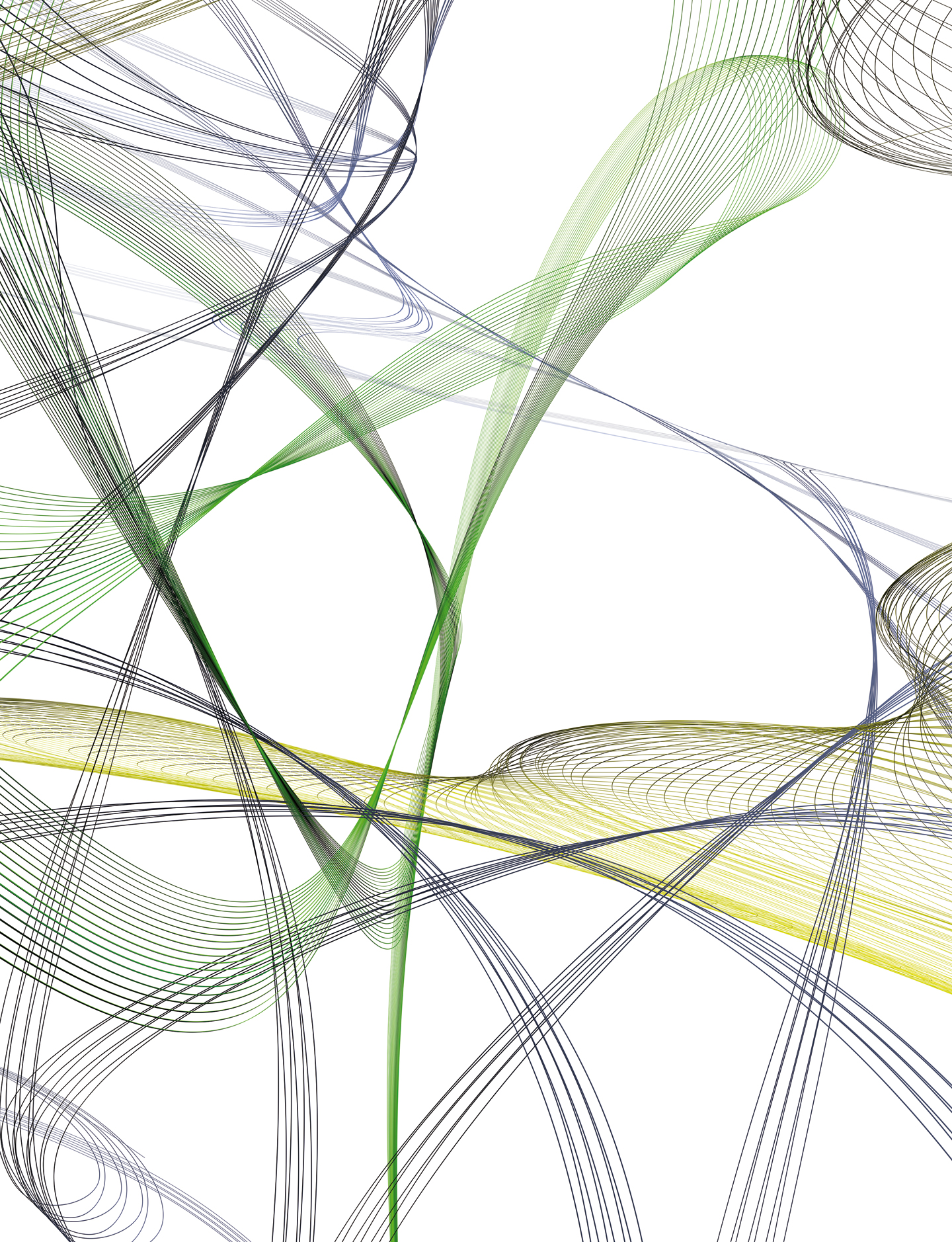Fra tutte le forme d’arte, la scultura è stata una di quelle maggiormente trasformate dall’avvento del Modernismo. Durante il primo decennio del XX secolo, i pittori dell’avanguardia europea uno dopo l’altro avevano trovato convincenti i nuovi modi che riflettevano il rapido cambiamento del mondo. Per primi Pablo Picasso e Georges Braque che nel 1908 scoprivano simultaneamente il Cubismo.
Dal 1909 in poi, le vivide simulazioni dinamiche dei Futuristi affrontavano un pubblico affascinato dal nuovo mezzo delle immagini in movimento. E nel 1910 Wassily Kandinsky inaugurava l’era dell’arte non rappresentativa con il suo First Abstract Watercolour. Lasciando da parte l’influenza della fotografia, la pittura, fino a metà del 1900, è stata sempre considerata applicazione di pigmenti su una superficie liscia così da creare immagini, naturalistiche o astratte, che riflettono il mondo in termini di apparenza reale o di emotività.
Fu soltanto intorno al 1960 che un’emergente generazione di artisti dell’avanguardia americana ed europea spazzò via le antiquate convenzioni che ponevano l’accento sulle differenze piuttosto che sull’affinità tra pittura e scultura. Sarebbe stata attribuita a un’avanguardia internazionale di scultori che si sono affermati dopo la morte di Rodin avvenuta nel 1917 — guidata dall’espatriato spagnolo Picasso e dalla generazione che lo ha seguito, compreso l’americano Alexander Calder, lo svizzero-italiano Alberto Giacometti e l’italiano Fausto Melotti — la capacità di creare una scultura con lo stesso livello di audacia concettuale già sperimentata in pittura moderna. Calder, tre anni più di vecchio di Giacometti e Melotti, aveva cominciato a realizzare sculture in lamiera d’ottone già nel 1909 mentre era ancora un ragazzo. Continuava a creare numerose immagini di piccole dimensioni con fili piegati che costituirono il Cirque Calder (1926), un vasto serraglio in miniatura di animali da circo e di acrobati, in cui l’artista recitava il ruolo del domatore in una messa in scena dal vivo antesignana delle performance. Calder era affascinante con questo giocoso divertissement, ma il suo importante contributo si è palesato solo dopo avere frequentato lo studio parigino di Piet Mondrian dal 1930.
Nei due anni in cui ha maturato questa fondamentale esperienza, l’artista inizia la lavorazione delle delicate sculture pensili formate da fili e lamiere di metallo — che Marcel Duchamp ha ingegnosamente soprannominato “mobiles”. A tempo debito Melotti avrebbe adattato e trasformato le caratteristiche delle più importanti innovazioni di Calder, rendendole completamente sue.
Melotti è oggi di gran lunga il meno conosciuto al grande pubblico dei musei. Le ragioni di tale negligenza di solito traggono origine da una varietà di fattori economici e sociali, ma nel suo caso è particolarmente difficile da comprendere. Fausto Melotti è nato a Rovereto, un piccolo ma significativo centro culturale dove, quando lui aveva diciotto anni, Fortunato Depero fonda la Casa d’Arte Futurista per la realizzazione di mobili, arazzi e giocattoli. All’inizio della prima guerra mondiale la famiglia di Melotti si trasferisce a Firenze, ed è qui che le opere dei grandi maestri del Rinascimento esercitano su di lui una profonda influenza. Dopo avere conseguito la laurea in ingegneria elettrica presso il Politecnico di Milano (città in cui vivrà fino alla morte), nel 1922 decide di dedicarsi alla scultura. Dapprima dunque studia con lo scultore accademico Pietro Canonica nel suo atelier di Torino, e poi all’Accademia di Brera a Milano con Adolfo Wildt, autore particolarmente legato alla tradizione. Nel 1930 Melotti incontra l’architetto e designer Gio Ponti (1891-1979), più vecchio di una decina di anni, che lavorava presso la venerabile manifattura di porcellane Richard-Ginori conferendogli con il suo stile una forte spinta di modernità. Ponti invita dunque Melotti a lavorare lì con lui, e questo sodalizio segna l’avvio del nostro artista all’uso delle numerose possibilità espressive della ceramica, il materiale che avrebbe impiegato con notevole successo nel creare le figure umane ispirate alle isole Cicladi. A disagio per i limiti della scultura di rappresentanza, Melotti entra a far parte del gruppo di artisti e intellettuali che gravitavano intorno alla galleria milanese Il Milione (tra cui Kandinsky, Josef Albers e Lucio Fontana, di due anni più grande di Fausto). Nel 1935 organizza la sua prima personale in galleria: un’importante serie di 18 costruzioni astratte di vario materiale, inclusa la sua sublime Scultura n. 17. La sua profonda formazione classica rimane evidente nelle proporzioni intatte di queste radicali, anche se molto composte, invenzioni.
In questo decennio Melotti entra a stretto contatto con diversi architetti razionalisti, tra cui i soci Luigi Figini e Gino Pollini, nella cui Casa elettrica durante la Triennale di Monza nel 1930 vengono esposti due suoi basso rilievi in gesso. Rimane inoltre vicino a Ponti, con il quale collabora all’allestimento di una mostra su Leonardo per la Triennale milanese del 1939. Prima della guerra le commissioni pubbliche di scultura su larga scala subiscono una battuta d’arresto; Melotti ai tempi lavorava alla realizzazione di quattro figure monumentali in marmo di Carrara per il Palazzo delle Forze Armate di Figini e Pollini per l’Esposizione Universale di Roma (EUR) del 1942 che venne annullata. Melotti definirà questo periodo gli “anni del silenzio” culminati con la distruzione del suo studio milanese a causa del bombardamento degli Alleati nel 1943. Durante l’ultimo anno della seconda guerra mondiale, quando l’Italia sconfitta si trovava sull’orlo del collasso economico e regnava il caos politico, Melotti, con a portata di mano solo materiali molto modesti, modellava un paio di figure in terracotta intriganti che, nonostante le loro dimensioni ridotte, incarnano a pieno il suo virtuosismo in ambito scultoreo e la sua sensibilità sempre più eccentrica. Diavolo e Diavolessa, entrambi del 1945 circa, sono ben lungi dall’essere rappresentazioni routinarie del male e — data la loro creazione in un momento di amoralità dilagante — esemplificano il rifiuto di Melotti nei confronti dei cliché iconografici. Diavolo sembra più birichino che diabolico, e sotto le sue piccole corna sfoggia un’espressione furba che proietta la stessa ambiguità per metà umana e per metà animale ripresa, quattro decenni più tardi, dallo scultore inglese Barry Flanagan nelle tanto amate lepri di bronzo che saltano. Diavolessa, elegantemente allungata, potrebbe essere uno studio per un busto in terracotta della metà del XVIII secolo di Madame de Pompadour di Clodion, impareggiabile petit-maître del rococò francese.

La diabolica e minuta effigie di Melotti lascia pochi dubbi al fatto che il diavolo sia donna. Numerose opere di Melotti rappresentano gli sforzi dell’artista di fondere gli elementi scultorei con quelli pittorici senza soluzione di continuità sfidando la capacità di assegnarle facilmente ora a un medium ora a un altro. Fra queste si annoverano Teatrino, 1950 circa: una scatola aperta a rilevo poco profonda di ceramica smaltata e argilla dipinta di piccole dimensioni è uno dei tanti pezzi a cui diede quel nome. A un primo momento quest’opera richiama alla mente gli assemblaggi del surrealista americano Joseph Cornell, che aveva inaugurato la sua prima mostra personale a New York l’anno precedente l’esecuzione di questo Teatrino. Nonostante le somiglianze superficiali, una grande differenza d’approccio tra i due artisti sta nel fatto che in questo caso Melotti ha attentamente modellato con le mani le quattro figure enigmatiche che popolano la sua impalcatura simile a un proscenio, piuttosto che utilizzare oggetti ritrovati come faceva Cornell nelle sue celebri composizioni.
Il nostro artista torna a questo formato quasi un quarto di secolo dopo nel più astratto e leggermente più largo Il mare, 1974 una terracotta dipinta, carta e scatola aperta di ottone che mostra l’oceano, visto nella parte inferiore del vano a tutta larghezza, come se fosse fatto delle strisce lunghe blu e bianche dei materassi.
Questo tema lineare è ripreso nei due sottili, delicati rilievi di terracotta in compartimenti verticali gemelli sopra la camera orizzontale. Realizzate pressando materiale di terra cruda con cartone ondulato, queste pallide forme verticali suggeriscono onde che si infrangono sulla riva, e conferiscono l’idea di un taglio cinematografico alla visione complementare dell’oceano raffigurato sia a una distanza laterale tranquilla che rispetto alla prossimità frontale turbolenta.
Un altro lavoro marino incluso in questa corrente d’insieme è Albatros (Albatross), del 1980, realizzato sei anni prima che Melotti morisse all’età di ottantacinque anni. Questa costruzione simile a un diorama prende il nome dal grande uccello marino del Pacifico che, attraverso allusioni poetiche, è diventato la semplice metafora di un grave peso psicologico. Qui, tuttavia, non c’è un senso di presentimento o di minaccia perché il grande uccello alato vola verso il cielo con una sensazione esaltante di libertà e sollievo. L’attitudine di Melotti a combinare il profondo con il bizzarro, senza il minimo accenno di malizia, sentimentalismo, o autocommiserazione, insieme al suo agrodolce riconoscimento degli aspetti universalmente tragicomici della condizione umana, lo colloca sullo stesso piano regale del suo contemporaneo ma più anziano Paul Klee. Questi spiriti affini condividono anche una capacità innata di colmare l’arcaico e il contemporaneo in quanto giustappongono il paradosso inconciliabile della tenuità struggente della vita terrena contro l’eternità dell’implacabile indifferenza. Raramente nell’arte moderna il conflitto tra queste realtà congiunte sebbene contraddittorie è stato veicolato in modo così convincente o toccante come in Klee. Se si fosse mai impegnato pienamente a lavorare con le tre dimensioni, le equivalenze tra lui e Melotti sarebbero state ancora più evidenti.
Melotti sembra più simile a Nino Rota, di dieci anni più giovane, oggi ricordato per le diciassette colonne sonore composte per Federico Fellini, ma anche autore classico di notevole distinzione. In grado di abbracciare il genere lirico e quello cinematografico Rota ha caratterizzato la determinazione modernista a ignorare le antiquate categorizzazioni che separavano cultura ufficiale e popolare. L’atteggiamento liberatorio, che noi ora diamo per scontato in innumerevoli manifestazioni, democratizzano l’“alto” tanto quanto legittimano il “basso”. Sia questo compositore che il nostro artista erano geniali nel lasciarsi andare alla malinconia, alle tenere fantasticherie sul trascorrere inesorabile del tempo. La facilità con cui hanno oscillato alternativamente tra la spensieratezza e le metafore strazianti della vita come in un circo — le colonne sonore di Rota per La Strada, o nel teatro, come nel Proscenio di Melotti — si rifà direttamente alla Commedia dell’arte, con la sua giocosità rauca ed equilibrata sostenendo che, come Shakespeare ha improbabilmente affermato, “Tutto il mondo è un palcoscenico / E tutti gli uomini e le donne sono solo comparse”. Le grandi sculture a tutto tondo, in ottone e bronzo, cui Melotti si è dedicato durante gli ultimi vent’anni della sua vita, spesso avevano titoli esplicitamente musicali, come la Pavane versare des enfants défunts, 1960, che riprende, modificandolo leggermente il titolo dalla celebre opera per piano del 1899 Pavane pour une infante défunte di Maurice Ravel. Quest’assolo dal carattere riflessivo a sua volta ha ispirato una delle più toccanti opere di Melotti, in cui possiamo facilmente discernere la figura estremamente stilizzata di una ragazza sdraiata dai capelli lunghi — se sia l’infante aristocratico (principessa) del compositore o l’enfant generico (bambino) dell’artista è irrilevante — con i suoi lunghi capelli che penzolano verso il basso senza vita come se si trovasse sotto un cielo pieno di nuvole.
Anche qui è perfettamente visibile che le sculture dell’ultimo periodo di Melotti hanno bisogno di uno spazio molto generoso attorno a loro. Perché queste opere — al tempo stesso eteree e potenti, snelle nei contorni ma pesanti nel volume — vengano correttamente viste e comprese non possono essere messe insieme ad altre, nemmeno con quelle dello stesso artista.
Di un diverso genere musicale è L’uscita delle valchirie del 1980, sfacciatamente lirica nella sua stravagante forma. Sopra una mischia di gambe intrecciate filiformi che suggeriscono le guerriere di Richard Wagner Die Walküre, diverse appendici tese, di filo d’ottone, si estendono da un piatto, ieratico “volto” accentuato dalla simmetria bilaterale di due grandi oblunghi vuoti.

Queste “braccia” sono drappeggiate di veli di tessuto dipinto e si protendono imploranti verso lo spettatore come un soprano wagneriano in uno di quegli estatici crescendo che incarnano la profonda capacità del compositore tedesco di comprendere il desiderio di immortalità dell’uomo. La scultura metafisica Il magazzino delle idee del 1960 richiama alla mente le altrettanto imperscrutabili rappresentazioni del rapporto tra il tempo fugace e la memoria persistente di Giorgio de Chirico. La struttura in ottone e bronzo dello scultore è composta da tre scatole rettangolari predisposte all’interno di una più ampia oblunga e verticale, tutte sospese su quattro gambe sottili e sormontate dalla falce di luna decrescente. Una scatola è affollata di maschere sostenute da esili aste, in una sequenza da sogno carnevalesco che contrasta con i busti in scala similmente allineati nel chiuso spazio orizzontale in basso.
Questa e altre opere simili degli ultimi due decenni della proteiforme carriera di Fausto Melotti lo riconfermano un maestro inspiegabilmente sottovalutato, un singolare visionario del Modernismo e un artista di straordinaria intuizione poetica.