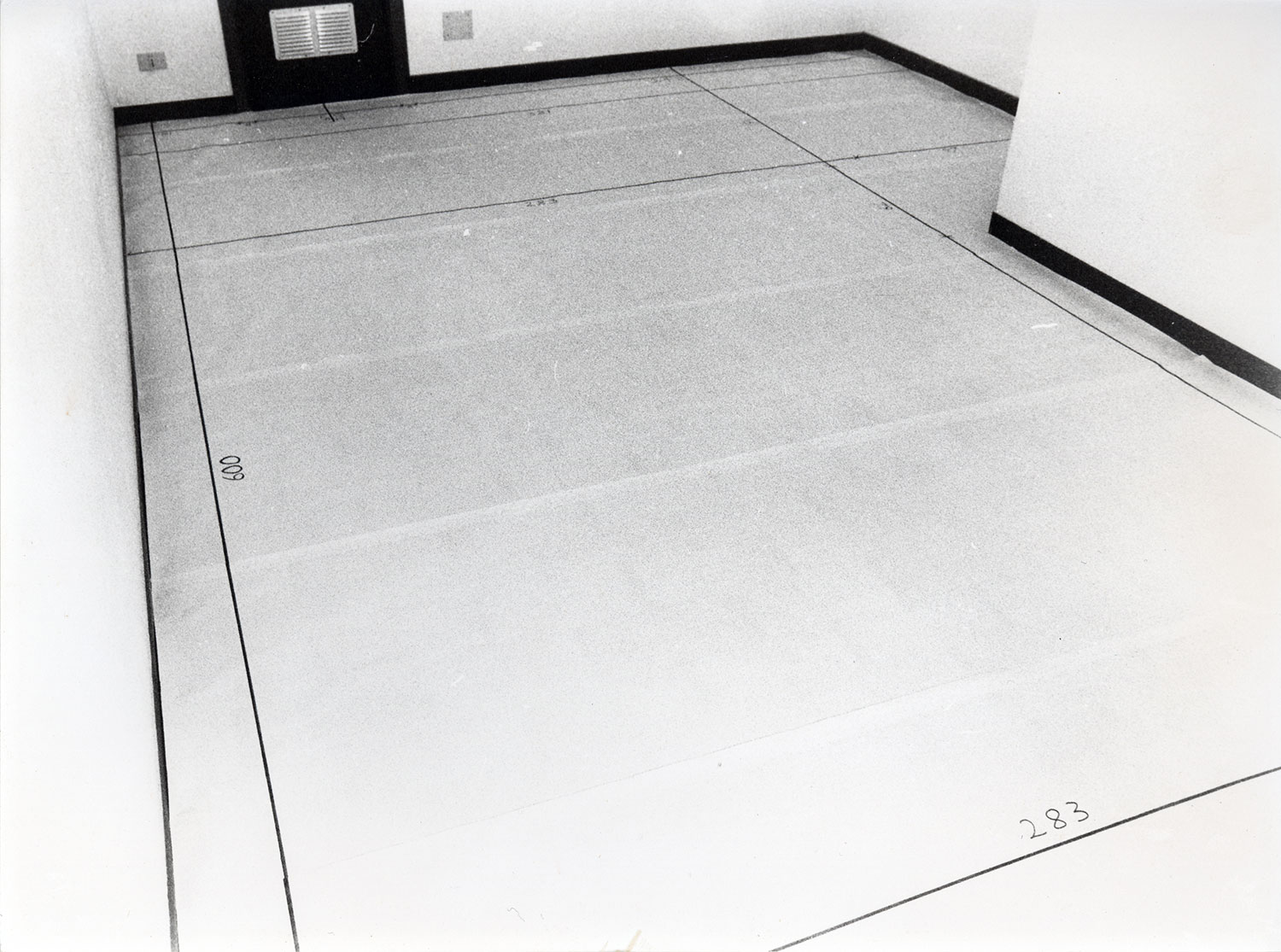Il 1993, l’anno in cui Felice Levini (Roma, 1956; vive a Roma) e H.H. Lim (Malesia, 1954; vive a Roma) producono l’azione Il gatto e la volpe, con il supporto della Galleria Pio Monti, è un anno particolarmente significativo per la storia degli ultimi trent’anni. L’Italia sta vivendo il fatidico passaggio tra la prima e la seconda Repubblica, ma è anche l’anno del primo attentato al World Trade Center, dell’elezione di Bill Clinton – un presidente democratico alla casa bianca dopo la lunga saga repubblicana degli anni Ottanta –, della fine dell’Apartheid in Sudafrica con la liberazione di Nelson Mandela.
Quell’azione a Campo dei Fiori, che segna anche il consolidamento di un’amicizia tra i due artisti, fatalmente si pone al centro di una nuova onda di trasformazioni che proseguono ancora oggi. I due, travestiti in modo carnascialesco da “il gatto” e “la volpe” (nella versione collodiana) s’infiltrano tra la folla della movida romana e si espongono come un elemento di disturbo. È un’opera che intreccia azione, narrazione, ironia, tautologia, pensiero e forma. Non un semplice recupero concettuale degli stilemi degli anni d’oro delle “seconde avanguardie”, ma un ibrido che entra nel mondo e lo guarda con uno sguardo totale, secondo una scala reale, e ricerca un nuovo filo d’oro per saltare a piè pari l’epoca precedente. Un nuovo inizio?
Guardando al lavoro del duo temporaneo, si tratta evidentemente di una modalità che filtra già nei loro trascorsi. E quel sodalizio a quattro mani segna un punto di svolta che coincide perfettamente con i tempi. Il lavoro bidimensionale della pittura (linguaggio percorso da entrambi con modalità diverse) diventa un’orchestrazione di immagini in azioni mentali. Non performance, ma “performatività”, ovvero delle ipotesi di performance estese soprattutto sul piano ontologico.

Levini, con Nuvola rossa (1996), mette al centro l’artista non più come ideatore di azioni, né in quanto personificazione dell’arte, ma come colui che esercita un pensiero performativo dilatato. Infatti già in Riflessi d’oro (1979), e ancor più nell’Autoritratto feroce (1992), Levini intendeva il ritratto come punto di partenza del suo lavoro. Nuvola rossa è una figura di guerra, non un “indiano metropolitano”, come potremmo semplificare, ma un’entità mitologica che entra in un linguaggio di azioni performative fissate dalla pittura. Come lo saranno i Cavalieri dell’Apocalisse (1999-2000), un’opera sostanziale del modo in cui l’artista intende la mitologia. Levini estrae dalle Apocalissi apocrife una frase che indica proprio quella guerriglia urbana dalla dimensione cosmica: “Un’ottenebrante densa notte coprirà il disco infinito della terra. La luna e il fulgente sole in uno si fondono, e tutto si fa deserto e desolazione. Dal cielo precipitano nell’oceano le stelle e insieme tutti gli elementi”. È uno dei passaggi più terrificanti che ricorrono non solo nelle Apocalissi Apocrife, ma anche nelle profezie di Leonardo da Vinci e di Nostradamus. È interessante soprattutto la versione leonardesca delle apocalissi, in quanto è Leonardo che accenna all’inverarsi dell’apocalisse nell’apparire dei due Soli: un mondo che esplode in due emisferi.
Il numero due è quindi il nuovo numero dell’arte. È il numero della simmetria, del codice binario (su cui si fonda il digitale), non più quindi la dialettica, ma l’opposizione simmetrica che può semplificarsi soltanto nella crasi, nella coincidentia oppositorum.
Questa bipolarità cosmica ricorre in modo diffuso nelle opere di Lim. È ciò che si ritrova nei suoi dipinti a rilievo su schermi di alluminio, dove l’opposizione accosta due emisferi, spesso Buddha (Oriente) e di parafernalia di guerra (Occidente), ma anche parola e immagine, pittura e scultura. Non esiste una risposta perentoria agli opposti se non un equilibrio precario fondato sul dubbio. Circa 60 kg circa di saggezza (2001) di Lim, è un autoritratto semi-immobile in cui l’artista in piedi su una palla da basket verifica la possibilità dell’immanenza: non lo scorrere del tempo, quanto la sua intensità. In questo processo di intensificazione, Lim prova anche la risposta del corpo alla durata con Patience (2002), dove rispetto alle Performance Art storica non c’è sperimentazione fenomenica (sullo spazio, sul corpo), ma sulla possibilità di percorrere, con ironia, il senso dell’impossibile (la carpa decida di saltare fuori dall’acqua per farsi prendere). Quindi non è un’azione-performance, ma un’azione del pensiero che diventa immagine in movimento. Lim ci conduce fino alla più violenta della realtà ontologica: la parola che si immobilizza nella lingua, come nella performance Red Room (2004) a Villa Arson, a Nizza, dove l’artista inchioda la propria lingua a un tavolo – si amputa, come Van Gogh, non in un senso dell’arte, ma in un senso parallelo, quello del dire, della poesia, del comunicare.

Nel percorso leviniano quest’estensione si gioca su un elastico più teso, che attraversa la mitologia e sbatte violentemente sul presente, tra civiltà (storiche) e inciviltà (presenti). Si addensa e si riassume soprattutto all’interno della vicenda personale – come dimostra la sua boîte meravigliosa, Babele balbuziente (2010), reminiscenza di una boîte duchampiana, dove la biblica scomparsa di una lingua comune, si presenta come una mostra portatile delle varietà e differenze presenti nel proprio lavoro. I suoi “luoghi d’affezione”, tra i quali figura anche un Pio Monti in scala 1:100 riconoscibile (in questo gioco dei sensi) soprattutto per quel grosso orecchio “da mercante” che lo segue e fuoriesce da una parete del piccolo white cube riprodotto in scala.
Il mistero cosmico poi s’infittisce con Astratti furori (2014), in cui il portone di un palazzo (o di una stanza metafisica) si apre e chiude in modo sistematico: è la soglia, il limen tra la vita e la morte, l’entrata per uscire. Il viaggio già intrapreso da Orfeo, Ulisse, Dante, dai poeti romantici, qui diventa l’immortalità che ci è preclusa non dal tempo, ma dalla tempestività, un’occasione meccanica formulata dal caso. Una mancanza, o assenza di possibilità, che l’artista aveva già formulato con “Non c’è” la mostra-progetto presentata a Fondazione Volume! nel 2004: l’horror vacui determinato dalla vacatio papale, l’assenza di un Papa che paradossalmente conduce poi alla presenza di due Papi, ancora una volta una simmetria, i due Soli.

Una simile preclusione diviene elemento centrale del lavoro di Lim e prende forma della gabbia: già la gabbietta di Pensatoio (1999) che ci ostacolava dall’accedere a una risposta ironico-banale (prima l’uovo o la gallina?), poi divenuta una prigione in The Cage, the Bench and the Luggage (2011), è cresciuta in modo esponenziale in Mental Trip (2017) dove l’iniziale sospensione del giudizio individuale diviene un viaggio collettivo con Eterno Ritorno, un viaggio all’interno di un doppio corridoio di grate dove non ci incontreremo mai. Presagio di amarezza che Levini nel suo stile propone con Stella Maris (2015) con cui ci accompagna verso il mare, nei luoghi dei giochi d’infanzia e del relax familiare di sapore piccolo borghese, ma alla velocità del razionalismo storico e delle forme aerodinamiche futuriste pronte a schiantarsi in guerra.
In quel 1993, con l’azione de Il gatto e la volpe il numero due si attesta ad ipotesi per (ri)fare arte: una doppia linea che si moltiplica non semplicemente lungo la via “multimediale”, ma secondo una nuova idea multimodale. Il due incarna una spaccatura che Lim e Levini non intendono conciliare ma “tenere assieme”; e quell’azione si presenta come gioco infantile (due personaggi da fiaba, due cappelli neri, due occhiali da sole, quattro orecchie pelose…), enigmatico, misterioso, ma terribilmente serio, che ci ammonisce dal credere che quanto vediamo sia limitato a un presente unico.