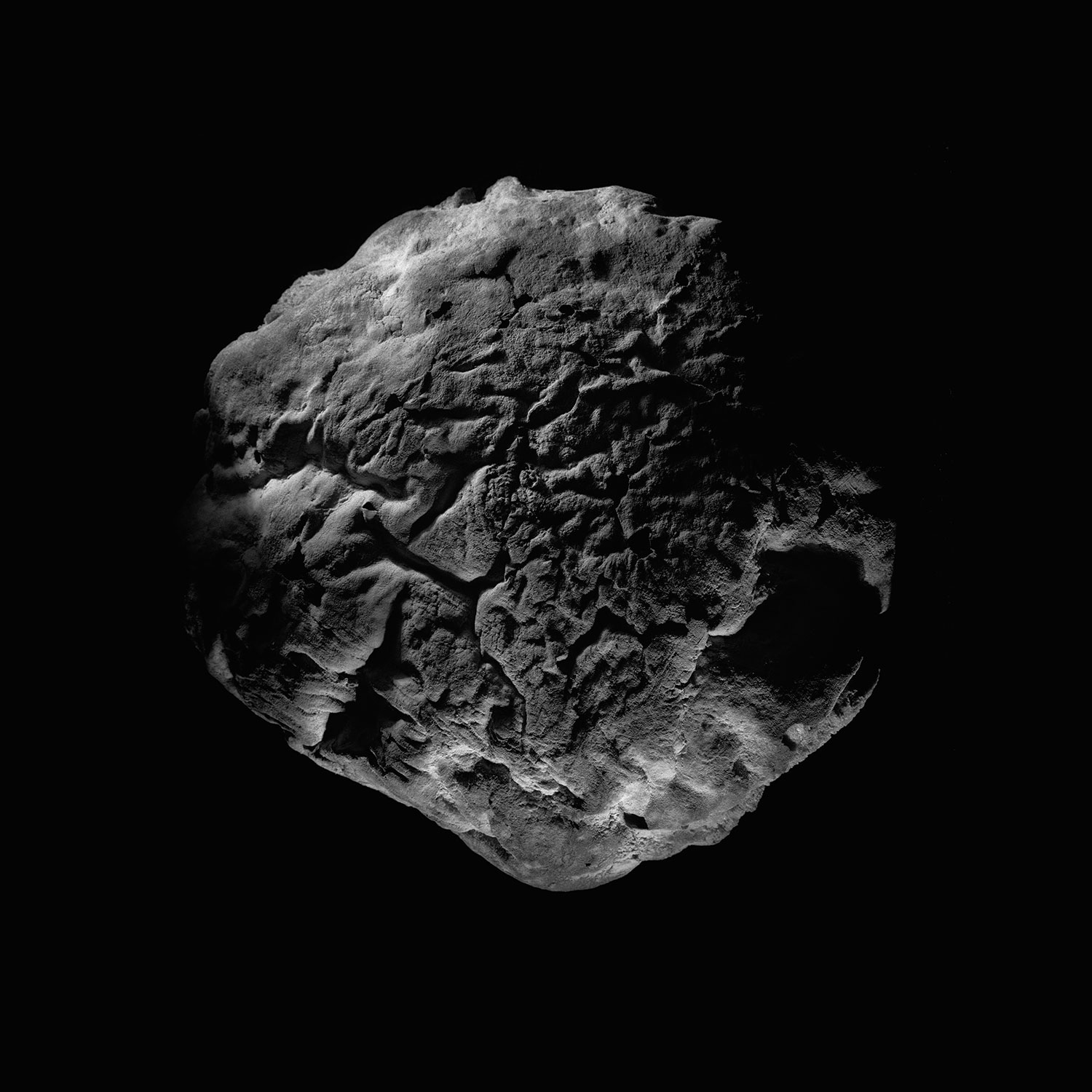Negli anni Settanta numerose artiste italiane adottano la fotografia per decostruire gli stereotipi di genere insiti nel linguaggio e nella comunicazione mediatica, per esplorare i nessi tra corpo e identità femminile, per rivendicare le istanze del personale e del vissuto e per denunciare istituzioni e consuetudini che da secoli ratificano la subalternità economica, politica e culturale della donna. Nel contestare le immagini del femminile diffuse nella cultura visiva occidentale, dove il corpo della donna è abitualmente sottoposto a un processo di reificazione, il medium fotografico è un alleato prezioso: la peculiare natura di indice della fotografia — la sua specifica contiguità con il reale (teorizzata proprio negli anni Settanta da Rosalind Krauss) — fa sì che l’immagine fotografica si presenti come una traccia sensibile del corpo, luogo in cui si inscrivono non soltanto i segni dell’identità biologica, ma anche quelli legati al ruolo sociale e pubblico. La fotografia consente quindi alle artiste di muoversi su un doppio binario: attraverso questo medium, da un lato, esse mettono in primo piano il corpo per sondarne potenzialità, limiti e desideri alla ricerca di una dimensione identitaria non più alienata e libera dai canoni maschili; dall’altro, demistificano le ideologie trasmesse proprio con e nelle immagini del corpo. Opere fotografiche come ritratti, autoritratti, fotomontaggi sono dunque un’arena ideale per la sperimentazione sul genere: lo sono sin dalle prime avanguardie e lo divengono sempre di più negli anni Settanta, contrassegnati dalla diffusione del femminismo e dal recupero massiccio della corporeità. In questo periodo numerose artiste ricorrono alla fotografia per raccontare sé stesse e la propria esperienza di vita. Sperimentano così nuove strade che si allontanano dalla logica dell’immagine rubata o dal paradigma dell’“istante decisivo”, per instaurare relazioni di vicinanza ed empatia tra chi fotografa e chi viene fotografato. L’autoritratto, in particolare, consente alle donne — storicamente vissute ai margini della cultura e della storia dell’arte — di riconquistare il piacere e il potere della narrazione: adottando uno sguardo che si pone simultaneamente al di qua e al di là dell’obiettivo, la donna cessa di essere l’oggetto della visione e del desiderio altrui e si riappropria del corpo, della sessualità e della sua rappresentazione simbolica. Le esperienze in tal senso sono molteplici: le serie L’invenzione del Femminile: Ruoli (1974) di Marcella Campagnano e Donne allo specchio di Paola Mattioli (1977) pongono in discussione i modelli correnti di rappresentazione del femminile, molto spesso fatti propri e interiorizzati dalla donna stessa, creando rapporti umani basati sullo scambio, sul gioco e sulla sorellanza. Campagnano coinvolge le compagne del collettivo femminista nel quale milita in una sequenza di travestimenti che le vede impersonare di volta in volta i ruoli stereotipati di madre, prostituta, sposa, casalinga, amante, segretaria ecc.
La posa fotografica è preceduta da un lungo rituale di mascheramento, in cui ogni donna aiuta l’altra a entrare nei panni che la società maschile le ha cucito addosso. È un processo di trasformazione identitaria che propone un’idea di femminilità acquisita mediante l’imitazione di gesti, pose ed espressioni, mettendo in atto i ruoli stereotipati del femminile, Campagnano sottolinea le ambiguità nella costruzione sociale dell’identità. Fotografandosi mentre si traveste insieme alle altre donne, inoltre, Campagnano realizza un “autoritratto collettivo”, fondato sulla reciprocità. In Donne allo specchio Mattioli interviene, invece, sul tema della reificazione prodotta abitualmente dalla fotografia: le donne vengono fotografate mentre si specchiano, quando, cioè, prendono consapevolezza di sé come altro da sé; l’autrice stessa si inserisce nella serie, identificandosi con le compagne. “In ognuna di loro mi rispecchio anch’io”, spiega all’epoca Mattioli, “perché è nell’altra che ritrovo frammenti diversi del mio stesso guardarmi”. L’obiettivo analizza il momento in cui l’autrice vive e condivide l’esperienza di essere nel contempo soggetto e oggetto della visione, decostruendo i meccanismi dell’immagine e costruendo per lei e per la fotografia una nuova identità. Nelle opere di Mattioli e Campagnano il corpo è inteso come costruzione culturale e luogo segnato da rapporti di potere, e la fotografia, proprio perché considerata strumento trasparente e “obiettivo”, è usata per svelare l’ideologia sottesa a tali relazioni, mostrando l’illusorietà di qualsiasi visione neutra (e asessuata) della realtà. Su questo terreno si giocano molte battaglie: sono diverse le artiste che, in Italia, intendono de-naturalizzare l’apparente mimetismo della fotografia attraverso pratiche di decostruzione del linguaggio, in particolare di quello mediatico. Ad esempio, sono molti i casi di appropriazione e détournement di immagini pubblicitarie che sottolineano le disparità di genere, spesso spacciate e recepite come “naturali” (quindi inevitabili e immutabili). Già nelle opere verbo visive realizzate nella prima metà degli anni Sessanta da Ketty La Rocca e Lucia Marcucci si evidenziava una critica corrosiva volta a denunciare le rappresentazioni femminili proposte dalle réclame e, più in generale, la condizione e il ruolo della donna nella società del boom: collage come Vergine e Sana come il pane quotidiano di La Rocca, entrambi del 1965, o l’opera fotografica La ragazza squillo di Marcucci, anch’essa del 1965, sono lavori indicativi del desiderio di demistificare, attraverso uno sguardo ironico e straniante, l’ipocrisia della cultura cattolica italiana, nella quale l’illibatezza femminile, propagandata come virtù, è funzionale al controllo del corpo e dei costumi sessuali della donna.

Benché con modalità diverse, la critica al sessismo del linguaggio mediatico si ritrova in diverse ricerche del decennio successivo. Nella serie Mythes et Clichés (1978) Nicole Gravier, artista francese attiva stabilmente a Milano dal 1971, mette a nudo gli stereotipi del fotoromanzo, ritraendosi all’interno di scenografie allestite ad hoc, mentre simula pose e atteggiamenti tipici di questo genere popolare, nato in Italia nell’immediato dopoguerra. Da un lato, Gravier esaspera il carattere dolciastro e sentimentale caratteristico delle immagini del fotoromanzo, dall’altro introduce elementi stranianti che stridono con l’atmosfera “rosa” della foto: la donna interpretata dall’artista è ritratta mentre trepida pensando all’oggetto della sua passione, circondata dalle foto dell’innamorato o da riviste patinate con le pubbli- Marcella Campagnano, L’invenzione del femminile – Ruoli (dettaglio), 1974. cità di prodotti di bellezza. All’interno di queste scene melense Gravier inserisce oggetti incongrui, come ad esempio in I Will Think of Him Every Moment, Constantly (1979), dove, a creare una smagliatura, compare una copia dell’antologia Il pensiero politico curata da Umberto Cerroni. L’effetto di discontinuità si genera dalla relazione delle sfere simboliche opposte del femminile e del maschile: quella stereotipata della donna, legata alla dimensione del sentimento romantico e della vita familiare, e quella altrettanto stereotipata dell’uomo, connessa alla ragione e all’azione politica. La volontà di mettere in questione l’univocità dell’ordine simbolico maschile è presente anche nel gesto compiuto negli anni Settanta da Bianca Pucciarelli in Menna: l’artista decide di sdoppiarsi, assumendo la duplice identità di Bianca Menna e Tomaso Binga, ratificata nell’opera Oggi Spose (1977), in cui l’artista celebra le nozze con il suo alter ego maschile. Per l’occasione amici e parenti sono invitati nella galleria romana Campo D, dove vengono accolti da due foto in bianco e nero: una ritrae Bianca Menna in abito bianco nel giorno del suo vero matrimonio, l’altra Tomaso Binga, vestito per l’occasione in abito scuro. L’operazione di trasformazione identitaria, in questo caso, pone l’accento sulle connotazioni maschiliste dell’istituzione matrimoniale; la sostituzione della dicitura “oggi sposi” con il femminile “oggi spose” riporta l’attenzione sull’assunzione convenzionale da parte della donna del cognome del coniuge, mettendo in luce come la condizione di assenza, di mancanza e di perdita legata al femminile si espliciti nel linguaggio.
Il medium fotografico, tuttavia, viene usato non soltanto per denunciare cliché mediatici e rituali pubblici solennizzati proprio dalla fotografia (come appunto il matrimonio), ma anche per avviare un’attività di raccolta e recupero di immagini legate al vissuto e alla memoria individuali, nell’ottica di una rivendicazione del ruolo politico del personale. La dimensione della sfera intima, dei legami parentali e del ricordo, ad esempio, riveste una funzione centrale nell’installazione fotografica Origine, realizzata nel giugno del 1976 da Carla Accardi alla Cooperativa di via Beato Angelico a Roma (da poco riproposta nella mostra “La Grande Madre”), dove l’artista ricopre le pareti espositive con nastri di sicofoil su cui vengono montate stampe fotografiche appartenenti alla storia della sua famiglia. L’opera, atipica nel percorso dell’artista, è una sorta di autoritratto à rebours, disseminato nello spazio e nel tempo, in cui Accardi riscopre le sue radici, ripercorrendo la propria vicenda esistenziale attraverso l’incontro e il confronto con i ritratti delle antenate.
La fotografia, e in particolare la Polaroid, ha un ruolo cruciale nel rappresentare il vissuto familiare delle artiste donne: nella serie Diario v’ideo senti/mentale (1974) Anna Oberto esplora la dimensione della maternità riportando le tracce dell’apertura al mondo e al linguaggio vissuta dal figlio Eanan. L’opera è coeva e per certi aspetti affine al Post-Partum Document (1973-1979) di Mary Kelly: entrambi i lavori pongono l’accento sugli aspetti psicologici, sociali e culturali determinati dall’esperienza della maternità e dalla crescita di un figlio. Diario v’ideo senti/ mentale si presenta infatti come una successione di fogli, equivalenti alle pagine di un diario, sui quali l’artista annota con interventi grafici, verbali e fotografici, le fasi e le scoperte che segnano la relazione del figlio di diciotto mesi con l’ambiente esterno. Oberto raccoglie gli scarabocchi infantili di Eanan, rivelatori della sua condizione prelinguistica, e li giustappone a foto Polaroid che lo ritraggono mentre fa esperienza del mondo, di sé e (con un riferimento a Lacan) della sua immagine riflessa allo specchio. Il ricorso all’apparecchio Polaroid, che per la sua immediatezza e facilità di utilizzo ha costituito uno tra gli strumenti più diffusi per testimoniare l’intimità dei momenti familiari, accentua la sensazione dello spettatore di trovarsi dinnanzi a un diario privato. L’immagine fotografica esibisce una fattura amatoriale, priva di ricercatezze, sviluppando così un racconto intimo e quotidiano, intessuto di ricordi e suggestioni. Dalle opere analizzate — esempi sintomatici di un fenomeno più vasto, che comprende artiste come Verita Monselles, Cloti Ricciardi, Diane Bond, Stephanie Oursler ecc. — si evidenzia come il legame tra arte, fotografia e femminismo in Italia negli anni Settanta sia molto stretto. Ogni artista affronta in modo diverso il rapporto con la militanza: Campagnano, Mattioli e Accardi, ad esempio, partecipano ai gruppi di autocoscienza, mentre Gravier e Binga accolgono le istanze del femminismo senza un impegno attivo. Al di là delle singole esperienze, ciò che accomuna la ricerca di queste artiste è l’uso militante e politico della fotografia, concepita come uno strumento per raccontare la realtà attraverso l’assunzione di uno sguardo sessuato che interroga le differenze di genere, e come un mezzo per costruire relazioni, scambi e nuove strategie di rappresentazione del femminile.