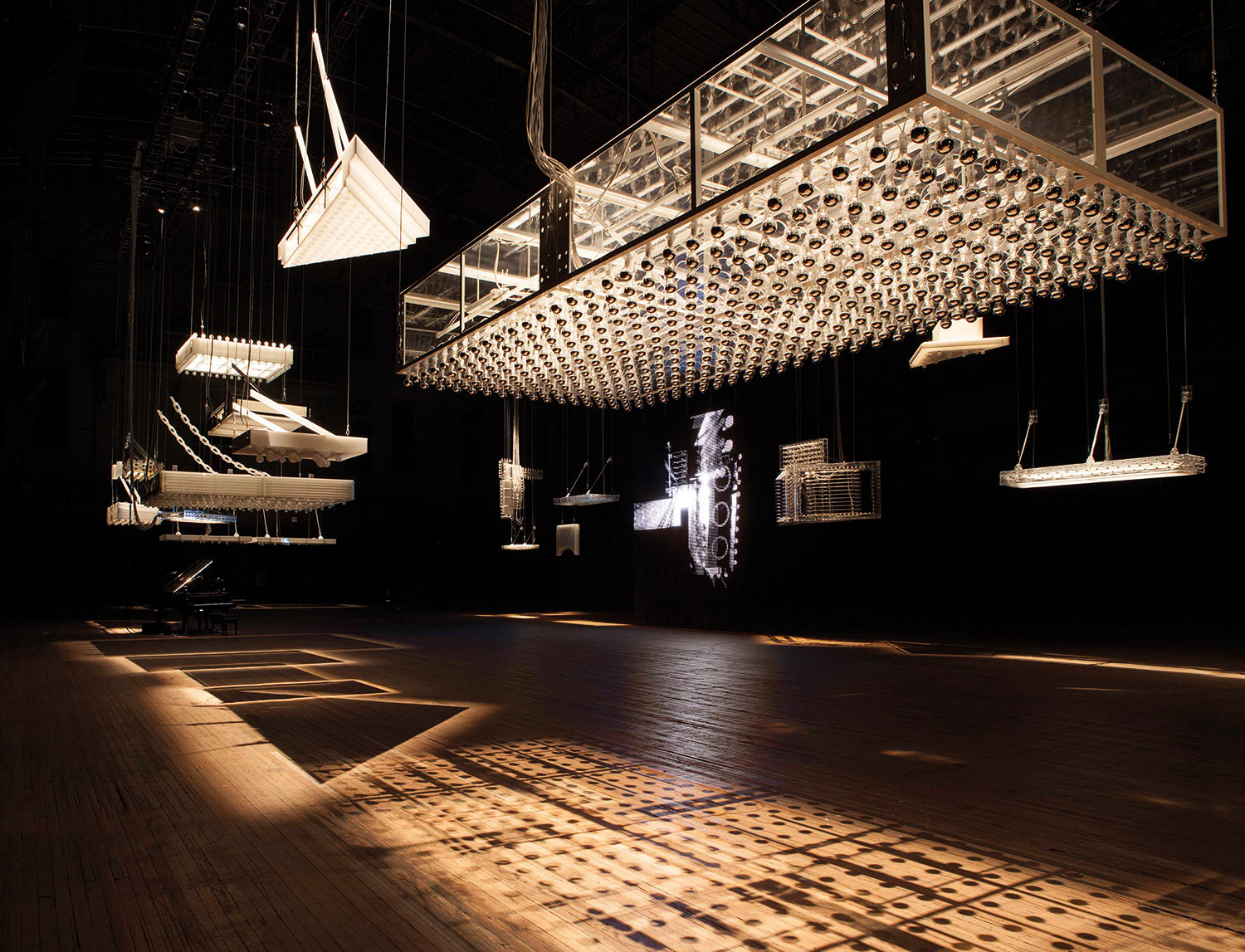Ginevra Bria: La memoria storica e civile che il tuo lavoro rievoca non è ancora stata scritta sui libri di scuola, ma si ritrova, inscritta, nei tuoi lavori. Come è cambiato, nel tempo, il tuo processo di ricostruzione, assimilazione e ipostatizzazione della storia?
Francesco Arena: Il mio lavoro necessita di un racconto perpetuo per essere pienamente fruito, la scultura deve mantenere la capacità di ascrivere qualcosa in sé. La storia è metà dell’oggetto finito, l’altra metà è composta dal materiale fisico di cui la scultura è plasmata, l’una trova espressione grazie all’altra. Quando nessuno racconterà più quel che un blocco di bronzo specchiante rappresenta, quel volume conterrà comunque, affogata in sé, un’informazione. Nel tempo il lavoro cambia naturalmente forma, si scopre una materia differente e quel che con essa può diventare. Ma il processo è sempre lo stesso, il punto di vista e il bisogno di raccontarsi sarà sempre quello umano.
GB: Quale definizione conferiresti al concetto di monumento alla memoria, in Italia?
FA: La memoria presuppone una trasmissione di conoscenza. Spesso si dice preservare la memoria, in realtà la memoria è già una salvaguardia. Senza questo atto non esiste memoria: le due estensioni formano un’entità. Non occorre proteggere la memoria essendo preservazione in sé. Diverso è il rapporto tra memoria e cultura, sono due condizioni distinte: la cultura è informata dalla memoria. Il monumento contiene la parola momento, anche se l’origine della parola è altro; l’incontro con il monumento è appunto un momento, uno spazio di tempo più o meno lungo che occupa uno spazio fisico. Il monumento non può essere altro che alla memoria, non come celebrazione di quel che è accaduto nel passato, ma come oggetto esperienziale che racconta reiterazioni nel tempo. Perché sono sempre sovrapponibili, uguali a loro stesse le azioni che l’uomo compie. Il monumento non è solo un monito, una riflessione, ma deve diventare un segno che sottolinei quel che siamo stati e continueremo a essere. Costruiamo monumenti per cercare di razionalizzare, per indicare chiaramente errori. Ne esistono talmente tanti che non li vediamo più. Se veramente avessimo coscienza di ogni lapide affissa ai muri delle nostre città e di quel che ognuna di essa porta con sé, proveremmo un senso di sconfitta insopportabile, ne saremmo ossessionati. Il mio lavoro emerge anche da questo: dal ripetersi degli eventi, dalla necessità di confrontarsi con essi non più attraverso il momento dell’incontro con il monumento, ma attraverso un dialogo personale. Attraverso la vita di ogni giorno, in termini di minuti, di spazio e di storie degli altri.
GB: Dal rapimento di Aldo Moro alla morte dell’anarchico Pinelli, ai due attentati di Capaci e via D’Amelio a oggi: quale episodio della storia e della politica italiana ha segnato i tuoi ricordi?
FA: Ci sono episodi che sono ricordi orali, racconti sentiti da bambino e di cui non capivo il significato. Con il tempo li ho ricostruiti e, quando li ho vissuti nella contemporaneità, alcuni erano incastonati nella memoria collettiva. Solo attraverso di essa ho potuto comprendere meglio le parole sentite nell’infanzia. Le luci dei bombardamenti notturni della prima guerra del golfo, i cecchini che sparano a Sarajevo, le bombe in Italia, un ragazzo morto a Genova e le torri di New York che cadono. Nel disastro sicuramente ognuno di noi conserva, associato, anche un ricordo felice. L’11 settembre 2001 io e mia moglie mangiammo un pollo allo spiedo in auto. Le immagini delle torri che crollavano avevano spazzato via la possibilità di creare un’altra immagine. Ma il quantitativo di morte che esse portavano per noi non era ancora chiaro.
GB: Quali aspetti ti hanno insegnato gli artigiani con i quali collabori, nel confronto diretto tra materia e materiali?
FA: Ogni materiale ha caratteristiche proprie che non sono solo quelle fisiche: durezza, resistenza, flessibilità, lucentezza e altro. L’uomo utilizzando i materiali per scopi precisi ha conferito a questi anche un loro significato concettuale, legando le due componenti strettamente in relazione. Nonostante l’evidenza, questo legame è parte fondante della nostra conoscenza appresa, empirica tanto da risultare un’intuizione spontanea. Non avendo studiato i materiali e le loro caratteristiche, è fondamentale per me rapportarmi con gli artigiani che conoscono bene questi materiali e che altrettanto bene conoscono il mio modo di lavorare e di pensare all’opera. Richiedendo una disponibilità e una curiosità, alle persone con cui collaboro, che va al di là del semplice rapporto lavorativo.
GB: Sette, uno, quattro, nei tre spazi di Galleria Raffaella Cortese, radica alcuni aspetti del proprio percorso narrativo sulle figure di Sontag e Nietzsche. A livello plastico, invece, quali pensieri permette di conoscere, alle tue mani, il DAS rispetto a metalli o a superfici lapidee?
FA: Il DAS lo usano i bambini perché è facile da usare e secca all’aria, non necessità di cottura, conserva il risultato di un’azione per un tempo ipoteticamente infinito. Ho scelto di utilizzarlo per Buddha’s corner perché volevo che in quest’opera la lunghezza della lavorazione, in termini temporali e fisici, passasse dalle mie mani nella sua interezza; necessaria per misurare un dimensione che non c’è più, l’altezza in metri dei due Buddha distrutti a Bamiyan dai talebani nel 2001.
GB: Quando concepisci un tuo autoritratto, come nel caso di quello che esporrai allo spazio di via Stradella, ritieni sia più importante rappresentare te stesso in un determinato periodo di tempo oppure proiettare un tuo contorno identitario nel tempo?
FA: Gli autoritratti sono segni che si lasciano nel tempo, sono interessato a come non ci possa essere un autoritratto definitivo perché siamo in continuo cambiamento, fisico e mentale. I tre autoritratti in galleria si intitolano I giorni e sono tre tacche come quelle che si potrebbero praticare in un ipotetico bastone per camminare, un segno netto per ricordare qualcosa che ha a che fare con noi, con gli altri e con il tempo.