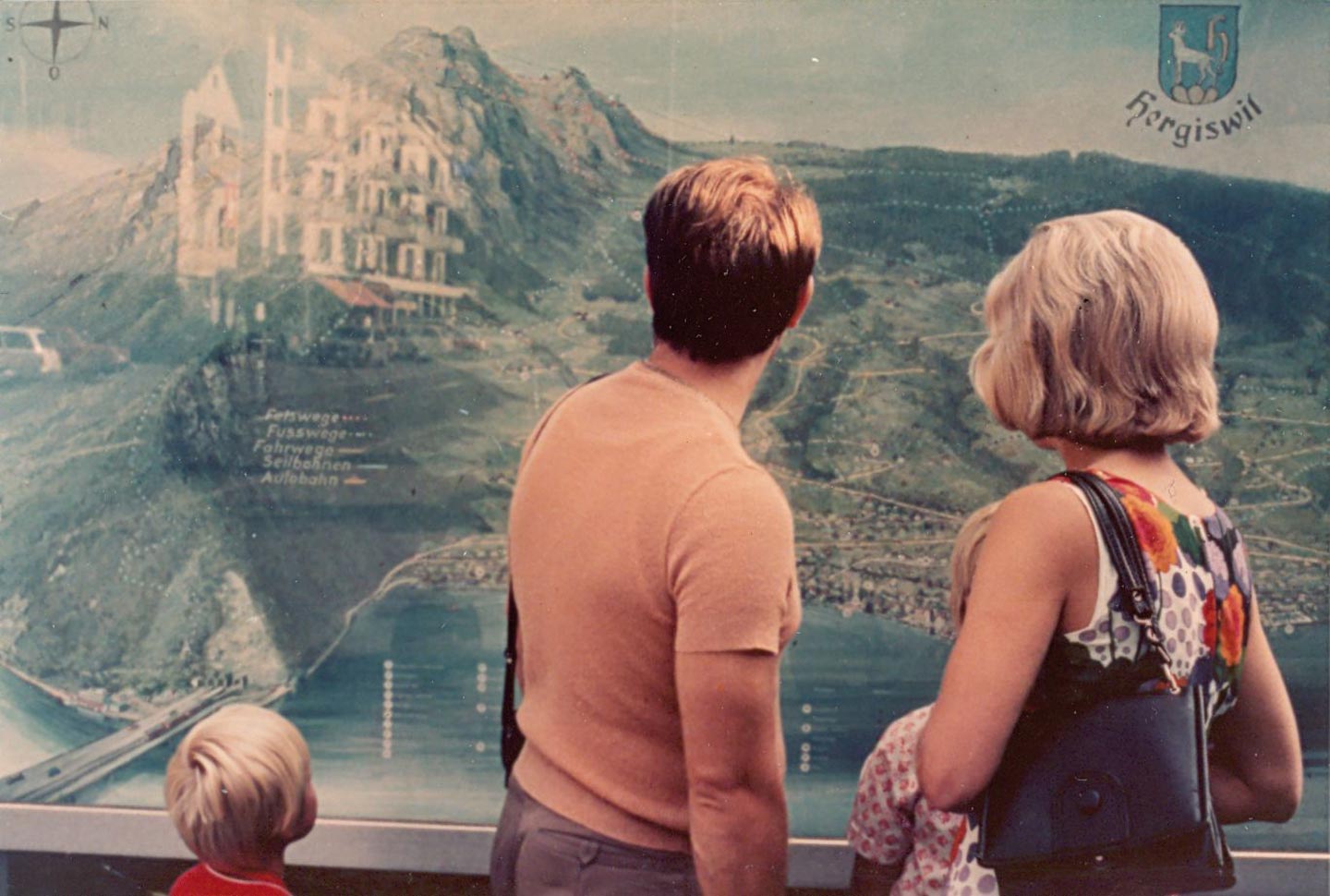La trasformazione, l’attraversamento e la processualità sono alcuni temi, guide concettuali e visive, che caratterizzano la ricerca di Giorgio Andreotta Calò e che l’artista trasferisce in un ampio registro di visioni costellate di gesti, azioni, sculture e interventi ambientali. Le sue opere sono sempre il risultato di una lunga riflessione segnata da una lenta ricerca di mezzi e di materiali espressivi tra loro molto diversi. Ma è l’impiego dell’acqua a conferire alle opere una forte componente “riverberante” e a porre lo spettatore a confronto con una tremante fissità presente nel mondo delle cose.
Per certi versi è forse significante pensare al lavoro di Calò in relazione alla dimensione artistica critica lanciata dalle esperienze concettuali e processuali degli anni Sessanta e Settanta del Novecento. È possibile, infatti, rintracciare una forte consonanza con le indagini svolte da alcuni artisti (si pensi, per esempio, al lavoro Splitting di Gordon Matta-Clark e alle opere Essere Fiume di Giuseppe Penone) che hanno saputo considerare il lavoro della natura e il lavoro della scultura come polarità materiali e temporali indistinguibili. Di fatto, l’uomo è natura e come essa crea unicamente distruggendo e non edificando di continuo la realtà.
È importante mettere in luce l’acuta abilità con la quale l’artista ha saputo cogliere un insegnamento fondamentale da queste pratiche, anche partendo da sentieri già percorsi: fare eticamente il proprio mestiere e dare a esso un valore ancora umano. E se ci è ancora concesso di esprimere l’importanza della stabilità, del radicamento e del contenimento delle connessioni e dei ritmi ai quali si è soggetti, allora il mestiere dell’artista, e in generale dell’intellettuale, se ne può ancora fare carico. Dalla ricerca e dai lavori di Calò ciò che sembra emergere con una forza specifica è l’importanza di riaffermare anche la dignità e l’autonomia di un gesto umile, ma capace di inscriversi nella logica stessa dell’opera (e del quotidiano) per innescare una serie di relazioni che possono irradiare la nostra immaginazione e “irrompere nel nostro mondo per spingerci oltre”.
Potrebbe quindi trattarsi di un “oltre” in cui è ancora possibile generare domande concrete per poter riaffermare l’importanza di questioni vitali: dal bisogno fisico di rallentare, differire e ritardare, fino alla necessità poetica di ritornare e ritrovare la potenza dell’immaginario. Anzi, forse proprio nella dimensione dell’immaginazione, nel suo essere luogo della fluidità, è possibile auspicare con tenacia una trasformazione della miseria attuale. E nonostante il potere di immaginare, assieme all’idea di autonomia e di autenticità, sia stato elegantemente integrato nello spirito del nuovo capitalismo (anche grazie alla stessa critica artistica), è ancora doveroso pensare che sia il solo a indicarci una via, almeno in parte, libera da valutazioni repressive e dalla dilagante autocensura.

Mara Ambrožič: Cominciamo questa conversazione da un vuoto geografico, letteralmente da una lacuna sospesa e scavata dall’acqua: da dove vieni e quali sono le visioni che ti hanno condizionato nella crescita?
Giorgio Andreotta Calò: Il luogo da cui provengo e quel qualcosa a cui tendo sono due elementi coincidenti, inscritti in un moto circolare. In questo senso è giusto pensare a un continuo (eterno) ritorno. Il ritorno potrebbe originare dalla stessa parola “Venezia”, come veni etiam, nel senso imperativo di venire ancora, quindi ritornare. Ho detto una volta che essere nato e vissuto a Venezia è stato in un certo senso come permanere in uno stato di fluttuazione, all’interno del liquido amniotico di una città intesa come una sorta di ventre materno. Questa unicità del luogo condiziona anche la percezione della realtà da un punto di vista altrettanto unico. È una città che si affaccia alla modernità pur restando ancorata a una fisionomia antica. Un luogo che sta soffrendo dei cambiamenti in atto a livello globale e che in un certo senso mal li sopporta. La sua chiusura — anche se si tende a farla passare per una città internazionale e aperta al mondo — permette una certa tranquillità e raccoglimento.
MA: Sin dai primi esperimenti era evidente che il tuo lavoro stava cercando di riflettere la transitorietà e l’irripetibilità degli eventi; inizialmente, infatti, quasi tutti i lavori si condensavano in un breve lasso temporale per poi riaffiorare di tanto in tanto nella memoria di chi li ha esperiti…
GAC: Un’opera traduce un pensiero, un’intuizione in forma. Un pensiero, che passa e sfugge, transita nella mente e cerchi di afferrarlo congelandolo in una presenza fisica, o semplicemente in un gesto. Inizialmente non mi preoccupavo che questa forma resistesse al tempo; l’urgenza era quella di esprimere, appunto, un pensiero e un’intuizione. Col tempo ho cercato di fare in modo che l’opera resistesse a questa condizione di transitorietà e che non fosse più soltanto una fotografia, ma una presenza fisica e reale, qualcosa che avesse una forza evocativa.
di afferrarlo congelandolo in una presenza fisica, o semplicemente in un gesto. Inizialmente non mi preoccupavo che questa forma resistesse al tempo; l’urgenza era quella di esprimere, appunto, un pensiero e un’intuizione. Col tempo ho cercato di fare in modo che l’opera resistesse a questa condizione di transitorietà e che non fosse più soltanto una fotografia, ma una presenza fisica e reale, qualcosa che avesse una forza evocativa.
MA: L’acqua, con il suo carattere tattile e fluviale, ritma intrinsecamente e con maggiore evidenza i tuoi ultimi lavori. È un motivo di richiamo?
GAC: Considero l’acqua come un possibile mezzo espressivo. Uno strumento di lavoro, una materia prima come può esserlo l’argilla o la pietra. Ha la capacità di trasformare, e trasformarsi, di assumere la forma del contenitore o sfuggire completamente al nostro controllo affermando la propria autonomia. Ha questa capacità di creare riflesso, aprendoci una visione. È il mezzo attraverso il quale sono stato abituato a considerare la realtà circostante, la quale si è sempre mostrata attraverso un rispecchiamento. È anche una perfetta metafora della dimensione sospesa che caratterizza l’atto dell’immaginare.

MA: Alcuni tuoi interventi, se non erro, tentano di trasfigurare il carattere funzionale e sociale del luogo nel quale agisci, cercando di interrompere il normale scorrimento del quotidiano per ristabilire una condizione inedita, autonoma.
GAC: Credo che l’artista, attraverso il suo operato, debba cercare di mettere il pubblico di fronte alla possibilità di intravedere un qualcosa che si situa “oltre”. Deve stimolare la possibilità di creare un immaginario, di andare oltre l’immanenza fisica dell’opera. Trasfigurare il luogo significa innazitutto cogliere in esso un potenziale inespresso, una qualità espressiva definita anche da una storia passata, fatta di individui, per restituirlo a una nuova possibile funzione. È un modo per dare alle persone e agli spettatori la possibilità di entrare, di investire ” se stessi nell’opera, di considerare la realtà e il luogo da un nuovo punto di vista scaturito da quell’interruzione del quotidiano, da quella frattura nella realtà che siamo altrimenti abituati a considerare come l’unica realtà possibile.
MA: L’irruzione del reale nella quotidianità può configurarsi come un qualcosa di distruttivo. Mi riferisco anche al tuo ultimo lavoro, che ancora non porta un titolo. Puoi raccontarlo?
GAC: È accaduto quattro mesi fa, qui ad Amsterdam, la sera del 24 novembre. Avevo lavorato senza sosta a un intervento nel mio studio che prevedeva di sommergerlo d’acqua fino a raggiungere il livello medio del mare, calcolato in circa 180 cm secondo le stime dell’ufficio competente (NAP, ovvero Normaal Amsterdams Peil). Lo spazio al di là del grande vetro, che separa i due ambienti dello studio, era completamente sommerso. Questa visione manteneva una sua coerenza con la condizione geograficamente depressa di quel luogo, che si trova sotto il livello del mare, mostrando uno scenario possibile. Mi trovavo in studio da solo, dopo cena. A un tratto il vetro è scoppiato, letteralmente esploso nella parte sinistra a causa della pressione che l’acqua esercitava sul vetro. Sono stato travolto. In una frazione di secondo mi sono trovato sommerso. Esattamente in quell’istante, varcando la soglia della rappresentazione e della finzione, sfondando quel vetro, quel limite, il lavoro aveva acquistato una sua autonomia per irrompere nella realtà. È stato sommerso tutto, computer e archivio, solo la radio continuava a trasmettere un estratto delle cronache sull’inondazione del 1953 nel sud dell’Olanda e dell’alluvione del 1966 a Venezia.
MA: L’incidente di cui parli è una conseguenza innescata dal tuo gesto. Anche in Scolpire il Tempo il processo in atto, nonostante sia meno evidente, è provocato dalle stesse due forze complementari che si fondono nelle sculture. Come funziona questa dialettica nelle Clessidre che compongono l’opera?
GAC: Riferendoti a questo lavoro, tu stessa avevi scritto che “le due forze, quella naturale e quella umana, si susseguono in un ritmo che scolpisce con fluviale continuità l’essenza e la forma delle sculture esposte”. Le Clessidre sono appunto una formalizzazione scultorea di un processo di erosione e scansione del tempo. Sono sculture in bronzo, ricavate dal calco di quei pali di legno che vengono piantati nella laguna di Venezia. L’azione altalenante della marea che sale e scende ogni sei ore scandisce il tempo di erosione consumando il legno nel punto di livello medio del mare. Il legno si assottiglia, si spezza e viene trasportato alla deriva dalla corrente. Questo pezzo viene prelevato, ricalcato, realizzato in cera in due esemplari identici assemblati specularmente in asse verticale e poi fuso in bronzo. La forma finale è appunto quella della clessidra, immagine di una misura del tempo, elemento simmetrico e speculare, natura tradotta in artificio. II processo di corrosione e passaggio del tempo viene congelato in una forma e in un materiale apparentemente incorruttibile, il bronzo. Il riferimento è ad Andrej Tarkovskij e al titolo del suo saggio sul cinema (Scolpire il tempo, ndr), dove è sempre l’acqua il mezzo rivelatore dell’immagine in movimento.
MA: Tempo. Ritmo. Divenire. Qual è la tua relazione con l’immagine?
GAC: Ho l’impressione che l’assidua presenza dell’informazione visiva, trasmessa ovunque e quotidianamente, atrofizzi la possibilità di immaginare e reprima la dimensione dell’immaginazione. L’immagine è qualcosa che viene evocato, stimolato e che permette di spingersi oltre. Non è qualcosa di fisso ma in continuo divenire; essa affiora, si condensa e poi si deposita nella nostra memoria. Quando quel vetro è scoppiato, il lavoro si è letteralmente svelato, come in una visione onirica. L’immagine si è manifestata. Quel che è rimasto dopo l’incidente aveva ancora la forza di suscitare qualcosa, di stimolare l’immaginazione, e proprio in quella frazione di secondo mi è stato “concesso di esperirla”. Per me quel momento, come un’epifania, era l’immagine in azione.
MA: E quindi si rende necessario trasferire nella matericità di un qualsiasi “supporto” (che sia una scheggia di marmo, l’estremità di un palo da fondere in bronzo) proprio la qualità “onirica” di una visione reale. Anche in ciò che resta di Sunset Boulevard è così?
GAC: Quell’azione compiuta a Los Angeles si è poi tradotta in un lavoro fotografico che cercava di restituire la visione di una città che è entrata nell’immaginario collettivo con il cinema hollywoodiano. Ho girato le strade in auto, chiuso dentro il bagagliaio, rievocando il romanzo noir e le scene di film in cui il morto viaggia chiuso nel baule della macchina. Attraverso un piccolo foro creato sul portellone, l’immagine dell’esterno penetrava nel buio come una proiezione cinematica. L’auto era diventata una sorta di cinepresa, e il bagagliaio un cinema. La visione alla quale assistevo dall’interno poteva essere restituita e cristallizzata solamente attraverso un’istantanea, esponendo la carta Polaroid alla luce per una frazione di secondo. Sunset Boulevard non è solo un riferimento al cinema, alla via che realmente ho percorso, ma anche a quella componente naturale, la luce, dal lasso di tempo che va dall’alba al tramonto, a cui era indissolubilmente legata l’esistenza di quella visione onirica. Quando il sole è tramontato, essa è svanita e anche il viaggio si è naturalmente concluso. La Polaroid era, in quel caso, l’unico mezzo possibile per restituire una sequenza di momenti “cinematici” ed era anche il mezzo più logico per catalizzare l’evanescenza della luce.

MA: Stai parlando di un’aderenza tra necessità, lavoro e mezzo. I tuoi lavori, infatti, sono quasi sempre il risultato di un gesto al quale tu assegni un peso reale e solenne. Come hai fatto, per esempio, a Carrara…
GAC: L’aderenza di cui parli è fondamentale. Il mezzo attraverso il quale si dà forma all’opera deve essere scelto consapevolmente e rivelarsi quello più adatto allo scopo. Il gesto, anche quando è secco e risoluto, è quasi sempre frutto di una lunga riflessione. Il gesto compiuto a Carrara è stato quello di staccare una scheggia dalla montagna, non di modellare un blocco. Non si tratta di una scultura. La scheggia non viene elevata formalmente, ma trattiene la sua purezza, una purezza informe. Nel gesto di estrazione non si instaura una gerarchia tra artista e lavoratore. Il riferimento al luogo dove il gesto si è compiuto si trasferisce in quella chiesa dove il blocco è stato deposto. In quel luogo, quindi, viene evocata la montagna. Non siamo nemmeno più in una chiesa. I simboli sacri sono coperti da grandi teli e nello spazio non esiste nemmeno una gerarchia simbolica. Tutto viene livellato allo stesso grado zero. Anonimo come deve essere la morte.
MA: Parlando di gerarchia, l’asse orizzontale sembra essere per te particolarmente importante. Non solo a livello astratto e simbolico, ma anche rispetto a un’idea di migrazione, di viaggio e di spostamento verso l’esterno, al di fuori dagli spazi istituzionali. Sia il cammino sia il viaggio sono modi che molti artisti hanno “incorporato” in epoche, in declinazioni e per necessità diverse (basti pensare ai surrealisti e ai situazionisti, al viaggio di Constantin Brancusi o a quello di Werner Herzog). Tu come ti poni rispetto a questo tema?
GAC: Il cammino va inteso innanzitutto come un movimento, mentale prima che fisico, e come una possibile via di riflessione. Quello che mi interessa è la povertà insita nell’atto del camminare, la sua semplicità. Per me non rappresenta un atto estremo, né eroico, né radicale. Nel cammino il corpo è impegnato nella sua dimensione naturale e, proprio attraverso il suo lento e progressivo cambiamento, diventa al contempo azione e mezzo espressivo. C’è un punto di partenza e un punto di arrivo, è all’interno di questo frangente, di questo segmento spazio-tempo, che si compie un percorso interiore, si dà forma a un concetto, a un’intuizione. Progressivamente si instaura un’unità tra esterno e interno, tra la lenta modificazione del paesaggio e di chi lo sta attraversando. Quando nel 2008 ho fatto quel lungo viaggio, attraversando Francia, Spagna e Portogallo, il punto di arrivo era un’icona, un’immagine che avevo trovato a Venezia e che nella sua realtà era conservata a Limpias, in Spagna. Riflettere e tendere verso quell’icona voleva dire lentamente assimilarla, arrivando a rispecchiarsi per tornare a se stessi. In questo si traduce la dimensione fisica e psicologica dell’attraversamento.
MA: Attraversamento, ritorno o liberazione? Cosa pensi sia doveroso fare nel presente?
GAC: Noi tutti siamo portati a considerare le sicurezze consolidate nel tempo come dei punti fermi. Questo vale molto nel percorso di un artista; quando un lavoro si è consolidato si manifesta anche il rischio di rimanerne prigionieri, cementati. Prigionieri della paura di perdere quel luogo, e un passato sicuro. Allora, rimettere in discussione tutto è liberarsi, per iniziare da capo.