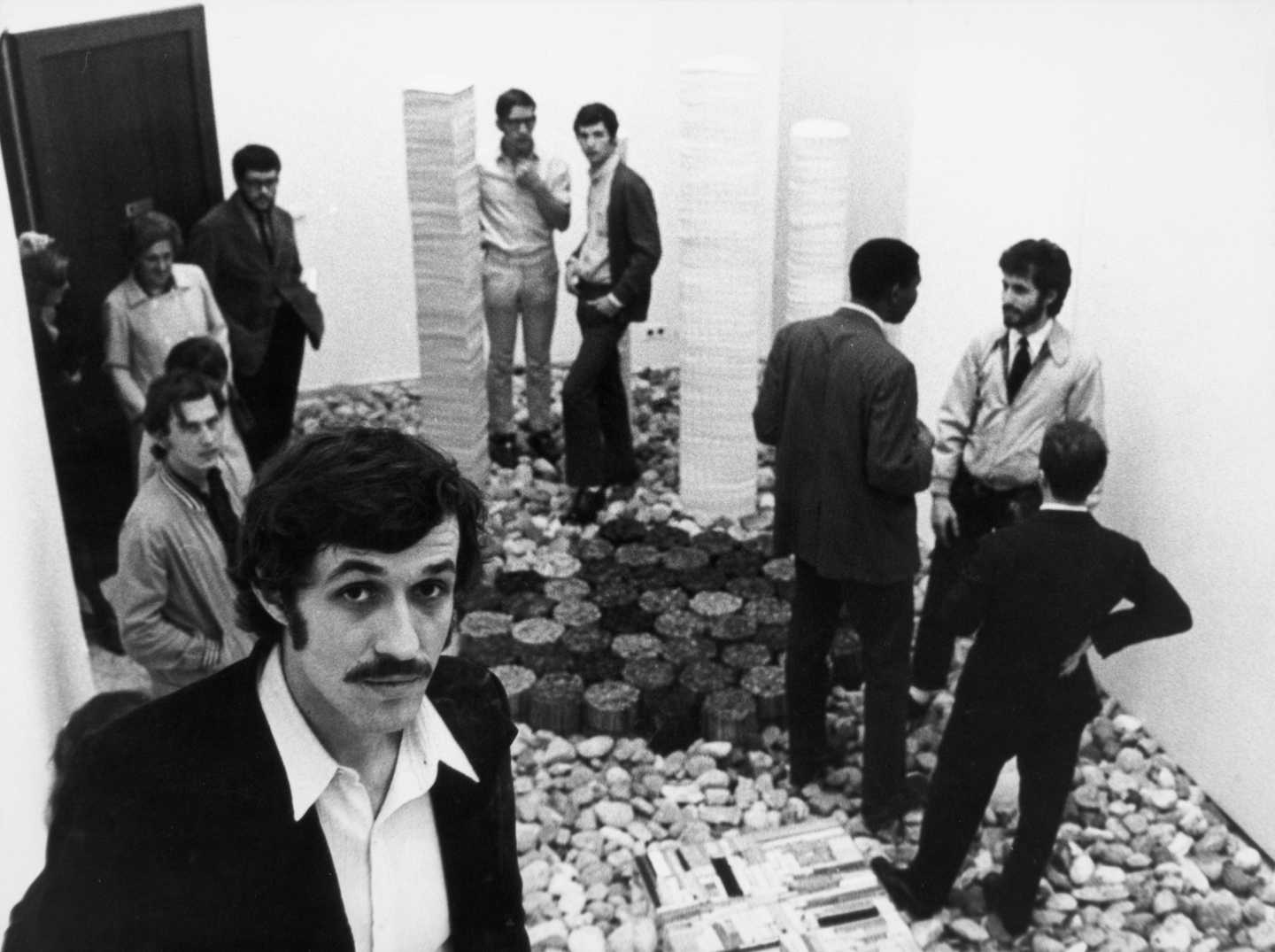Alberta Gnugnoli: Signora Freund, che studi ha fatto?
Gisèle Freund: Preso il Bac, m’iscrissi alla scuola di Sociologia di Francoforte — vivevo ancora in Germania — dove insegnavano Karl Mannheim, Horkheimer, Adorno e dove si faceva della ricerca, almeno fino all’avvento del nazismo. Ma amavo soprattutto la letteratura: leggevo Mann, Kafka, Brecht… Quanto all’arte, la mia casa era una specie di museo, dato che mio padre era un appassionato collezionista di pittori romantici tedeschi. Da lui ho imparato ad amare la bellezza nell’arte e a cercarla poi ovunque. Fuggita a Parigi dopo la presa del potere da parte di Hitler nel 1933, m’iscrissi alla Facoltà di Lettere all’Università di Parigi e nel 1936 discussi la mia tesi alla Sorbonne: La Photographie en France au dix-neuvième siècle. Tra gli amici venuti ad ascoltarmi c’era Walter Benjamin. Fu pubblicata da Adrienne Monnier che, benché trattasse solo opere di poeti, si era interessata alla novità dell’argomento — l’analisi della fotografia dal punto di vista sociologico. Fu un lavoro difficile dato che praticamente non esisteva bibliografia sull’argomento. Mi dispiace che a tutt’oggi sia un’opera molto citata ma ancora poco conosciuta.
AG: E i suoi approcci con la fotografia?
GF: Del tutto empirici. Mio padre mi aveva regalato una Leica piccola, una novità per quei tempi, e io, da amatore, sviluppavo da sola le immagini con una carta seppia che poi ho scoperto usava anche Atget. Rifugiata a Parigi, vivevo con lo scrittore tedesco Horst, che non riusciva a vendere i suoi articoli. Bisognava dunque sopravvivere, e, incoraggiata da un amico, Wolfgang Schade, redattore della Kölnische lllustrierte, cominciai a fare dei piccoli reportage, cioé delle storie per immagini, sviluppate attorno a un’immagine simbolica che contenesse già la vicenda. Era un genere ancora tutto da inventare. Così ripresi lo spettacolo del Gran Guignol ai Giardini del Lussemburgo, fotografando i visi di un bambino e di una bambina i cui rapidi mutamenti d’espressione riflettevano lo sviluppo dell’azione scenica. Incredibilmente, fu il successo di quei miei primi lavori a urtare la suscettibilità di Horst. In seguito ci separammo. Quando decisi di prendere lezioni di fotografia, non ebbi molto successo. Dopo aver rinunciato a Man Ray perché non potevo permettermi la somma che mi aveva chiesto, andai da Florence Henri, pittrice e fotografa, che faceva buoni ritratti su commissione e quindi con abbondante ricorso al ritocco, cosa che mi sono sempre rifiutata d’imparare. Ci la-sciammo dopo un po’ di tempo, visto che, secondo il suo giudizio, non sarei diventata mai una buona fotografa. Ancora oggi dico che la fotografia come opera d’arte o come frutto d’abilità tecnica non è mai stata il mio obbiettivo. Personalmente non amo stare nella camera oscura; amo vedere i soggetti umani nel momento in cui entrano nel campo visivo della macchina.
AG: Ma torniamo al reportage…
GF: È la base della fotografia perché pone il fotografo a contatto diretto con le realtà sociali e geografiche. È appassionante perché tutto dipende dalla tua iniziativa, talvolta anche la scelta del soggetto, ma è anche un lavoro precario, dove non si guadagna perché ci sono troppe spese. Non si guadagnava nemmeno negli anni d’oro Quaranta e Cinquanta. Non lo si apprende con una scuola; del resto con un buon apparecchio, una solida base culturale, la conoscenza delle lingue, e una notevole adattabilità a qualsiasi circostanza, non è difficile beccare l’immagine giusta. Certo, oggi, dopo l’avvento della televisione e la sparizione di Life, il mito leggendario del fotoreporter è morto o perlomeno non fa più sognare. Anche se è rischioso, personalmente l’ho sempre preferito ad altri generi fotografici, fatta eccezione per il ritratto.

AG: Qualche esperienza indimenticabile come fotoreporter?
GF: Quando nell’estate del 1940 decisi di fuggire da Parigi e senza un soldo raggiungere, su di un cargo spagnolo, l’Argentina, viaggiai lungo tutto il continente sudamericano, per fare reportage e guadagnarmi da vivere. Un giorno Life m’incaricò di andare fino alla Terra del Fuoco a fotografare sottomarini tedeschi presumibilmente nascosti nei canali dell’isola. Raggiungere la terra più desolata, disabitata e fredda del globo, fu un’avventura interminabile, un rischio senza precedenti, per arrivare a scoprire che lì i sottomarini non potevano esserci a causa dei fondali pericolosi e delle numerose scogliere. Decisi allora di fare un reportage sui pochi indiani che abitavano ancora la Terra del Fuoco. Ma Life non lo pubblicò. E questi sono gli incerti del mestiere. Alcuni anni più tardi, nel 1950, sempre Life mi mandò a fare un servizio su Evita Perón e la sua vita privata. In quell’occasione ebbi veramente paura per la mia vita. Evita mi aveva mostrato con vanità e orgoglio tutto il suo guardaroba, i suoi gioielli, ma il Ministro dell’informazione, saputa la cosa, mi ordinò di presentarmi, il giorno seguente, nel suo ufficio con tutti i negativi. Un’ora prima dell’appuntamento presi l’aereo mettendo in salvo il mio lavoro. Seppi che qualche ora più tardi era giunto all’aereoporto l’ordine di negarmi l’imbarco.
AG: Come donna, il reportage le poneva dei problemi?
GF: Innanzitutto non era facile il rapporto con i fotografi all’interno della “Magnum”. Anche nella fotografia si tendeva a relegare la donna al suo ruolo familiare — il ritratto di famiglia, per esempio — ma io non avevo figli, anche se ero già sposata, e volevo viaggiare. Sul lavoro, dato che ero giovane e non brutta, mi consideravano più come oggetto che come soggetto che opera. I colleghi maschi tentavano di sopraffarmi. Ricordo, qui a Parigi, quando Life mi mandò a fotografare il Generale Eisenhower: c’erano già una cinquantina di fotografi ad attenderlo e io che sono piccola fui letteralmente schiacciata dalla loro presenza. Ma il Generale se ne accorse e quando gli altri ebbero finito di fotografarlo, si avvicinò a me e mi disse: “Madame, vuole seguirmi? Ora sono soltanto per lei!”. E così me ne andai con il Generale sulla sua macchina in Bolivia, nelle miniere di stagno, gli indigeni non volevano farmi entrare perché dicevano che la donna portava male. Ho però anche avuto dei vantaggi. Le donne scrittrici si sono sempre lasciate ritrarre, preferendomi a un uomo, da cui temevano di non essere capite.
AG: Consiglierebbe, a una donna, il reportage?
GF: Sì, purché abbia coraggio, una salute di ferro, tanta pazienza, e sappia prendere all’occasione decisioni rapide.
AG: I suoi rapporti con la “Magnum”?
GF: Lei saprà certamente che si chiamava così dalla marca di champagne preferita da Robert Capa. Ci sono stata sette anni, dalla sua fondazione; conservo ancora il contratto da me firmato nel 1947. Vi entrai perché allora un fotografo aveva bisogno di un’agenzia che ne difendesse i diritti, dato che sulla vendita delle immagini non esisteva alcun controllo. L’idea di Capa di farne una cooperativa di fotografi mi parve intelligente e poi alla “Magnum” si discuteva sempre. I fotografi avevano in comune l’idea e il desiderio d’interpretare la realtà unicamente attraverso le loro immagini. Comunque, nonostante il mio lungo rapporto di lavoro, l’Agenzia ha sempre deliberatamente omesso il mio nome negli articoli che parlano della sua storia prestigiosa, come se non ci fossi mai stata. In realtà, furono Robert Capa e Chim (il cui pseudonimo americano fu, poi,
David Seymour) a ordinarmi di uscirne, quando nel l954 mi fu negato il visto d’ingresso negli Stati Uniti, probabilmente perché nel mio soggiorno in Messico avevo frequentato artisti di sinistra, come il pittore Diego Rivera. Ma era il periodo maccartista della caccia alle streghe e dato che l’Agenzia lavorava soprattutto con clienti americani, Capa e Chim temettero che la mia presenza sarebbe stata di danno agli interessi della cooperativa. Quanto all’America, ho rifiutato per diciotto anni di esporvi le mie foto e solo molto più tardi, nel l970, ho accettato di richiedere il visto che mi è stato accordato.
AG: Dal reportage al ritratto…
GF: Con il reportage mi sono guadagnata da vivere, ma con il ritratto è stata un’altra cosa. Ho sempre scelto io il soggetto da fotografare, senza fare mai alcuna concessione al ritocco. Non l’ho mai considerata una fonte di guadagno ma di piacere. C’era una corrente di simpatia che mi legava al soggetto. Erano tutti amici: Joyce, Man Ray, Cocteau, Colette, Henry Miller… Il primo fu Malraux. nel 1933, già Premio Goncourt, già famoso, a chiedermi di fargli il ritratto, forse per aiutarmi finanziariamente facendolo pubblicare. Poi scoprii la magia del colore e mi venne l’idea di fare una collezione di ritratti a colori, di scrittori dell’epoca, ma sempre per mio diletto… Dovevano passare alcuni anni prima che le riviste fossero tecnicamente in grado di riprodurre la stampa a colori, così il mio ritratto di Colette fu pubblicato per la prima volta in Francia solo nel l940 su L’Annuaire de la Photographie.
AG: Il segreto di un buon ritratto?
GF: Che vi si trovi tutta la personalità del soggetto — e non quella del fotografo — con i suoi gesti abituali, le linee caratteristiche del suo volto. Insomma che sia immediatamente riconoscibile come il ritratto di Joyce, e non come la fotografia di Gisèle Freund. Per questo non ho mai lavorato in studio come altre fotografe, ma ho preferito recarmi dal soggetto, entrare nel suo ambiente naturale, fatto di oggetti, orari, situazioni, che parlano di lui, del suo universo interiore. E poi il personaggio è più rilassato.

AG: È importante la cultura per un fotografo?
GF: Essenziale, a mio avviso, perché c’insegna a vedere. Nelle scuole di fotografia si dovrebbero insegnare la sociologia, la storia dell’arte, e non soltanto la tecnica. Con l’occhio vediamo ogni sorta di cose, ma soltanto quelle che sono selezionate dal cervello, vale a dire dal nostro background culturale, entrano nel campo visivo della macchina fotografica. Mio padre era un collezionista e io ho passato con lui molto tempo nei musei e nelle gallerie. La cultura è necessaria per leggere l’immagine nel suo autentico contesto, aldilà delle mistificazioni di cui essa è inevitabilmente oggetto attraverso i suoi molteplici e contradditori usi. A forza di vedere, non vediamo più, l’immagine stessa ci diviene indifferente.
AG: In cosa consiste la qualità di una fotografia?
GF: Nel grado di emozione che riesce a provocare in noi. Virtuosismi tecnici a parte, la fotografia resta sempre e comunque una creazione mentale e, come diceva Weston, “L’espressione” di una personalità, di un mondo interiore. Poche sono le immagini che ci toccano profondamente; eppure il linguaggio della fotografia è universale. Quanto a me, che sono vissuta in un’epoca di orrori e di atroci incomprensioni, l’ho praticata senza la pretesa di creare un’opera d’arte, ma con la speranza di comunicare qualcosa di nuovo, di emotivamente personale che rivelasse l’uomo e se stesso, lo avvicinasse agli altri uomini, estendesse la sua conoscenza.