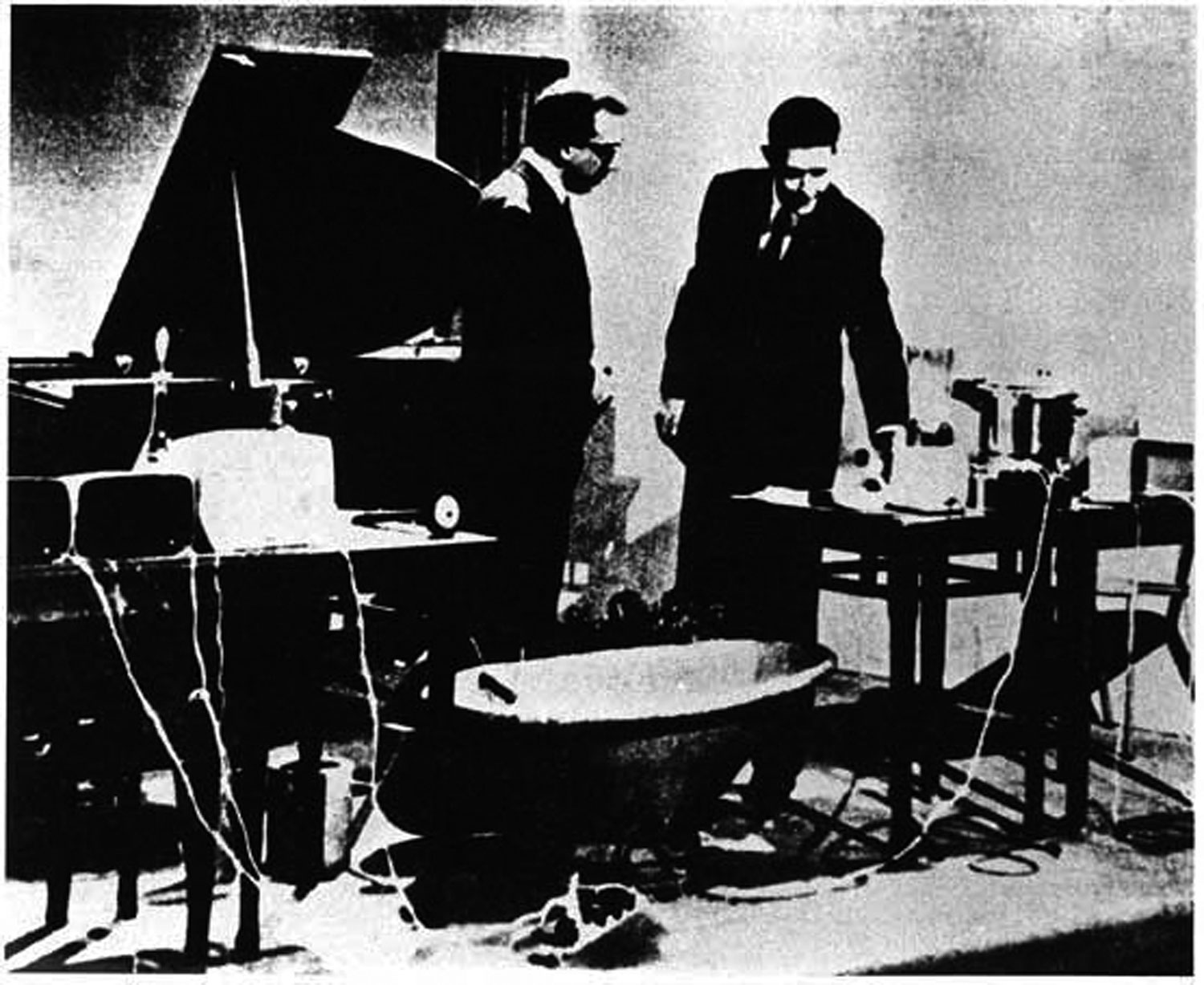“FACCIA GIALLA! FACCIA GIALLA!” è il grido delle “parenti del Santo”, le fedeli di San Gennaro che così lo apostrofano, con un grido insieme strafottente e devoto, incitandolo a compiere il miracolo. “Faccia gialla” è il volto d’argento dorato del Santo, ed è anche la faccia itterica del malato per cui si invoca la grazia: il colore del contagio, della quarantena e del veleno. E giallo è il colore della carta su cui Giulia Piscitelli ha tracciato i disegni che aprono (o forse chiudono) “Protocollo”, la mostra tenutasi a Napoli pochi mesi fa. Quando inseguo la mia ombra è il titolo di due pagine di quaderno su cui appare un reticolo a matita simile agli schemi “da riempire”, gli esercizi di pigrizia applicata dei giornali di enigmistica. Sono autoritratti in cifra, o forse anche mappe per non ritrovarsi: fanno venire in mente le foto cancellate di Arnulf Rainer, con i segni neri che si allargano su una faccia ricacciata con violenza sul fondo. Nella loro mescolanza di sfi guramento e dissimulazione, di malattia e convalescenza, di ironia, autodisciplina e sarcasmo intelligente, ritrovo il carattere di molti lavori realizzati da Piscitelli (classe 1965) in questi ultimi anni, dopo un periodo di incubazione creativa durato due decenni — un caso che mi pare senza equivalenti nella scena artistica italiana contemporanea. Se dovessi trovare una formula sintetica per descrivere questo percorso, direi: una celebrazione del quotidiano compiuta allo scopo di smantellarlo, oppure di scomporlo e spolparlo, un po’ come si fa con un oggetto rotto, per vedere se è possibile comunque salvarne qualche pezzo. E ci si può servire di qualsiasi cosa: un lenzuolo à la Burri, rammendato fino all’estenuazione (Rammaggio, 2000); una scala di legno sghemba, come per una caviglia storta (Scaletto organico, 2007); una bandiera multicolore che ha perso letteralmente la parola per il troppo sgolarsi (Pac, 2003). Oppure, come nella serie degli “Arazzi”, è lo stesso medium che si incarica di accelerare il deperimento. Qui la pittura, invece di colorare, scolorisce, agisce per sottrazione e, usando la candeggina come “rivelatore”, mangia il tessuto come in un lavaggio sbagliato. Ne escono fuori forme familiari, sagome di pesci, oggetti e animali morti ritagliati su fondi di colore compatto (Pesce spada; Lucertola su strada, 2008). È una soglia al contempo allegorica e semiotica: ritratti malinconici dell’azione corrosiva del tempo, della sparizione, attraverso una pittura che fuoriesce dalla sua dimensione iconica e si fa marchio, impressione, indice, mise en abyme del procedimento fotografico, oggettivazione impersonale.
Il tempo, ancora il tempo. In un Super 8 mm del 1989, per la durata di due minuti e nove secondi, due mani puliscono sotto l’acqua corrente un teschio sporco di terra (Senza Titolo). Per diciotto minuti e ventitré secondi, invece, Rodolfo centodue (2002) consuma un pasto di fronte ai nostri occhi di commensali non invitati: metodico, attento, completamente assorbito in un’azione che nella gestualità elementare di un vecchio riassume come un’epigrafe il senso di una vita, nonostante tutto. E, in un altro video, per due lunghi minuti e sedici secondi (Senza Titolo, 1997), una torcia elettrica illumina un ripostiglio ingombro di oggetti, libri e vestiti. Un ritratto in contumacia si potrebbe chiamarlo: qualcuno c’è stato, è andato via, è latitante, è morto, è vivo, torna, non torna. Tutte le domande e tutte le risposte sono possibili; sullo sfondo, l’idea che la presunzione di conoscere l’altro sia patetica quanto quella di afferrare se stessi. Nel lavoro di Giulia Piscitelli, in effetti, il conoscere sembra coincidere sempre con il fare esperienza di ciò che non sappiamo di sapere, come avvertire una fi tta o sentirsi pungere da qualcosa che buca da dietro lo schermo.

Un pensiero improvviso: cambiar pelle, faccia, mestiere, vita. Così, l’artista va in giro indossando la maschera di un animale feroce (Tigre, 2005), oppure, in quello che rimane il suo lavoro più performativo e autobiografico (un video senza titolo del 1995), di fronte a uno specchio e con le spalle rivolte alla videocamera, si taglia i capelli e li infi la in bocca, si passa ossessivamente il rossetto sulle labbra, spalmandolo su un volto trasformato in maschera sotto lo sguardo inerte di una sagoma femminile sullo sfondo. Figlia/madre, donna/uomo, desiderio/ repulsione: le opposizioni si toccano in un rituale di iniziazione sadomasochistica, di redenzione e punizione che segna il passaggio a una maturità ormai non più rimediabile. Sono tutte immagini attraversate da una duplicità perturbante e da una precisa cognizione del paradosso: la fedeltà a se stessi non può che essere convenzionale, come la natura dei codici e dei media. Non c’è altra via d’uscita se non l’incredulità verso il proprio stesso travestimento, in cui tuttavia si ripone alla fine ogni speranza. Far finta di scherzare senza essere seri. Il beckettiano ed enigmatico germano che ascolta imperturbabile su una sola zampa il vaniloquio dell’ubriaco berlinese nel video Unter den Linden (2008) decide alla fine di volare via: se le cose facili non riescono, vale la pena provare quelle impossibili.
Guarire, guarirsi. Si potrebbe dire che, lungo tutto il suo percorso artistico, Giulia Piscitelli abbia cercato di praticare la difficile arte di una medicina omeopatica con cui curare l’avvelenamento con il veleno, la mancanza con la perdita. È proprio questa valenza a emergere dalle altre “stazioni” della mostra “Protocollo” (un nome che richiama non a caso la sequenza di una terapia): un video in bianco e nero dalle immagini sfocate, in cui sagome ectoplasmatiche cercano invano di muoversi all’unisono (Plessimetro); una Polaroid ingigantita con la sagoma inquietante di una nuca calva (Sunshine); il primissimo piano di una massa di capelli (Non ti riconoscevo per un pelo); un “arazzo” nero su cui appare una chioma o una criniera (Tornado, il formidabile destriero di Zorro). Possiamo leggere questi elementi in chiavi di volta in volta diverse: dal punto di vista temporale, le immagini sottintendono una progressione, una sorta di transito dal passato verso il presente; dal punto di vista dell’esperienza, convocano strati di ricordi traumatici con un procedimento di liberazione emotiva; sul piano figurativo, visualizzano e mettono in relazione le tappe di un percorso che dallo spazio reale retrocede fin dentro quello dell’immaginazione e da lì si riverbera nel luogo occupato dallo spettatore; sul piano semiotico, infine, si dispongono su un asse che va dall’iconico all’indicale, in modo tale che ogni “tappa” contraddica e riconvochi la precedente. Tutte queste componenti sono intrecciate tra loro come i capi di una tessitura: sono distinte ma solidali e mutuamente necessarie: offrono, osservate nel loro insieme, l’immagine di un dispositivo di ri-sensibilizzazione, una macchina mentale il cui combustibile è il trauma stesso e la cui logica è l’isolamento, la scissione dell’esperienza traumatica nelle sue componenti elementari. Come in un esperimento di fisica sperimentale, l’esito non è mai garantito: il risultato può essere futile o controproducente, e coincide sempre con la riproposizione del problema, con un’ulteriore trafittura. Sottrarsi è, ancora, un compito impossibile.