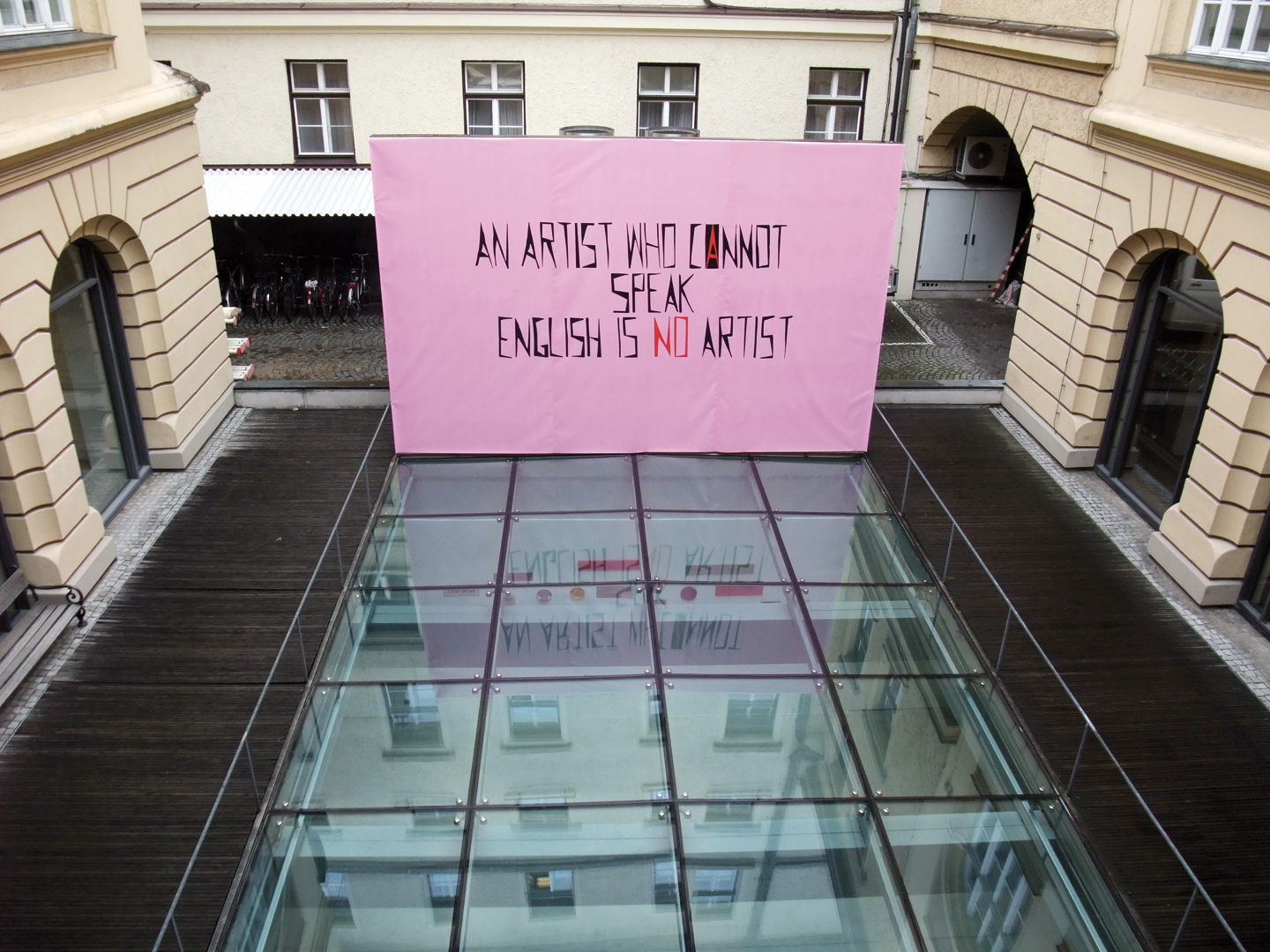In pochi si sono raccolti per vederlo: il bambino tiene un dito in bocca e sonnecchia nudo su un panno bianco disposto a terra. Hanno scelto delle rovine lontano dalla città per presentarlo. Hanno convocato santi e suonatori ma, nonostante il momento lieto, nessuno accenna un sorriso. Nemmeno i suoi genitori. La sinfonia di archi e chitarre si perde nel vento che arriva dalle montagne e sembra che in quell’angolo arido e tagliente di mondo si siano dimenticati che esistono i fiori. L’adorazione si svolge sotto un cielo pallido e gelatinoso, come la polpa di un pesce. Ammantati da quella luce lunare, due volti sghembi e acuminati hanno acceso da sempre la mia ammirazione per Bramantino: un francescano e un domenicano dai crani lucidi che, fianco a fianco, ammirano genuflessi il prodigio appena nato. Occhi naso e bocca da tagliagole, le dita quelle di una donna. Ci tenevo che li vedessi dal vivo anche tu per parlarmi dell’importanza della deformazione nel tuo lavoro.
La deformazione è una questione legata alla mia passione per il figurativo. Il volto è di per sé una delle cose più comunicative che esistano perché basta un lieve spostamento di un tratto somatico per variarne l’espressività. Deformando puoi andare ben oltre l’espressività umana per evocare territori sconosciuti.Se guardi molto attentamente le figure dei volti che abitano la storia dell’arte ti accorgi che le più intense e interessanti sono tutt’altro che naturali. Bambini che sembrano vecchi, lineamenti femminili ibridi tra l’umano e l’animale, incarnati cadaverici, sguardi taglienti, occhi come fessure. I volti di alcune figure di Giotto o Simone Martini, per fare solo un esempio, sono così intensi e magnetici non certo perché realistici, quanto piuttosto perché capaci di evocare un senso di presenza alieno e impenetrabile. Alcune figure particolarmente efficaci hanno un effetto inquietante in qualche modo simile a quello di essere di fronte a un cadavere, solo che al contrario di questo che seppure composto di materia organica appare morto, un’immagine è composta di materia inorganica ma appare “viva”. Non sono come fotografie, sono un’altra cosa, sono molto di più.
“Perché dipingi spesso i tuoi personaggi in giacca e cravatta? Che valore ha l’eleganza?”. “Più che dalla trasgressione di un comportamento, sono affascinato da chi ha formulato le idee che rendono possibile quel comportamento. E, molto spesso, queste idee sono frutto di una specie di rigore, di cura della forma nell’esercizio del pensiero. Per molti, l’eleganza, tipo quella ottocentesca, è sinonimo di pedanteria. E in parte hanno ragione. Oggi però ho l’impressione si sia raggiunto l’estremo opposto, cioè un atteggiamento informale al limite del disinteresse. Forse il fascino che io provo per queste figure seriose, raccontate da foto ormai sbiadite, che appaiono tra il grottesco e il metafisico, è una forma di compensazione. Incuriosito dal fascino che subisco sempre per l’eleganza esibita da un presentatore anni Sessanta, oppure da quella dei componenti di un’orchestra, mi sono domandato come mai, in generale, la gente si veste bene, cioè come mai si prende cura della forma nelle situazioni che considera importanti. Mi chiedevo che cosa spinge l’uomo al decoro. E ciò ha a che fare con la ritualità. È l’etimologia stessa della parola a suggerirne il senso, visto che “decoro” deriva dalla parola “decenza”, che a sua volta rinvia alla funzione di onorare, di rendere omaggio, cioè di un modo di essere dignitoso e senza affettazione di fronte a qualcosa che si considera di valore”.
Anche se oggi siamo letteralmente immersi da immagini, per cui hanno perso molta forza e capacità di stupire, non si può sottovalutare o dare per scontato il potere empatico e comunicativo dell’immagine figurativa. Mi sa che questo lo capiscono molto meglio i pubblicitari e le agenzie di comunicazione di noi artisti.
A mio avviso la figurazione è tutt’altro che un capitolo chiuso e vorrei esplorarne alcuni confini. Tramite l’immagine scattano in noi dei meccanismi feticistici e animisti che sopravvivono alla modernità, come la tendenza a commuoversi per la foto di un vecchio amore, di noi stessi da giovani, oppure per una persona che non c’è più. L’immagine fa da tramite tra coppie di concetti come vita e morte, presenza e assenza, realtà e apparenza.
Rileggendo questo scambio di battute, che ho ricostruito tra quello che mi ricordo della visita a Bramantino al Castello Sforzesco, qualche email e un paio di chiacchierate al bar, penso a quanto sia diventata indispensabile nella nostra vita l’immagine con cui ci si mostra agli altri, con cui ci rendiamo un oggetto pubblico. E di conseguenza alla responsabilità indotta che comportano certe scelte: il taglio di capelli, gli occhiali, le scarpe, i vestiti. Fino a qualche decennio fa, per la maggior parte delle persone, l’immagine pubblica di sé rispondeva a una situazione straordinaria (la domenica, il matrimonio, la morte…) ora si è sovrapposta alla quotidianità.
I tuoi occhiali hanno attirato la mia attenzione appena ti ho conosciuto: lenti non molto grandi, montatura fine e trasparente piuttosto arrotondata. C’è qualcosa in te che mi ha sempre dato l’impressione di aver di fronte un chimico, o un farmacista; insomma, una persona che conosce il peso e la qualità delle cose. Forse perché era una sera di dicembre, e indossavi un lungo cappotto nero, mi hai ricordato una di quelle silhouette allungate, tipiche dei boulevard di Pissarro, asciutte, pulite, formali — con la sola eccezione dei capelli scompigliati, portati un po’ all’indietro. E, nonostante il ritardo all’appuntamento, il tuo passo era rigido e composto; salvo poi, dopo avermi salutato, esserti scusato così: “Mi dispiace, ma ieri sera mi sono spaccato”.

Da lì ho intuito quanto il paradosso facesse parte di te e dei tuoi lavori: una passione incondizionata per il figurativo, l’aspirazione alla geometria, il controllo dello spazio, la tendenza alla distruzione, la filosofia. E, mi pare, tu abbia detto pressappoco: “Vedi, il motivo per cui il paradosso ci emoziona è che ci toglie il terreno sotto i piedi, giusto il tempo necessario per farci provare quella vertigine che fa ondeggiare tutto”.
E questo stato d’ironia crudele emerge nel tuo primo lavoro che ho visto: Il filosofo e l’architetto (Materia disposta secondo intelligenza). Due anime nere, in completo elegante, si stagliano su un fondo a strisce giallo/verdi che ricorda la carta da parati di un salotto reganiano. Delle due figure, quella che sta dietro — abietta, corrotta — con una mano stringe la spalla del malcapitato, con l’altra gli offre qualcosa: un cavolfiore romano appeso a qualche decina di centimetri dalla superficie del quadro. Nonostante abbiamo avuto modo di discuterne diverse volte, sinceramente non m’interessa capire la relazione fra il dipinto e il vegetale. Il fatto di percepire che nell’improbabilità della tua associazione ci sia la possibilità di un principio ordinatore mi è bastato. È talmente assurdo, eppure familiare. Hai ragione tu: “il cavolfiore è così bello da sembrare una cattedrale”.
“Definire lo spazio è come fa un cane che piscia su un albero”, mi hai detto via Skype. C’ho riflettuto e mi sono chiesto se la rappresentazione dello spazio (la planimetria di un edificio, il mappamondo o il planetario) non sia altro che un atto mentale per definire il luogo in cui siamo contenuti, ma, soprattutto, la nostra posizione all’interno di quel sistema. Sapere dove sono mi aiuta a capire chi sono. Inabitants (in un stesso luogo suggestionati da diversi spazi) è un lavoro che ho trovato significativo al riguardo: sopra i volti trasfigurati di Heidegger, Van der Rohe e Ungaretti sono sovrapposti dei cerchi incisi sul vetro secondo i modelli di antiche ipotesi del nostro universo.
“Se tu guardi le forme dei sistemi solari sembrano decorazioni tribali, delle specie di Mandala. Dietro trattati e raffinatissime speculazioni, si nasconde un istinto primitivo. Quando ragioni profondamente, ti meravigli di esistere e ti chiedi dove vivi e chi sei”. “Ma c’è una relazione con i pensatori?”. “Nessuna in particolare, credo. Spesso sono i loro volti a colpirmi. Quando il pensiero di un autore mi coinvolge mi viene da dipingerlo, specialmente se poi anche il loro aspetto ha altrettanto fascino. Impressa nei loro volti intuisci la dimensione del pensiero che ha lasciato la sua traccia. Pensa a Beckett”. “Però, l’uso che fai della geometria combatte l’idea di chiarezza, stabilità e ordine”.
C’è una profonda relazione tra geometria, ragione e stupore. Spesso si distingue la ragione dal sentimento. Io penso che anche la ragione paradossalmente produca emozioni. Ci sono emozioni che producono pensieri così come pensieri che producono emozioni, alcune delle quali destabilizzanti e vertiginose. La mia poetica è ancora in gestazione. Da un lato sento una fascinazione fortissima per le forme più pure e asciutte moderniste, con tutto ciò che quelle scelte estetiche comportano eticamente, e dall’altro mi rendo conto che la mia italianità mi attrae verso forme di figurazione anacronistiche, a generi minori della pittura del passato, a volere difendere una mia singolarità che non vorrei ridotta da nessun “ismo”. Non riesco ancora a decidermi, ma credo che dalla contraddizione di questa tensione possa venirne fuori qualcosa di interessante e singolare che rifletterà questo mio disorientamento culturale.
C’è un lavoro, Perfetto sconosciuto (minuscole particelle di materia fuori e dentro una prospettiva), in cui questa dicotomia tra figura e geometria dà origine a un’immagine molto suggestiva: una zona franca dove il tempo non si cancella. Dalla testa di un uomo, in una vecchia fotografia, partono dei fili che formano sul pavimento un poligono irregolare dove la polvere non viene rimossa. Penso al fatto che, se tenere pulito uno spazio significa cancellare il tempo trascorso, il tempo è materiale e può essere rimosso, spostato, aggiunto o imbrogliato.
Quell’opera nasce dalla pigrizia. Quando sono andato a Milano a studiare e ad abitare da solo ero impressionato dalla rapidità con cui la polvere si andava a posare dappertutto. Quando poi mi decidevo a toglierla era spessa e visibile come una velatura. Una cosa pittorica. Mi veniva da pensare quanto in realtà nella nostra cultura occidentale siamo istintivamente portati a rimuovere ogni traccia del tempo e della sua azione. Graffi, ammaccature, macchie, tutto viene riaggiustato, ripulito, ridipinto. Rimosso, in sostanza, come rimossa è sempre la coscienza della morte. L’acqua che ristagna non rappresenta un tempo distruttore, ma creatore; così in quel opera ho provato a conviverci piuttosto che combatterlo: dietro la rimozione c’è la paura della morte, dietro l’accettazione c’è la fede nell’eterno.
“Non hai paura di invecchiare?”
“Sono profondamente spaventato dalla vecchiaia. Ho scelto l’arte perché significa puntare su qualcosa di stabile anziché d’effimero”. Mentre mi parli di queste cose penso a Giovanni Drogo, il protagonista de Il Deserto dei Tartari, e mi torna la paura di sprecare il tempo. Di non aver abbastanza coraggio di vivere pienamente e di compiere delle scelte, ora che, a quasi trent’anni, niente è ancora definitivo. Prendi il tuo Campo di girasoli: centinaia di semi sospesi a mezz’aria, in una condizione di attesa perpetua. In potenza sarebbero dei fiori bellissimi; al momento solo dei punti neri che fluttuano lontano dalla terra, il loro posto nel mondo. Ecco ciò che m’interessa in quello che fai: il senso dell’attesa. Proprio come Drogo, che attende una vita la guerra che giustifichi il suo isolamento, tutti i sacrifici compiuti.

“È come se vivessi prendendo la rincorsa. Vivere pienamente il presente è quasi impossibile. Studio molto, m’informo, cerco di capirci qualcosa di questo momento storico in cui mi sento completamente disorientato. Mi domando cosa significhi oggi essere artista, come scongiurare il rischio di fare un’arte irrilevante, incapace di cogliere lo spirito del tempo. Mi guardo intorno nel mondo dell’arte e vedo un gran caos. L’unica soluzione, penso, sia quella di seguire l’intuito e provare piacere nel fare ciò che fai. Intendo seguire un’urgenza espressiva senza pensare alle conseguenze”.
“Sì, ma adesso che fai?”
“Adesso, dopo un paio d’anni a Berlino, sono tornato a casa per ricostruire il senso di stare a mio agio, fondamentale per me per pensare poeticamente, e di essere in una buona condizione fisica, senza un ambiente che ti mette ansie da prestazione”.
Non si capisce bene cosa sia l’arte o meglio la poesia. Di certo è qualcosa che nomina zone della sensibilità prima inesplorate, schiarendole e rendendole comunicabili. Io penso che l’ideale per un’artista sia quando il linguaggio comune lo adotta rendendolo così parte della realtà esistente, come quando si dice di una situazione che è kafkiana o che un’atmosfera è lynchana. Cioè quando da soggetti si diventa aggettivi.
Milano, Berlino, Arzignano (VI)
giugno – settembre 2012
Il testo per me si è concluso poco sopra. Eppure mi rendo conto che, se non ti avessi conosciuto, sarei stato davvero curioso di sapere come definiresti il tuo lavoro rispetto a quello di De Dominicis e Roccasalva.
“Ammetto che c’è stata una similitudine formale in alcune figure e me ne assumo la responsabilità. È normale, credo, quando si stima qualcuno; e so bene che è solo un passaggio che ho avuto bisogno di attraversare. La mia poetica è in piena gestazione e io stesso non so bene dove mi stia portando. Io faccio quello che posso per seguire le mie intuizioni e imparare da ciò che mi piace. Oggi c’è troppa fretta di etichettare i giovani artisti, come se fossimo tutti geni o qualcosa del genere. È un atteggiamento sbagliato — che tra l’altro mette ansia. Io penso che quelli dell’arte siano tempi più lenti e siano necessari almeno una decina di anni per capire come si stia muovendo un’artista. All’inizio mi ricordo che molti dicevano che Roccasalva copiava De Dominicis. È chiaro che questo è un punto di vista riduttivo, che livella ogni differenza. Ognuno è libero di considerare e vedere solo quello che già conosce e non considerare tutto il resto, se questo lo può far sentire più a suo agio.
Lui mi piace perché è un’artista singolare e anomalo, che nonostante questo si è imposto nel dibattito culturale. Chi non si ferma alle superfici delle nostre poetiche si accorge che non c’entrano. È risaputo che il processo culturale è collettivo, fatto di contaminazioni e scambi tra individui che non sono isolati. L’influenza è il modo in cui la cultura sedimenta”.