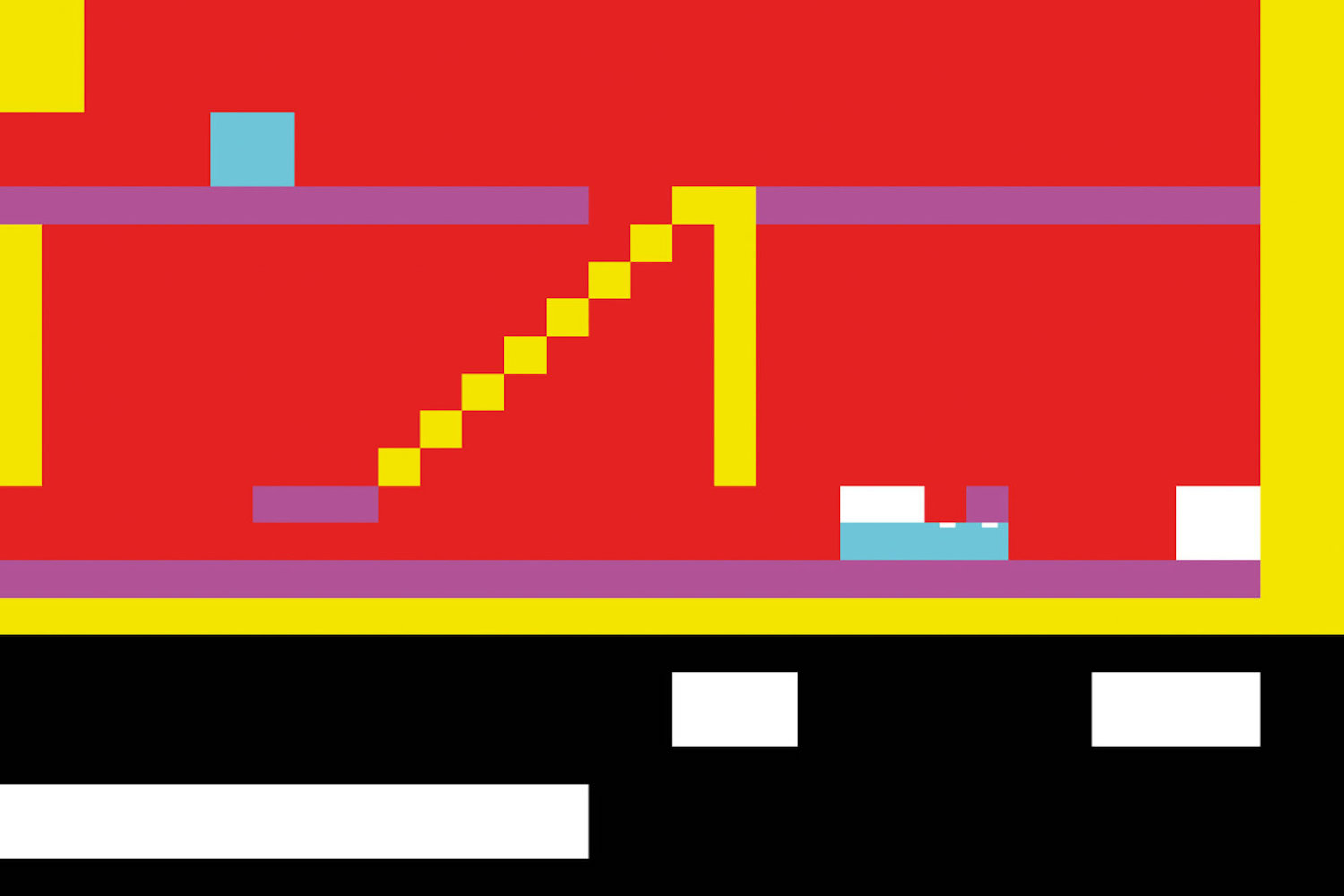Nel 2000 era in programma al P. S. 1 Contemporary Art Center di New York una mostra che doveva inizialmente includere i “Disastri della Guerra” (“Los Desastres de la Guerra”) di Francisco Goya assieme a una selezione di scene di guerra e altre atrocità di Henry Darger. L’intenzione era quella di presentare al centro dell’allestimento dei lavori su carta, la scultura di grandi dimensioni Hell di Jake e Dinos Chapman. Per problemi di sicurezza relativi all’opera, in quanto scena tridimensionale che mostra un paesaggio con migliaia di piccole figure fatte a mano, si decise che il lavoro era troppo fragile per essere trasportato e che la sua esposizione per un lungo periodo a un pubblico piuttosto giovane e a volte irruente ne avrebbe pregiudicato l’incolumità.
Così, d’accordo con gli artisti, abbiamo pensato di esporre una serie di fotografie di grande formato ispirate ai soggetti di Hell, che visualizzavano i momenti più bassi della nostra civiltà: guerra, genocidio, distruzione, tortura e molte scene singole di atti violenti.
Le straordinariamente brutali e crudeli scene di Goya sono considerate come una delle prime rappresentazioni “realistiche” delle atrocità della guerra nella Storia. Gli acquerelli di Darger combinano diversi strati di speranza innocente, perversità inaspettata, ripetizione compulsiva, crudele gioco di ruoli, fede naive e ira incontrollabile per formare una visione complessa della violenza, appresa attraverso le sue regolari letture di vecchi giornali e dal suo lavoro di usciere in un ospedale.
Nel 2004 Hell è andata distrutta quando il deposito Momart nell’East London è crollato per un incendio.
Nella mostra “Into Me / Out of Me”, l’opera dei Chapman è Sex II, una scultura in bronzo di grandi dimensioni che mostra la famosa rappresentazione di corpi e brandelli umani sospesi a un albero in stato di avanzato decadimento, con la carne consumata dalle larve. Questa colossale opera richiama alla mente i piccoli sarcofagi in ebano abilmente realizzati nel periodo tardo Barocco, che mostravano l’apice della peste bubbonica attraverso un immaginario di corpi in decomposizione consumati fino allo scheletro dai vermi.
Le grandi produzioni hollywoodiane come Alexander e Troy cercano di trovare non solo un modo più realistico di rappresentare le battaglie, ma anche la devastazione, il sangue, e la miseria conseguenti, sia da lontano che nel dettaglio. La serie del 2005, Elizabeth I, su HBO, mostra una scena in cui diversi traditori vengono torturati pubblicamente e muoiono a causa delle lacerazioni allo stomaco provocate dal lento attorcigliamento delle viscere su un fuso. Se la sola immagine di questa scena in televisione mi costrinse a lasciare la stanza, è ancora più difficile immaginare come una persona potrebbe reagire se questa avesse luogo pubblicamente davanti ai suoi occhi.
Infatti, atti di pubbliche torture o esecuzioni devono aver pesantemente impressionato un pubblico non ancora insensibilizzato dalla proliferazione di immagini oltraggiose di sofferenza, brutali incidenti e guerra, propinateci ogni giorno dalla televisione. Ma nonostante questo, c’è una grande differenza tra il confrontarsi con una scena come questa nella realtà o “solamente” attraverso il filtro dei media. In Elizabeth I, il pubblico sullo sfondo sembra in effetti abbastanza distaccato, alquanto interessato ma per niente scioccato o empatico. Infatti, gli atti di tortura e di violenza fisica resi pubblici richiedevano una precisa serie di competenze e una certa predisposizione. Lo squartamento, ad esempio, aveva lo scopo di tenere in vita la vittima il più a lungo possibile mentre alcune parti del corpo e i suoi organi interni venivano estratti lentamente, prima che le amputazioni finali avessero portato alla morte effettiva del torturato.
Per quanto queste scene oggi possano apparire impossibili da immaginare a un pubblico istruito, centinaia di anni fa il confronto con una miseria e una sofferenza di questo tipo doveva essere stata un’esperienza quotidiana per la maggior parte dell’umanità.
Solo una semplice infezione dentaria senza antidolorifici o antibiotici doveva essere stata insopportabilmente dolorosa. In effetti, chi aveva un’appendicite, una meningite o altre infezioni incurabili soffriva davvero, per così dire, le pene dell’inferno, mentre il corpo lentamente e inesorabilmente rinunciava a lottare.
Una situazione più complessa come un’ostruzione intestinale avrebbe causato crampi e in seguito un processo di decadimento dall’interno verso l’esterno. Una volta che le viscere si fossero bloccate, il loro contenuto avrebbe potuto solamente salire o scendere e il corpo avrebbe potuto provare a liberarsene prima del sopraggiungere della morte dei tessuti interni dell’individuo ancora in vita. Vedere il tuo compagno, figlio o vicino soffrire per una tale morte fornisce una potente metafora di come dev’essere, o è, l’inferno.
Debellata la varicella, l’umanità sembrò per la prima volta nella storia della civiltà libera da qualsiasi epidemia estesa e devastante. Le ondate di influenza virale mietono ancora innumerevoli vittime in tutto il mondo, ma ciò è dovuto in larga misura alle complicanze dell’influenza stessa e a una già debole disposizione fisica, come ad esempio l’età avanzata o i problemi di cuore. L’influenza è oggi solo un catalizzatore della morte — non la sua causa diretta come lo era la peste, che ai tempi ebbe una diffusione inspiegabilmente veloce.
Quando agli inizi degli anni Ottanta si cominciò a parlare di AIDS, la nuova malattia venne molto presto etichettata la “peste dei gay”. Il sarcoma di Kaposi, una vistosa lesione nera sulla pelle del paziente, visualizzava uno stigma e una sfida crescenti che la nostra società non ha ancora affrontato in misura sufficiente.
Il dipinto di Frank Moore Debutantes (1992) è un collage multistrato che allude alla reazione della società di fronte alla crisi dell’AIDS, includendo l’isolamento e la stigmatizzazione delle vittime della malattia. La mosca spagnola, un antico strumento di tortura, è collocato su un gigante piedistallo a forma di pillola. Questo immaginario è giustapposto alle rappresentazioni di figure impalate di fronte a innocenti spettatori, bambini. Fobia e repressione quotidiana del debole e del morente aggiungono oltre al danno la beffa, oppongono libertà a senso di colpa, supportano con indifferenza e cautelano con noncuranza.
All’apice della crisi, molte persone non sapevano che l’HIV fosse causato da un’infezione virale che, a differenza di molte altre malattie infettive, si può trasmettere esclusivamente attraverso contatti intimi o corpo a corpo, durante i quali fluidi come sangue e sperma sono trasmessi direttamente dal sistema di un individuo a quello di un altro organismo. Ancora oggi, milioni di persone muoiono di AIDS, e la più semplice protezione non sembra neppure accessibile o possibile da praticare per le migliaia di persone che vengono infettate ogni anno.
La consapevolezza di essere stati contagiati dall’HIV era, fino alla fine degli anni Novanta, un conto alla rovescia verso una morte certa, con un’aspettativa di vita media di approssimativamente dieci anni, raggiunti i quali il paziente si aspettava di perdere la sua battaglia contro il virus e contro le infezioni da esso derivanti. Se l’AIDS aveva i tratti di una sentenza di morte, influenzando pesantemente le generazioni più giovani durante l’adolescenza, si svilupparono parallelamente ai sentimenti di colpa e paranoia quesiti in merito ai comportamenti eticamente responsabili.
La medicina odierna, per avanzata che sia, affronta ancora enormi sfide a dispetto del fatto che gli stadi sopracitati di sofferenza infernale causata dalla malattia non possono essere più così visibili nella vita di tutti i giorni, attraverso i media e sulle strade. Gli ospedali e le cliniche oncologiche, pur essendo strutture indispensabili, sono anche i mezzi con i quali nascondiamo tale miseria, contenendo e occultando dietro le pareti spiacevoli realtà.
Gli autoritratti fotografici a grandezza naturale di Hannah Wilke documentano gli stadi avanzati del cancro al seno che nel 1993 l’ha portata alla morte. Le tracce fisiche dei test e dei trattamenti sono evidenti, rivelando il brutale assalto e gli effetti collaterali della medicina contemporanea intesa a salvarla: perdita dei capelli causata dalla chemioterapia, ecchimosi provocate dalle iniezioni, bende macchiate, l’essere collegati a macchine e penetrati da tubi. L’artista si è persino fotografata seduta su una padella, come per ritrarre la sostanziale impotenza che si unisce al tentativo sistematico di prolungare e salvare la vita — e allo stesso modo al prolungato periodo di controllo del dolore attraverso i farmaci.
Il dolore fisico viene spesso messo in relazione con la paura psicologica, l’ansia e la sofferenza. Catturato nel circolo vizioso degli inquietanti reami di fobia e rabbia, prende completamente il sopravvento. Di nuovo le droghe sembrano essere un modo piuttosto “moderno” di affrontare questo tipo di inferno — un inferno che un individuo subisce ma che non è volontariamente o maliziosamente inflitto da qualcun’altro. Gli stati di profonda depressione e paura che precedono e accompagnano la sofferenza possono già eguagliare un dolore che può essere descritto come infernale. Prima dell’introduzione della psicoterapia e perfino del contributo psicofarmacologico, questi stati mentali dovevano essere stati intollerabili, configurandosi come la massima angonia interiore sopportabile.

Nel cortometraggio muto del 1971 I’m Too Sad to Tell You, Bas Jan Ader libera la sua tristezza lasciando scorrere le lacrime. Questa immagine e il titolo dell’opera suggeriscono un’inspiegabile malinconia che è insostenibile a parole. Infatti, quattro anni dopo l’artista scomparve nel tentativo di attraversare l’Oceano Atlantico su una barca a vela.
La tortura autoimposta, nelle forme di martirio e automutilazione, non è un’invenzione degli artisti che facevano performance negli anni Sessanta e Settanta, ma ha archetipi antichi e religiosi più profondi. San Simeone Stilita, ad esempio, riusciva a rimanere in posizione eretta su una colonna giorno e notte nella città di Antiochia finché i piedi e le caviglie non iniziavano a decomporsi e putrefarsi, stando semplicemente in piedi, sfidando il tempo. Un tale prolungato supplizio basato su motivazioni religiose ha anticipato le performance di artisti ossessionati dal rituale e dal tempo.
In contrasto con questi duri test di resistenza e di autocontrollo, le elaborate trovate da palcoscenico di un intrattenitore contemporaneo come David Blaine sembrano una fiacca allusione alle imprese del leggendario Houdini.
Nella sua performance del 1973, The Conditioning, la prima azione dei suoi “Self-Portrait(s)”, Gina Pane si reclinava su un letto di metallo sopra a delle candele accese, mentre nel video di Sigalit Landau, Barbed Hula (2000), si vede l’artista sullo sfondo della nativa spiaggia in Israele mentre fa l’hula-hoop con un cerchio di filo spinato.
Anche la serie di performance fotografiche del 1973 di Ana Mendieta, “Untitled (Rape Scene)” e “Untitled (Self Portrait with Blood)”, associano l’idea di sofferenza a un livello di violenza politico, domestico e sociale.
Diverso l’approccio di Bob Flanagan. Come Wilke, l’artista ha tradotto in immagini la sua malattia, testimoniando la sua morte per fibrosi cistica. In vita si è fatto conoscere per le sue performance masochistiche, sperimentando i limiti del suo corpo. Nelle tre parti dell’installazione a sette canali Video Scaffold (1992), creata assieme alla moglie Sheree Rose, Flanagan si incide il petto e si infila alcuni chiodi nei genitali. Bastano le sole espressioni del viso, mostrate su un altro monitor, ad aiutare gli osservatori a immedesimarsi con il dolore lì sperimentato. Col motto “Combatti la malattia con la malattia”, Flanagan adottava la violenza autoinflitta come stile di vita, in forma di performance e come affermazione potenziale nei confronti della pratica medica che stava subendo.
L’ampia gamma di dolore inflitto attraverso atti diretti o intenzionali volti a causare sofferenza a un altro individuo è un capitolo a parte. Nell’Impero Romano, i cittadini avevano il diritto all’integrità fisica del proprio corpo, perfino in caso di esecuzione capitale. La pratica della crocifissione mediante l’impalamento di mani, polsi o piedi veniva applicata solo nei casi di individui ai quali non erano stati concessi i diritti civili. Nel corso della Storia poche civiltà hanno abolito con successo la tortura, la pena di morte e le altre procedure punitive volte a dissacrare il corpo umano. Nonostante sia una condizione necessaria per essere accettati nell’Unione Europea, l’abolizione della pena di morte è ancora una pratica legale in molti dei più grandi stati del mondo.
Tutti gli atti fin qui descritti rientrano nella legalità e nella vita civile, ma in caso di guerra, o anche nelle situazioni di terrore e genocidio che ancora oggi viviamo, non sembrano esserci possibilità di azioni troppo crudeli o troppo barbariche. Si è detto che il genocidio in Ruanda sia costato circa un milione di vite. Qui l’uccisione non è avvenuta con anonime armi di distruzione di massa ma è stata nella maggior parte dei casi commessa in modo diretto, essere umano contro essere umano, faccia a faccia.
Molti degli assassini hanno descritto le loro azioni come se fossero scaturite da uno stato di rabbia in cui se la vittima non rimaneva uccisa dal primo taglio o colpo o sparo, qualcun’altro doveva completare il compito, e poi passare alla prossima, in un’orgia quasi estatica di atrocità. In una relazione simbiotica, questo tipo di violenza non è stata un’esperienza “estrema” solo per la vittima, ma anche per il “carnefice”. L’uno esiste in virtù dell’altra e viceversa.
Queste erano esperienze multisensoriali che le immagini delle riviste non potevano comunicare. Un decennio dopo, diversi film hanno tentato di raccontare in parte quanto era successo in tutta la sua tragicità, ma nessuna immagine nel vocabolario del mondo mediatico si è rivelata adatta a catturare l’attenzione e suscitare quella logica reazione che la crescente aggressività tra i Tutsi e gli Hutu avrebbe meritato di avere. Se queste tensioni fossero state più ampiamente e accuratamente portate all’attenzione pubblica, forse si sarebbe prodotto un disastro minore o di diverso tipo. Forse questa storica mancanza di articolazione è esattamente ciò che rende la fotolitografia di Alfredo Jaar Rwanda, Rwanda (1994) così forte. Stampata semplicemente otto volte in un carattere nero grassetto, la parola diventa superficie di proiezione dell’intero disastro, e la sua ripetizione la cantilena di un riconoscimento tardivo.
Nei loro reportage sul genocidio in Ruanda, i giornalisti ricordavano al mondo le atrocità nella ex Jugoslavia. All’apice dell’orrore, l’olocausto richiama alla mente un grado di malvagità che per lungo tempo si è pensato il progresso della civiltà avesse reso inconcepibile.
La società attuale, non meno che altre epoche, ha incoraggiato una netta distinzione tra i protagonisti attivi e quelli passivi della Storia, tra gli individui che si esibiscono sul palco e quelli seduti tra il pubblico che guardano e si godono lo spettacolo. Pensando alle esibizioni dei gladiatori nel Colosseo, dove panem et circenses era una forma di intrattenimento per appagare la popolazione romana, gli spettatori guardavano in tempo reale la gente morire, combattere, dimostrarsi eroica, conseguire la vittoria e arrendersi alla sconfitta, pura e inadulterata proprio davanti ai loro occhi. Oggi Internet e la televisione forniscono un accesso simultaneo all’immaginario di disastri, tortura, morte e violazione, perdita e vittoria.

Spettatori pigri e in sovrappeso guardano i protagonisti dei cast di Survivor o di The Real World su MTV per vederli combattere, vincere e perdere. La percentuale di grasso corporeo dei membri del pubblico in relazione agli attori potrebbe essere molto simile a come andavano le cose 2.000 anni fa. La fruizione è determinata, innescata e alimentata dal diventare spettatori del momento fatale. Per salire sul palco bisogna lavorare molto, subire dolore o imbarazzo, insulti o perfino danni fisici.
Gli individui oggi vengono inondati a livelli insostenibili da immagini di guerra e terrore. Agenzie di stampa accreditate così come turisti e testimoni casuali dotati di dispositivi di videoregistrazione all’interno di telefoni e computer portatili catturano senza alcuna esitazione il momento in cui “l’inferno” ha luogo. Osservatori casuali così equipaggiati hanno maggiori possibilità di cogliere l’attimo in cui la crudele realtà mutila permanentemente il corpo di una vittima, la sua integrità fisica o la sua dignità.
Le fotografie delle teste dei figli di Saddam Hussein diffuse dai media sono state trattate come trofei in un modo che le fa in tutti i sensi competere con le immagini di antichi vincitori che issavano su dei pali le teste dei nemici sconfitti durante i raduni pubblici. Quando Saddam è stato catturato, un dottore gli ha infilato un abbassalingua in bocca più profondamente che ha potuto. Questa penetrazione di fronte alla telecamera è diventata un atto di rivendicazione del territorio e un’affermazione di potere.
Il modello storico per la fantasiosa figura del Conte Dracula fu un principe rumeno del XV secolo, Vlad III Dracula, o Vlad Tepes, tradotto in “Vlad l’impalatore”. Era conosciuto per il suo modo di punire i prigionieri obbligandoli a sedersi con gli orifizi anali o genitali su un palo appuntito sul quale, conseguentemente al peso corporeo e al cedimento della forza muscolare, la morte era lenta e protratta.
La tortura è ancora uno degli ambiti in cui l’inferno viene ricreato volontariamente e intenzionalmente sulla Terra.
Burning Skull (2006), di Paolo Canevari, mostra un teschio umano esposto alle fiamme. Dev’essere stata usata della benzina per intensificare il calore delle fiamme che si protraggono nel tempo e che sembrano uccidere i resti già senza vita di un individuo. All’interno dei rimandi relativi alla tematica di Goya, il teschio incarna l’icona delle infuocate profondità dell’inferno.
Un po’meno archetipica la grande installazione di Thomas Hirschhorn Superficial Engagement, esposta alla Gladstone Gallery di New York nel gennaio-febbraio 2006. Parte dell’installazione consisteva in figure di legno di dimensioni reali che i visitatori potevano perforare con un trapano. Traboccante di immagini che mostravano vittime di atti di violenza, guerra e terrore, parte del contenuto era di natura incredibilmente esplicita, rivelando fotografie di volti, teste e altre parti del corpo brutalmente distrutti, fatti a pezzi o spazzati via dall’assoluto potere della forza bruta.
La mostra di Hirshhorn consisteva anche in una selezione di opere dell’artista svizzera Emma Kunz, chiaroveggente e guaritrice spirituale. Il compito di identificare quegli stati dell’essere che sono tra i più forti che la vita umana può esperire pone una moltitudine di sfide alla pratica artistica contemporanea, soprattutto in un momento in cui Internet è pervaso da immagini che non possono effettivamente trovare un’area di consenso nel dibattito pubblico.