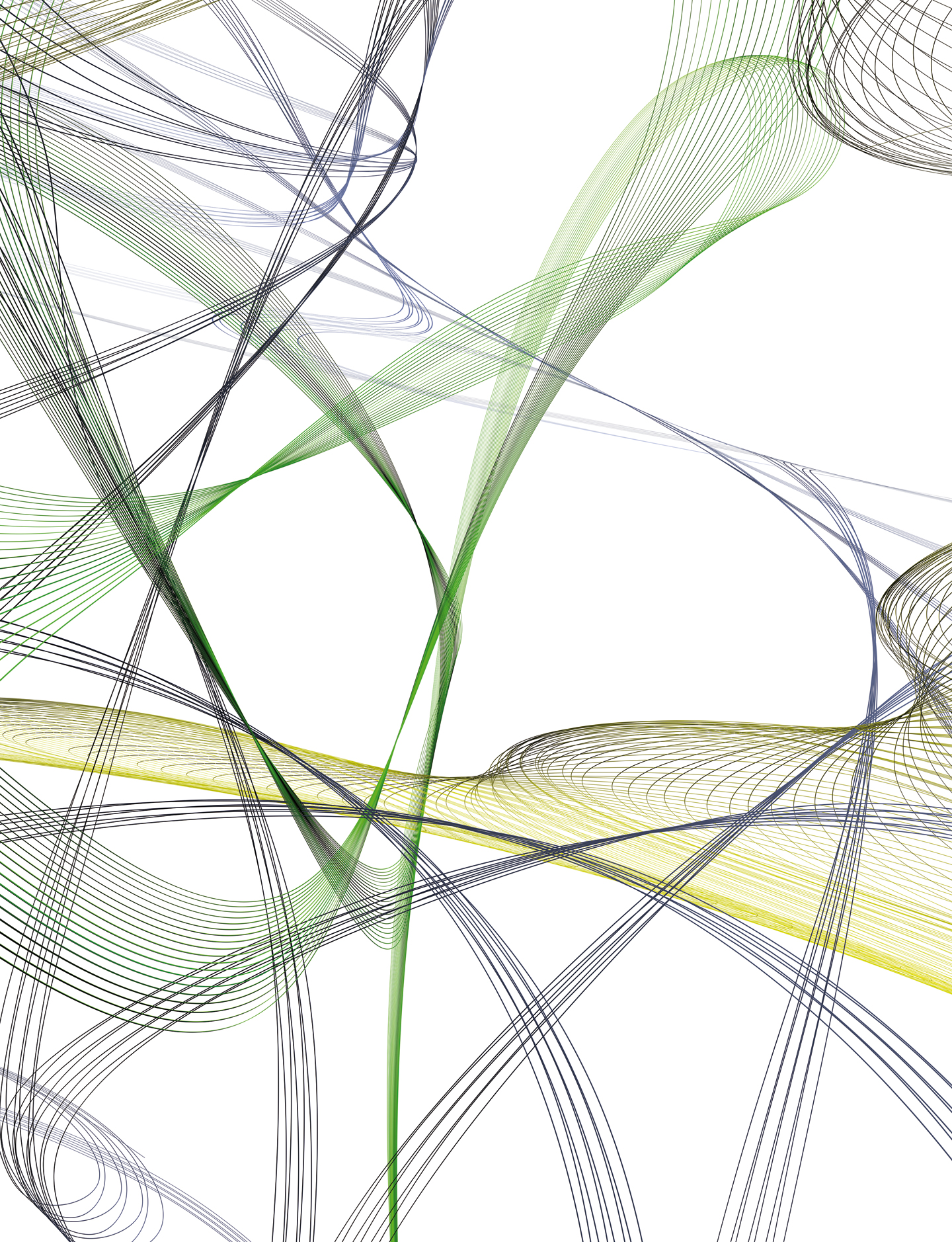Davide Giannella: All’interno del vostro percorso ci sono degli elementi che ritornano, sembra non esserci mai un salto netto. Indagini portate avanti di volta in volta e riprodotte in maniera sempre più complessa.
Invernomuto: È una volontà precisa quella di non chiudere definitivamente un argomento o un progetto, quella di non bloccare risolutivamente una direzione di ricerca ma, come dire, tenerla lì, depositarla, e al limite riaprirla dopo tre anni quando oramai ce la siamo dimenticata, ma è possibile trasformarla nuovamente. Questo più che per i soggetti funziona molto bene per le modalità, per l’approccio: il modo di osservare il paesaggio o di inquadrare una figura davanti alla camera se parliamo di immagini in movimento, ha più o meno mantenuto nel corso degli anni la stessa impostazione o dei richiami molto specifici a una posizione dello sguardo. Crediamo che sia anche una conseguenza del fatto di lavorare in due e, forse, di avere iniziato molto presto a lavorare insieme. Senza temporeggiare. La cosa che notiamo tutti i giorni è che il dialogo interno è continuo, non si è mai fermato e procede, rinnovato.
DG: Nel vostro lavoro appare anche forte la capacità di bilanciamento tra la cultura mainstream e una serie di linguaggi legati alle sottoculture o a tematiche che magari un pubblico più ampio non conosce necessariamente.
IM: Come diciamo sempre, l’approccio iniziale era quello di usare le sottoculture come lente attraverso cui osservare il mondo. Fondamentalmente stavamo approcciando la realtà utilizzando temi per noi molto chiari o che comunque stavamo studiando. Quello era il nostro modo di affrontare il reale, qualunque tematica essa fosse. Poi crediamo che ci sia stato un cambio dovuto ai tempi e alle nostre esigenze espressive e di ricerca.
DG: Mi sembra che questo cambiamento sia avvenuto anche rispetto all’utilizzo degli strumenti tecnologici. L’impressione è che ci fosse un rapporto mimetico tra gli strumenti utilizzati e la resa formale dei lavori. Cosa e come avete cambiato?
IM: È stato molto spontaneo, dovuto anche alla saturazione di un certo tipo di patina. Per restare nel contesto delle moving images, oggi facciamo molta fatica ad approcciare la pellicola, il video — e quindi quel gusto che necessariamente ne consegue. Ne abbiamo fatto largo uso, ma quella pasta ci ha stancati.
DG: Ma ha stufato solo voi personalmente o pensate che ci sia una saturazione generale?
IM: No no no, pensiamo che ci sia stata una percezione generale in quel senso. E contemporaneamente è arrivato l’HD, che è sceso su tutto e ha livellato la superficie di ogni immagine in movimento. Il nostro gioco è cercare di non essere completamente dentro a un trend: ad esempio l’uso dell’HD che stiamo cercando di fare in Negus è semplicemente teso ad avere un’immagine nitida e il più possibile cinematografica e contemporanea. La nostra tensione è sempre stata un po’ quella, di non essere revivalisti né passatisti, insomma di essere qui ora. Con l’ultimo video, The Celestial Path, ci siamo scontrati con problemi tecnici reali: l’abbiamo realizzato in CGI e siamo giunti a un risultato soddisfacente, pur sapendo però che non è il top di quello che è possibile raggiungere oggi. In termini plastici forse non ci ha soddisfatti al cento per cento, ma è stato molto interessante farci i conti, misurarci con quel linguaggio. Il punto è che noi abbiamo sempre approcciato alla patina tecnologica in base al soggetto che volevamo raccontare. Stessa cosa è successa per l’HD: in certi casi è più comodo, è più versatile, prendi la 5D, vai in Etiopia e fai un documentario con uno zaino. Però arriva sempre una fase progettuale in cui facciamo un ragionamento di tipo plastico, da scultori: come decliniamo questa cosa, con quali strumenti? Sicuramente c’è una tensione quasi erotica verso l’HD. Finita la fascinazione, però, mettendoci più testa, sentiamo l’esigenza di gestire gli strati delle immagini come se lavorassimo a una scultura: qua ci va il marmo, qui ci va il legno… La tattilità, il fatto di sgorgare fuori dalla bidimensionalità di uno schermo diventa un’esigenza.
DG: Parlando di tattilità e possibilità di uscire dalla presunta bidimensionalità e piattezza dello schermo, come vi rapportate alle possibilità di espansione dell’immagine e del lavoro video stesso?
IM: Per molto tempo abbiamo ragionato sulla questione e in generale ci sembrava che la risposta potesse essere nelle installazioni multischermo. A un certo punto però abbiamo sentito l’esigenza di eliminare questo approccio e iniziato a considerare ciò che stava attorno, in varie misure, allo schermo. In Negus – Echoes Chamber, presentato al Milano Film Festival, è stato aggiunto un elemento “scultoreo” come un soundsystem e di conseguenza una percezione più violenta e immersiva del suono. Per noi è sempre stato naturale aggiungere un pezzo per enfatizzare il suono (anche nel caso del primissimo Negus – Duppy Conquerors, presentato alla nona edizione del Premio Furla), abbandonando il senso di uscire dallo schermo come sinonimo di immagine.
È in questo modo che abbiamo creato una presenza organica alle immagini, ma comunque extraschermo. È come se avessimo in mano tante fonti e potessimo declinarle e agganciarle in modi differenti.
DG: Mi sembra che l’idea di fondo sia quella di rendere uno spazio organico tra opera, luoghi e persone. Siete d’accordo?
IM: La necessità di uscire dallo schermo dovrebbe andare a coinvolgere un’altra sfera rispetto a quella degli occhi, per noi è importante che si fisicizzi l’opera e l’esperienza fruitiva. Cerchiamo sempre di lavorare in modo volumetrico sul suono, in modo fisico e scultoreo, quella è una priorità. Il rapporto che il pubblico intraprende con l’immagine che sta vedendo non è esclusivo. Lo è lo spazio interposto tra pubblico e schermo, abitato di suono, di vibrazioni dell’aria che agiscono fisicamente.
DG: Ci sono in questo senso anche degli aspetti performativi che ricercate ogni tanto?
IM: È innato, ci troviamo spesso a mettere in scena quelle vie di mezzo tra un live media e una sonorizzazione, o spesso prevediamo un intervento dal vivo, ma non ci interessa essere in scena o particolarmente visibili. Teniamo al fatto che la regia continui sempre, anche durante la presentazione del lavoro, ma appunto cerchiamo di evitare spettacolarizzazioni frontali. Inoltre per noi è un modo di non chiudere mai un’opera che, come già detto, è un pregio e difetto che ci portiamo appresso.

DG: Secondo voi quali sono o possono essere le possibilità non tanto di commercializzazione ma di valorizzazione e distribuzione di queste esperienze? Credo che ormai sia uno dei nodi centrali non solo del cinema e di tutti i prodotti a carattere cinematografico ma di tutti i prodotti sperimentali che non sono dei semplici oggetti finiti.
IM: La distribuzione va di pari passo ai contesti. Nell’arte può esserci una certa distribuzione, il cinema può averne un altro tipo e poi ci sono le terre di mezzo tra questi due mondi e tanti altri mondi X che hanno caratteristiche distributive ancora una volta differenti.
Il dato di fatto è che abbiamo sempre lavorato in contesti che ci hanno spinto verso linguaggi transdisciplinari e ci siamo specializzati meno nelle espressioni più oggettuali del lavoro. Siamo spesso stati invitati da festival o situazioni che stanno in zone liminali tra più discipline, ma anche attraverso commissioni di stampo museale. Ciò non significa un rifiuto di qualsiasi tipo di commercializzazione o spendibilità del lavoro nel mercato, anzi ci interessa molto coltivare maggiormente questo aspetto, aprendo un dialogo serrato e costruttivo con una galleria.
DG: In questa moltitudine di strumenti e linguaggi che riuscite ad articolare, mi dicevate che la “testa del polpo”, se così vogliamo chiamarla, è l’immagine in movimento. Quali sono invece i “tentacoli”, le altre forme espressive, gli altri linguaggi?
IM: Abbiamo parlato anche di musica, più precisamente di suono, elemento che a tutti gli effetti collocheremmo tra le nostre forme espressive centrali, proprio nella testa del polpo se vogliamo continuare con la tua metafora. Un altro tentacolo è senz’altro l’approccio da “impaginatori”, che è il figlio più diretto del nostro interesse per il publishing: la dimestichezza con i layout, cartacei e non. Di conseguenza la progettazione del display, che è forse una definizione che preferiamo utilizzare al posto di “installazione”. E certamente la scultura come nel caso di Wax, Relax. Molto spesso tendiamo a considerare l’utilizzo che facciamo della scultura come un prop, qualcosa che in fondo ha a che fare con il cinema.
DG: A proposito di cinema, voi ci andate spesso?
IM: Sì, molto. In realtà ultimamente cerchiamo di andarci sempre di più. Questo chiama in causa il vecchio discorso della ritualità del cinema, per il quale arrivi lì e decidi di dedicare due ore a un film. Inoltre è uno spazio condiviso, quindi è più coinvolgente. Devi spegnere il telefono, non devi fare rumore, ci sono molte regole che devono essere rispettate.
DG: È una cerimonia a tutti gli effetti. È un’esperienza unica, è interessante per l’ottica della simultaneità che nel cinema sparisce. Sei più passivo ma più dedito.
IM: La questione è che ultimamente il cinema e le immagini in movimento in sala hanno bisogno di recuperare il coinvolgimento del pubblico. Prendi per esempio il cinema 3D, quell’esperienza richiede necessariamente di essere fruita in sala, non sullo schermo di un laptop. Allo stesso tempo però ci obbliga ad indossare degli occhiali, un supporto fisico, un’operazione analogica, qualcosa che fugge e si stacca dalla tensione all’innovazione tecnologica.

DG: Gli ultimi dieci anni sono stati l’apoteosi del passaggio delle sottoculture da terreni di nicchia al mainstream. Adesso è molto difficile riscontrare qualcosa di realmente inedito. Come trattate o risolvete questo argomento?
IM: Siamo sempre partiti da un’analisi molto peculiare e locale, usandola come pretesto per parlare di qualcosa di più ampio, che può avere una risonanza diversa e universale. In Negus, ad esempio, la scintilla locale ci permette di costruire triangolazioni inedite, sdoganando i soggetti dagli stereotipi con i quali di solito vengono affrontati alcuni argomenti che il progetto raccoglie, come la tradizione del reggae e la sua percezione.
DG: Un altro tra i tentacoli che mi sembrano ben presenti nel corpo del polpo di Invernomuto è l’architettura. Che sguardo avete rispetto a questo tema?
IM: Forse più che l’architettura ci interessano i singoli elementi architettonici, perché storicizzano e attivano un discorso plastico. Siamo portati dunque ad analizzare un particolare muretto o una staccionata, possiamo destrutturare l’ambiente che abbiamo intorno per cercare di leggerlo e tutti i tasselli che riuniamo vanno a costituire il nostro sfondo.