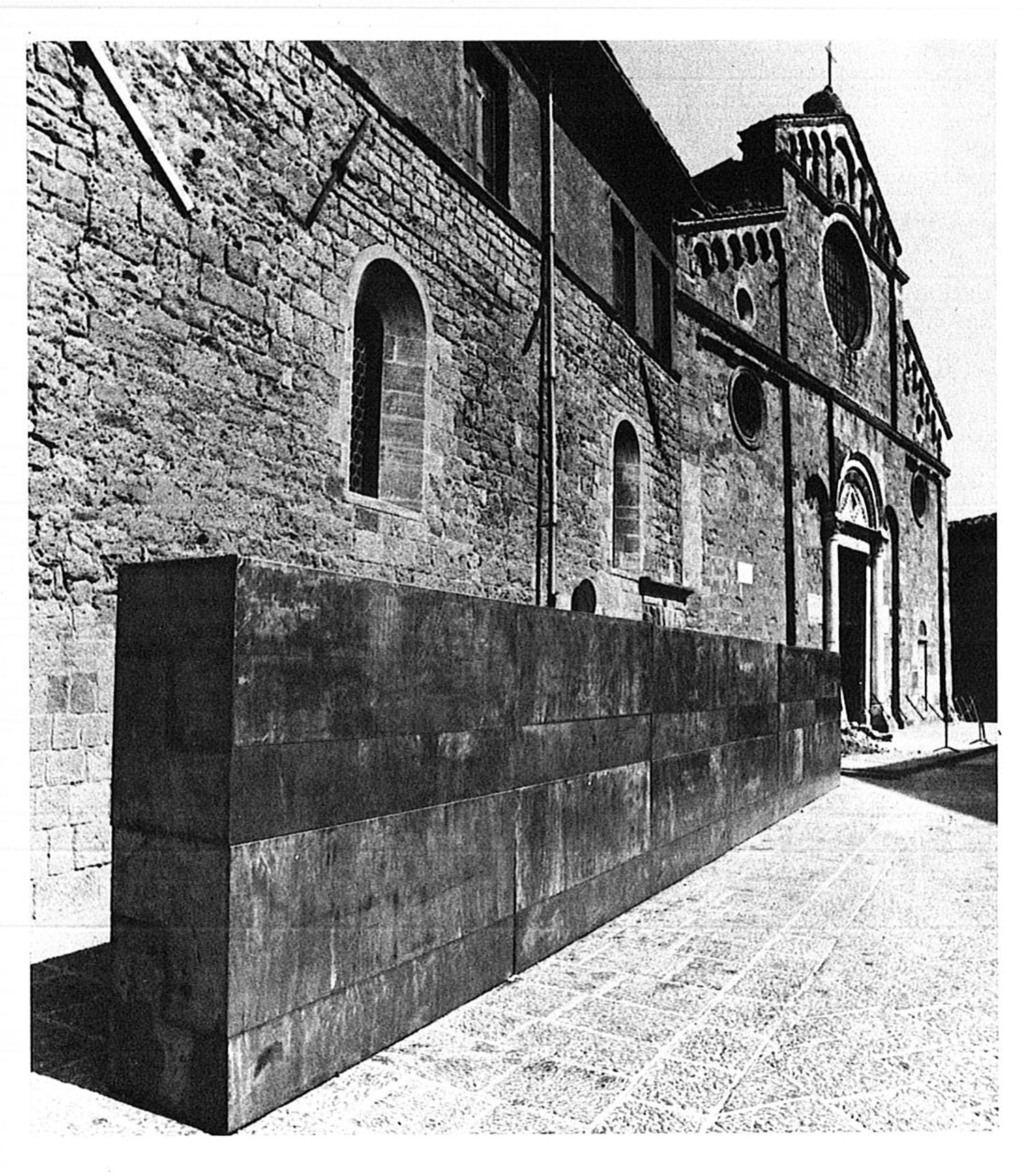Sottogenere musicale del rap, la trap nasce ad Atlanta e prende il nome dalle trap houses, ovvero edifici abbandonati ai margini della città americana, scenari di microcriminalità e spaccio di droga. Da espressione periferica, la trap si è velocemente tramutata in fenomeno globale (e globalizzato), investendo le scene musicali d’Europa, Africa, Sud America e persino Asia. Oggi la trap è il genere postmoderno per eccellenza: fluida e ibrida – mixa sonorità e si dirama in una moltitudine di sottocategorie –, delegittima qualsiasi tipo di “grand récit” (ovvero il “grande racconto” di cui Lyotard proclamava la morte) per svelare il mondo “per quello che è”[i] e ritrarre la frammentazione del contingente. In Italia, in particolar modo, è un genere sviluppato da giovani autori per raccontare la vita di quartiere e la potenziale emancipazione e riscatto da questo. La seguente tavola rotonda chiama in causa quattro operatori del settore musicale – Enrico Bisi, Guè Pequeno, Giovanni Robertini e Paola Zukar – per discutere le peculiarità della trap di matrice italiana: dalla sonorità, al bagaglio lessicale, ai legami con la scena rap e hip hop del Bel paese, per arrivare alla stretta relazione con il sistema della moda.

Giulia Gregnanin: Vorrei iniziare parlando dalla sonorità che contraddistingue la trap. Tecnicamente il beat è caratterizzato da un ampio uso di bassi (distorti, tipicamente dub), kick ripetitivi e pesanti, velocità di colpi sull’hi-hat e l’uso di sintetizzatori. Vocalmente il ritmo è più rilassato, in quanto abbandona il ritmo 4/4 del rap. Trovate che la trap italiana abbia determinate caratteristiche che a livello di suono la contraddistinguono? Oppure ancora sussiste un tentativo di emulazione della trap statunitense? Inoltre, come secondo voi è recepita all’estero la “nostra” trap?
Paola Zukar: Il lavoro fatto dai giovani produttori italiani sulla trap locale è fuori discussione per qualità e originalità: Charlie Charles, Sick Luke, Ava e altri hanno davvero fatto la differenza. Se non ci fossero stati loro, la trap italiana avrebbe faticato non poco ad emergere, o magari non sarebbe emersa per nulla. Per quanto originali, si rifanno in ogni caso a canoni estetici internazionali, americani, francesi, tedeschi… globali, ecco. E non credo sia possibile, in questi tempi di omologazione culturale, essere davvero locali. Penso, anzi, che agli artisti piaccia riconoscersi in un mercato globale ed essere riconosciuti per la qualità del lavoro più che per la sua particolarità.
Guè Pequeno: Trovo che la scena italiana sia pressoché identica a quella statunitense essendo giustamente ispiratissima, con la differenza che è più edulcorata. Come ha detto Paola, ci sono produttori come Charlie Charles e Sick Luke che sono allo stesso livello di Europa e Stati Uniti; e artisti come Sfera Ebbasta che sono apprezzati all’estero e collaborano con artisti giganti.
Enrico Bisi: La trap italiana nasce sicuramente come imitazione di quella d’oltreoceano, ma questo è capitato per qualsiasi genere musicale nell’ultimo secolo. Successivamente alcuni iniziano a elaborare uno stile più personale aggiungendo caratteristiche originali e sta effettivamente iniziando a definirsi una scena italiana autonoma, con i suoi stili e contenuti. Anche a livello di sound, la maggior parte dei produttori cerca di ricalcare il suono americano, mentre alcuni trovano la loro via e il loro suono più personale, contaminando la trap con elementi melodici, etnici, decisamente insoliti e tipicamente italiani.
Giovanni Robertini: Fare la trap in Italia è come studiare una lingua straniera con un corso su cassetta. Ogni riferimento, almeno per la prima generazione di produttori, è fuori dai nostri confini, arriva dagli Stati Uniti, dalla Francia e dall’Inghilterra. La produzione delle basi è frutto dell’elaborazione, della masticazione, dell’ascolto di basi altrui; è artigianato solitario di giovanissimi producer che, nelle loro camerette trasformate in studi di registrazione, smanettano sul computer in cerca del beat perfetto, tanto che la competizione – quasi fosse un audiogame mondiale – è altissima per chi riesce a produrre il beat che “spacca” di più. Poi c’è l’italian touch, che è il risultato degli ascolti fatti a casa con i genitori, ovvero la melodia della canzone italiana che diventa una piccola ma importante madeleine nella grande abbuffata della trap. E i francesi infatti, più simili a noi per tradizioni e cucina musicale, impazziscono per la trap di Sfera: a Parigi mi è successo di sentirlo dai boombox dei ragazzini per strada.

Secondo un’analisi statistica[ii] svolta ad hoc per questa conversazione le parole più utilizzate nella musica trap italiana sono (in quest’ordine): “soldi”, “gang”, “vuoi”, “fumo”, “casa”, “strada” e “vita”. Questo ci riporta ai temi trattati nei testi, perlopiù a un primo sguardo relativi a volontà di emancipazione da una condizione di marginalità a cui spesso fa da sfondo la periferia urbana. Un altro spunto che vi vorrei proporre è il linguaggio vernacolare utilizzato dai trappers: uno slang di strada, che si crea e si adopera nel quartiere, ricco di espressioni gergali, dialetti, ma anche neologismi. Ricordo che recentemente il termine “bufu” (sigla dell’espressione gergale americana “by us fuck u”, insulto in risposta a dissing verbali) coniato dalla Dark Polo Gang è entrato nel vocabolario Treccani. In che modo dunque, secondo voi, i temi affrontati nei testi e il linguaggio utilizzato si complementano?
EB: Penso che questo aspetto non sia affatto nuovo e certamente lo si può ritrovare nel rap già negli anni Novanta. C’era e c’è un divertimento sincero nel raccontare e nell’inventarsi universi personali che appartengono a un gruppo, a una crew, e che poi diventano di dominio pubblico. Sicuramente temi e linguaggio vanno a braccetto anche se mi sembra che nei contenuti ci sia stato un progressivo impoverimento. L’emancipazione è esaltata da un punto di vista prettamente materiale. Gonfiare le proprie tasche e farlo in fretta – purtroppo, spesso passa questo ascoltando i testi… Sullo stile del linguaggio mi piace molto quello che fa Quentin40 [troncare le parole, ndr]. Mi sembra un passo avanti, qualcosa di davvero nuovo e ardito.
GR: È sbagliato considerare la trap un genere “di strada” o di per periferia. Non ha una connotazione di classe, non c’è ghetto dove confinarla, perché è un fenomeno liquido. La trap è un “codice sorgente” generazionale che solo per necessità, non potendo ancora servirsi di una lingua nuova e inventata, usa la parola comune scegliendo alcune tematiche – soldi, droga, street attitude – come colori di un quadro che rappresenta il disagio e il bisogno di affermare un’identità/appartenenza. Non c’è morale né politica nella trap; bensì uno stato emotivo condiviso da milioni di ragazzi in tutto il mondo.
PZ: Riprendo la risposta data prima circa la musica: generalmente anche il linguaggio utilizzato nella trap è globalizzato – è mutuato dai social, dai colleghi – ed è davvero difficile personalizzare un genere che trova la propria forza proprio in quell’omologazione. Bisogna però dire che a rimanere saranno quelli che riusciranno a trovare in quello stile universale e comune una loro propria collocazione, unica e irripetibile. Ghali ha un modo personalissimo di scrivere, ad esempio, come pure Sfera; e nonostante le tante imitazioni, ci saranno sempre le matrici di questo genere, così come lo sono Fibra, Marracash e Gué Pequeno.
GP: Sono le stesse identiche tematiche che hanno contraddistinto l’hip hop di sempre. Le differenze sono nei testi più semplici, in più melodia e meno metrica, in meno metafore, meno giochi di parole, meno liricismo in generale. Ciò non toglie che sia meno bella la musica. Anche in Italia, comunque, abbiamo grande scelta e tra le nuove generazioni ci sono mille artisti diversi, più superficiali o più profondi, più o meno pop, eccetera eccetera.
Mi sembra che il fenomeno della trap anziché nascere nei club e nei circoli, sia sorto nelle strade e nei parchetti di periferie urbane (tra queste Milano, Genova, Roma, Napoli), per poi fiorire su internet – prima YouTube, poi Spotify ma anche Instagram. Che ruolo ha secondo voi oggi la viralità nel far crescere o abbattere la carriera di un artista? I social network hanno forse eliminato alcune barriere all’entrata che consentivano una scrematura qualitativa?
GR: La trap non sarebbe la trap se non fosse una rete iperconnessa con tutti i suoi utenti. Spotify, SoundCloud, YouTube e i social network sono le factory artistiche che sviluppano un prodotto, quello musicale e dell’immaginario, cambiandone e contaminandone continuamente canoni e regole. La viralità è fondamentale. La musica trap è il prodotto di una globalizzazione dove tutto circola senza confini: il trapper filippino e quello finlandese comunicano la stessa identica cosa, semplicemente con poetiche diverse (sarebbe più corretto dire con swag e flow diversi) e si incontreranno in un featuring o scambiandosi delle basi, creando comunità orizzontali (anche se economicamente sempre deboli ed etero dirette).
GP: Sicuramente il fenomeno è sorto anche in discoteca, perlomeno a livello di desiderio; il lifestyle lussuoso e il materialismo tipici dell’hip hop in questo momento storico sono ai massimi livelli. Il social e l’immagine hanno un ruolo fondamentale – citando me stesso, “il rap adesso si guarda, non è più da ascoltare”.
EB: L’abbattimento degli schemi produttivi e distributivi del passato è stata una vera rivoluzione per la musica. Sia per chi la musica la fa, sia per chi l’ascolta. Forse è ancor presto per capire esattamente a che punto della parabola siamo, ma certamente la viralità è diventa una componente essenziale per arrivare a farsi conoscere. Farei attenzione a dare un giudizio morale su questo: i mezzi di comunicazione sono esplosi e ognuno può usarli a proprio piacimento. L’importante è cercare di conoscerli il più possibile, cercare di essere tu a guidare loro e non viceversa. Per un artista, i social devono rimanere megafono per veicolare la propria musica.
PZ: Sono d’accordo. Però mi piace molto l’attitudine al rap che hanno molti di questi nuovi artisti. Ascoltando i più grandi e i colleghi all’estero, hanno capito i principi sui quali lavorare. Non era scontato, dopo l’ondata pop/rap del 2012/2013…

Questa domanda la pongo a te, Enrico, tenendo in considerazione il tuo documentario Numero Zero. Alle origini del rap italiano, realizzato nel 2015 e visibile su Netflix. Trovi che la trap veda nel primo rap italiano un punto di riferimento? Ritornano citazioni e rimandi a questo periodo?
EB: È un tema che ricorre spesso quello di mettere in relazione il rap con la trap. Io credo che i punti di contatto siano davvero pochi, in particolar modo se pensiamo all’hip hop, fenomeno artistico e culturale all’interno del quale il rap è nato. Alcuni trapper hanno dichiarato senza problemi di non conoscere, ad esempio, i Sangue Misto. È chiaro che il loro orizzonte di riferimento e il loro background non si sposi con quello che c’è stato in Italia negli anni Novanta. Ma questo discorso non vale per tutti, ovviamente. Per alcuni artisti è diverso, a volte ci sono richiami, omaggi e anche collaborazioni. Però, penso che per rispetto di entrambe le realtà, rap e hip hop vadano scissi il più possibile.
Guè, hai supportato la giovane scena trap sia attraverso produzioni che collaborazioni. Recentemente, inoltre, hai pubblicato il libro autobiografico Guèrriero (Rizzoli, Milano 2018), e qui nell’introduzione sei molto duro verso alcuni esponenti di quella scena, per quanto riguarda lo stile adottato. Dici: “quando vedo questi rapper che si improvvisano fashion icon mi fanno ridere perché si vede benissimo che non sanno niente: magari un anno fa erano in cassa all’Auchan e oggi fanno i fighi sui social”. Poi racconti come agli inizi dei 2000 fossi tra i primi a vestire Gucci, Vuitton, Armani, sdoganando l’uso dell’alta moda in un ambiente che non l’aveva mai digerita. Come credi si sia evoluto il rapporto con la moda e perché oggi i giovani hanno iniziato a indossare le grandi firme? Mi sembra inoltre che si vada verso un’ibridizzazione sessuale nel modo di vestire: si vedano Achille Lauro oppure Sfera, che a volte indossano capi femminili.
GP: Hanno iniziato a indossare le grandi firme perché i cantanti urban di tutto il mondo le indossano da sempre, solamente che la cosa da noi è stata sdoganata recentemente, così come gli argomenti dei testi prima tabù. Non sono critico verso tutta la scena; la citazione del libro è solo un’osservazione sarcastica. Ci sono artisti bravissimi che portano borse da donna. Non è il mio stile ma il mondo è libero.
Giovanni, la domanda consequenziale sorge spontanea e riguarda i video musicali. Credi ci sia una sorta d’immaginario che si vuole restituire attraverso la sceneggiatura dei clip? Ci sono elementi che ricorrono e che vanno a costituire una sorta di metatesto?
GR: Il video nella trap è importante tanto quanto la musica. I vestiti di marca, la danza gestuale, la droga, la gang – ovvero i veri protagonisti dei video trap – non hanno bisogno di una sceneggiatura, o di uno storytelling, ma di essere “riconosciuti” in mezzo agli altri. Devono “distinguersi” con le sneakers più nuove e costose, devono “primeggiare” per coolness o per quantità: chi ha più soldi, chi più droga, chi la gang più grande. I video sono, tanto quanto la musica, un elemento per costruire l’identità e il valore merceologico di un artista trap, perennemente in competizione per primeggiare sugli altri.
Paola, credi che la trap sia un fenomeno passeggero, legato a un discorso generazionale o possa avere un futuro? Te lo domando in quanto la scena mi sembra molto giovane, e forse non più connessa a esigenze di stringere una sottocultura antagonista al mainstream. Tra l’altro, è ancora corretto parlare di sottocultura in ambito musicale?
PZ: La trap rimane una controcultura, non fosse altro per il linguaggio e per il suono che ancora si contrappone alla musica tradizionale italiana. Come dicevo prima, rimarrà se saprà andare nel profondo, se riuscirà a dare qualcosa oltre l’apparenza, oltre la superficialità, se si saprà legare a quell’importante caratteristica dell’avanguardia artistica che cattura il momento particolare e lo rende universale. Sicuramente questo suono adesso è di moda e come tale passerà, ma rimarrà qualcosa se appunto si evolverà come colonna sonora generazionale. In ogni caso, la trap è parte integrante del rap, il genere più adatto a raccontare questi anni così complessi e non tradotti ai ragazzi da nessun altro, se non dai rapper. Il rap ha quasi quarant’anni ed è qui per restare.