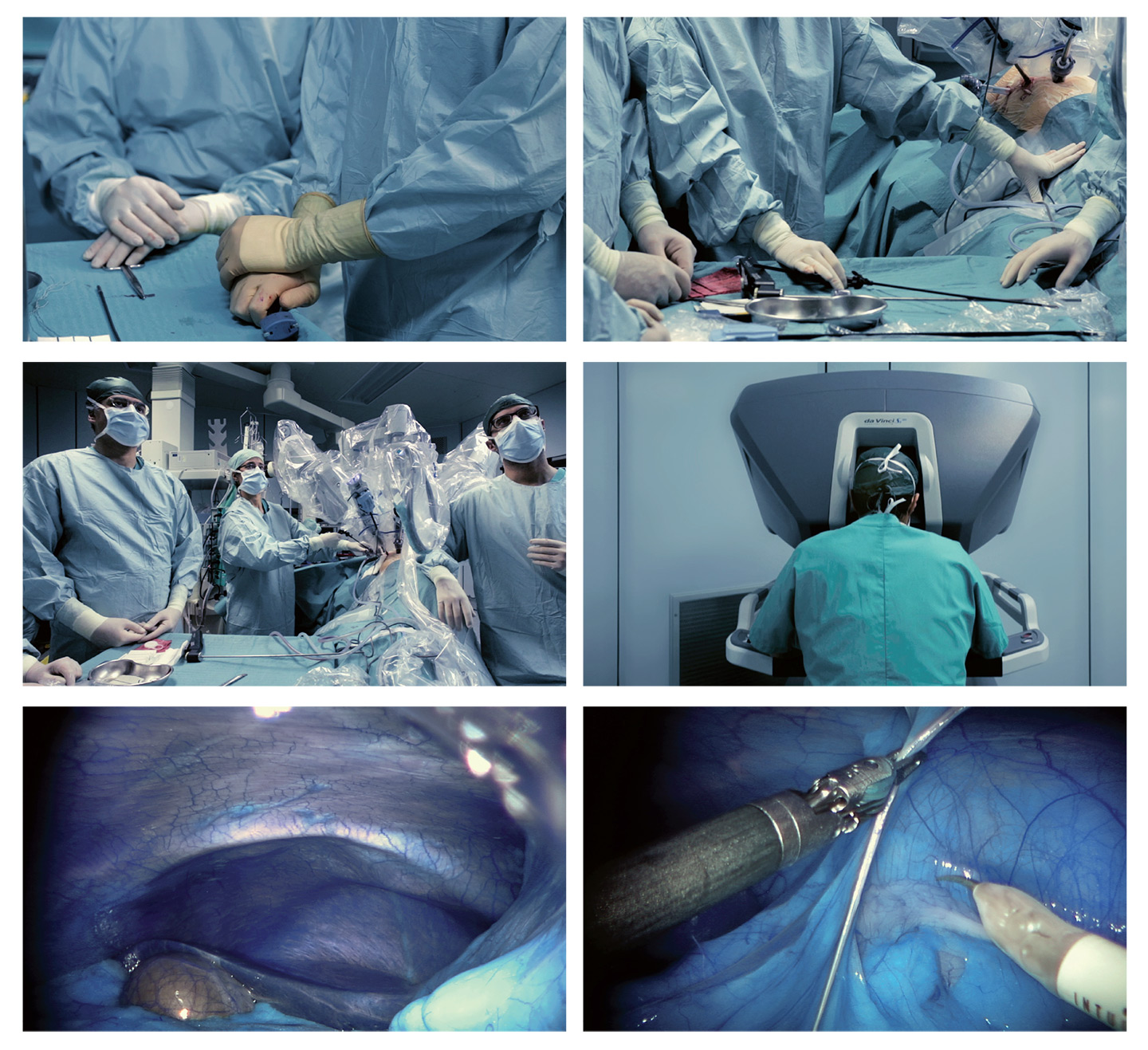“Ci vuole un bel po’ a fare un americano di successo, ma per rendere felice un veneziano ci vuole solo una manciata di rapida sensibilità”.
Henry James, Venezia
Penso che dovremmo parlare di James Lee Byars come un artista americano — non perché l’America se lo sia meritato (non è così) ma perché se limitiamo le origini di Byars al Midwest rendiamo dandy il suo tentativo, ostruiamo la sorgente di urgenza che lo guida, e chiudiamo i nostri occhi al buio che illumina le sue più dorate tracce di qualcosa di più generoso e curioso.
È importante, dunque, che nel contesto delle nostre considerazioni, manteniamo l’immagine monocroma della Paradise Valley, la innominata e prevalentemente oscura zona di Detroit, laddove, nel pieno della Grande Depressione, James Lee Bryars è cresciuto tra scontri razziali, violenze e squallore. Ed è importante, inoltre, mantenere una certa immagine della cupa facciata vittoriana alla Edgar Allan Poe davanti ai nostri occhi, e di Mister Dracula, fresco dall’Armenia, che ha insegnato nell’aula magna di primo grado di Bryars, non in circostanze di simpatia; Bryars avrebbe disprezzato questo — come punti sulla scala con la quale misuriamo l’enormità della sua creatività e contro la quale calcoliamo lo stravagante livello di imprudenza e coraggio teatrale richiesto. Avendo conosciuto le radici americane della radicale inventiva di Byars, comunque, non abbiamo bisogno di immaginare, come molti fanno, che Byars ha trasformato se stesso dall’essere un americano in qualche altra cosa. Infatti, ogni aspetto dell’arte di Byars ha radici profonde sia nel Midwest della sua giovinezza sia nella latente postmodernità della cultura americana dissidente degli anni Cinquanta. Per questo, il suo cosiddetto dandismo, cresciuto sulle strade di Detroit negli abiti appariscenti del fiore degli anni, parla più incisivamente della cosiddetta sfacciataggine da outsider di ogni conoscenza urbana baudelairiana. Il suo orientalismo mondano, inoltre, che è spesso caratterizzato come un marchio logoro di decadenza imperiale, viene lasciato crescere abbastanza naturalmente da una speranza destinata a fallire e che era molto più viva nella cultura beat degli anni Cinquanta, quando l’America poteva in qualche modo volgersi a Occidente e guardare a Oriente, lontana dall’Europa. Anche il riflessivo orientalismo dell’iconografia di Byars, comunque, non smette mai di sorridere — e non smette mai di riconoscere le sue fonti, legate alla satira americana, al patinato pop-lusso panculturale del design pop degli anni Cinquanta.
In altre parole, nonostante le sue implicazioni elevate, l’ambientazione pacchiana dei ristoranti cinesi nel nevoso Michigan non è mai presente nell’evocazione di Byars, nonostante alcuni volessero che ci fosse.

Ancora, l’assunto che James Lee Byars ha in un certo senso abbandonato l’America resta qualcosa di confortante per molti interpreti. Consente loro di guardare la romantica carriera di Byars come la naturale conseguenza della sua defezione, che l’artista in qualche modo intendeva cominciare alla sesta decade, come un vagabondo nel vero senso della parola, vivendo in una misteriosa cattiva reputazione, con le valigie fuori e una stanza a Venezia. Se consideriamo Byars come un disponibile transfuga da rassicurare — come una sorta di Epicureo distopico venuto a riposare in una Venezia sommersa, oziando felicemente nei caffé di San Marco, assaporando la sua fuga — potremmo continuare a considerare l’America come un generoso rifugio per sforzi indifferenti, immateriali, multiculturali. Pretendendendo che Byars sia cambiato, allora possiamo pretendere che l’America non l’abbia fatto.
Niente, naturalmente, potrebbe essere più lontano dalla questione; e come anche l’indagine più distratta della sua carriera sarebbe chiarita, le ispirazioni di James Lee Byars, dal principio, non hanno niente a che fare con la prospettiva di diventare un “Americano a Venezia” — e ogni cosa da fare con la possibilità di un’“America veneziana” — con una cultura che sia un’elegante confluenza di Oriente e Occidente.

Così, le attività di Byars durante gli anni Sessanta erano quasi totalmente devote allo studio del Giappone e all’esplorazione dell’America e durante la pausa dai suoi studi nel 1963 egli ha voluto fare un giro in autobus da “99 giorni, 99 dollari” attraverso il cuore dell’America da Los Angeles a New York; ha inoltre organizzato un viaggio di 12 ore per 2 attraverso il profondo Sud. E, nel 1964, ha voluto girare le principali attrazioni turistiche dell’America, ancora in autobus — enfatizzando il suo viaggio con delle cartoline degli eventi. Tutte queste attività, naturalmente non erano solo tipicamente byarsiane, ma assolutamente originali di quel generoso, evangelico momento nella cultura americana; e in quel momento, io suggerirei, prima che l’America cambiasse intorno a lui, possiamo vedere James Lee Byars come era e come è, guardando fuori al finestrino dell’autobus e al cuore, mappando la sua campagna di redenzione. Come una Dortothy Gale cosmopolita, ha voluto riportare Oz al Kansas, il Paradiso alla Paradise Valley, in una serie di chatauqua (scuola estiva, NdR) psichedelici. Egli ha voluto rischiare tutto, infatti, per far ritornare “il divertimento al fondamentalismo”, come Paul Morrisey che una volta ha cercato di mostrare i film di Warhol in Texas. Questo era il tono di quei tempi, e si aveva bisogno solo di uno sguardo agli epigrammi generosissimi di 100 minuti o al grande campionario di James Lee Byars, estrapolando alcune voci come “Parla più veloce”, “La bellezza va all’avanguardia”, “Il papavero è il mio fiore preferito”, per capire che una sensibilità come quella di Byars non avrebbe mai potuto prevedere l’istituzionalizzazione protestante del mondo dell’arte americano — non il giorno in cui gli artisti avrebbero aspirato alle virtù dei professori e dei vizi degli uomini d’affari. Era un punto morto nella visione di Byars, ma io posso testimoniare il suo essere un americano tipico. Ciononostante, il manto di “artista americano” riposa scomodamente sulle spalle di Byars come su quelle di Poe o Pound o Henry James. Drappeggia questi rigorosi esotici in una cordiale aura di rispettabilità che, implicitamente, attribuisce alla malattia la sua cura. Tuttavia, nessuno a parte i figli indigeni come Byars e Poe, come Pound e James, potevano così splendidamente purificare la banalità dei protestanti americani dalle loro vite e dai loro lavori; quindi è importante che riconosciamo le radici di Byars, in qualunque modo estirpate, e lo consideriamo oggi, forse, come un americano “sotto cancellatura” — o, ancora meglio, un americano in gloria, o meglio di tutte, semplicemente un eroe americano — uno di questi vivaci spiriti gnostici, come Bugsy Siegel (famoso gangster americano tra i fondatori di Las Vegas) o Brigham Young (Presidente della Chiesa Mormonica, tra i promotori della colonizzazione dei territori dell’Ovest degli Stati Uniti), come Liberace (Wladziu Valentino Liberace, musicista di origine polacche molto famoso negli Stati Uniti tra gli anni Cinquanta e i Sessanta) o Richard Buckminster Fuller (inventore, scienziato e filosofo, architetto americano), che sbocciò dal Grande Nulla e non reclamò mai il suo diritto imperiale di ricostituire l’universo nella lingua dei suoi stessi desideri. In ogni caso, innocenza, entusiasmo, grandezza ed esteriorità sono qui i concetti chiave; e “sofisticazione” non è mai presente nel lessico di Byars. Dunque è importante ricordare che non c’è niente di più moderno nella traversata di James Lee Byars, e neanche di anti-moderno. E nella sua mancanza, penso, Byars ha molto più in comune con Warhol e Ruscha, suoi contemporanei locali, che sono cresciuti durante lo stesso periodo e in circostanze simili, rispettivamente a Pittsburgh e Oklahoma City. Tutti e tre gli artisti, vorrei suggerire, sono cresciuti senza, sotto e alle spalle della moribonda cultura della modernità europea — sono cresciuti con sensibilità basate sulla ricca atmosfera di incertezza vittoriana e aspirazione che ha permeato il cuore della gioventù americana. Per questo, il ruolo dei “post-modernismi” che ognuno vorrebbe inventare, penso, sono cresciuti rispetto a un rapido e radicale accordo con quella moribonda modernità — cresciuta, nello specifico, rispetto alle sue reinvenzioni personali (o occultamenti) della pittura americana degli anni Cinquanta, di Pollock e de Kooning, Rothko e Barnett Newman —una reinvenzione che vorrebbe rendere un futuro possibile per loro e lasciare il passato disponibile, come non sarebbe accaduto ad altri “post-modernismi”. Dunque questi giovani vittoriani, suggerirei, questi bambini degli interni grigi, guardavano a tutto questo eccitante, eurotrascendentale dipinto e lo guardavano nell’immagine del loro stesso desiderio. Warhol guardava alle possibilità politiche e sociali della ripetitiva eleganza rococò; Ruscha, ai settori della écriture e alle atmosfere di testualità latente; e James Lee Byars, guardando a questi dipinti come fotografie, come inviti all’intuizione, individuata la loro goffa, didattica generosità. Prendendoli come koan — storie e domande alla base della pratica filosofica dello zen— visivi la cui autoritaria schiettezza egli voleva elegantemente invertire in un dematerializzato, interrogativo formalismo — un decoro dello spirito basato su un deterioramento sillogistico che rievoca l’orientalismo della belle epoque. Le differenze tra questi artisti sono come le loro analogie, e nel caso di Byard e Warhol, l’aspirazione immateriale del lavoro di Byars è stata probabilmente interpretata troppo alla lettera dalle sue somiglianze di superficie con Warhol. Per condividere, anche attraverso Byars e Warhol un linguaggio di opacità, inganno, e stravaganza. La retorica di stile dozzinale di Warhol è veramente sulla scalata sociale rivoluzionaria. Byars, d’altro canto, impiega le stesse strategie nei suoi lavori più recenti per ricostruire e intensificare i contesti sociali che Warhol invade insistendo sul loro realismo sensuale, investendoli di una iconografia di noblesse che non afferma di nobilitare qualcuno o qualcosa, ma piuttosto parla alla generosità e gli eccessi del puramente visivo.