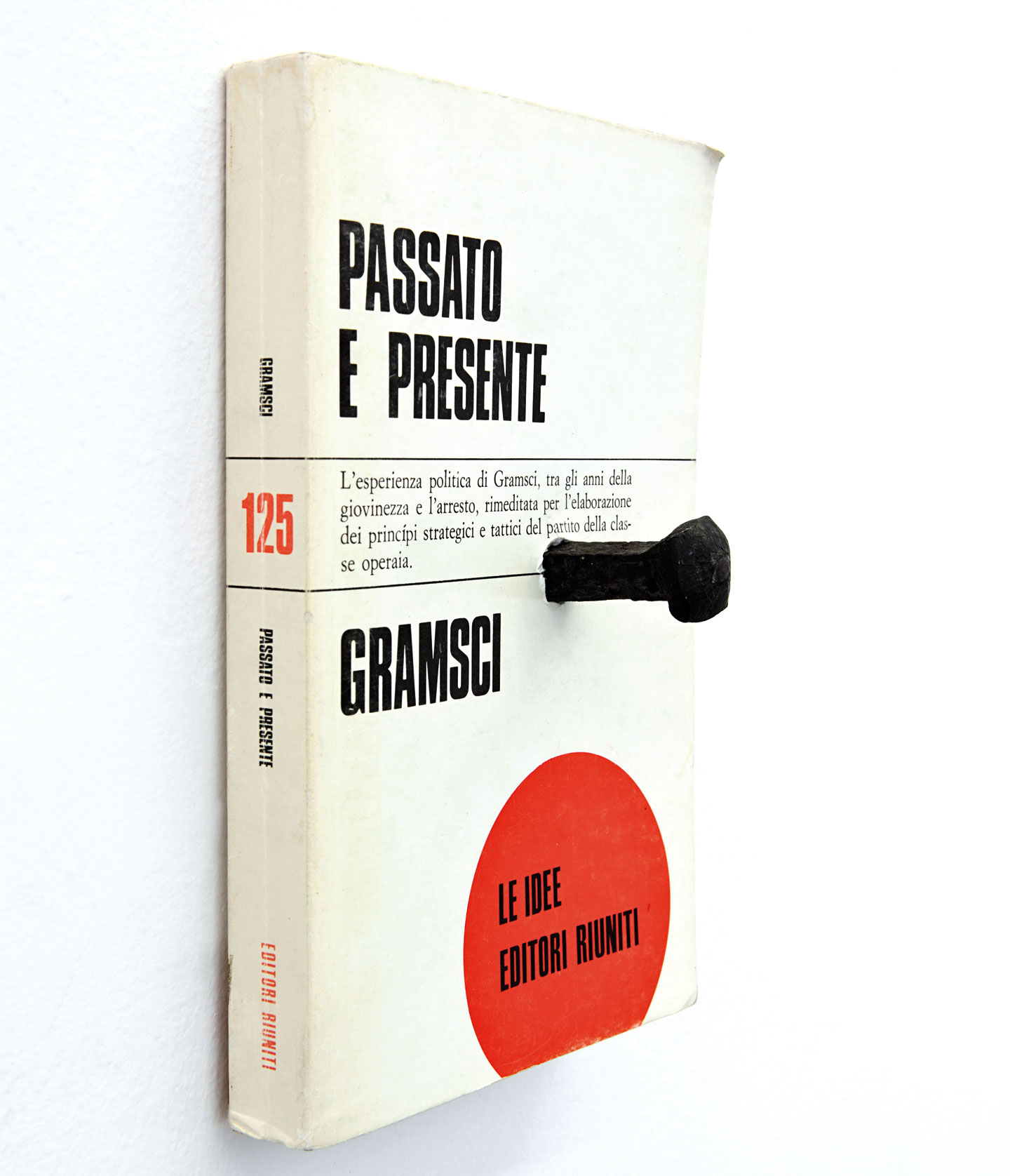Caro Jasa,
innanzitutto i miei complimenti per la tua partecipazione alla 56° Biennale di Venezia. Rappresenterai il tuo paese, la Slovenia, e immagino la cosa ti renda felice. Ci siamo conosciuti tanti anni fa, guarda caso proprio a Venezia, dove frequentavi l’Accademia, e da tanti anni ormai ci siamo persi di vista. Adesso siamo qui, a parlare ancora una volta di arte e del tuo lavoro. Stamattina pensavo a Proust e mi sono ricordata che in quei mesi, a Venezia, cercavo ansiosamente di leggere La Recherche — perdendo il filo ogni volta e non ho problemi a dirlo (perché fingere di aver fatto una cosa quando invece ci abbiamo provato e magari non ci siamo riusciti?).
Sai come inizia Dalla parte di Swann (il primo, per l’appunto, dei sette volumi de La Recherche)? Con una bugia. “A lungo, mi sono coricato di buonora”. Anche il tuo lavoro è una bugia, nel senso che le tue installazioni ambientali ricreano mondi che non esistono, e nei quali tu e il pubblico — invitato a interagire — vi muovete, raccontate storie. È vero? E le storie, come da prassi, si ripetono; così come si ripetono le azioni che metti in scena. Diventano rituali. E i rituali sono quasi sempre operazioni collettive. Che ruolo ha dunque il pubblico per te — ovviamente non come fruitore ma come soggetto attivo? È imprescindibile nel lavoro di un artista? Oppure si può farne a meno? Leggo che per tutta la durata della biennale i visitatori si troveranno coinvolti in performance multi-sensoriali attivate da te e dai tuoi collaboratori. Ma ritorniamo alle bugie dell’arte. Picasso dichiarava “L’arte è una menzogna che ci avvicina alla verità”. Secondo me non è proprio così, anzi forse è proprio il contrario. Partiamo da una verità per poi attraversare una o più bugie e infine approdare a qualche altra cosa. Soprattutto nella performance, dove i corpi si muovono, si scontrano, si recita, si canta, si balla, si urla, si lanciano oggetti… si diventa altro.
Qual è il momento esatto in cui smettiamo di essere uomini e donne per diventare artisti / scrittori? Secondo me c’è un momento esatto, proprio come quando si scopre la morte e si smette di essere bambini. Dico questo perché Slavoj Žižek — che è sloveno come te — ritiene che la dimensione privata, così presente nell’arte contemporanea, manca di autenticità, è pura messa in scena. Insomma, quando facciamo arte, il più delle volte fingiamo. Non siamo noi stessi, ritorna la bugia.

Leggendo Žižek, in fatto d’arte mi sembra piuttosto “nichilista”: dichiara infatti che le vere conquiste dell’Europa risalgono a un secolo fa, o più: Mallarmé nella poesia, Stravinskij e Schönberg nella musica, Kandinskij e Malevich nella pittura. Tutto ciò che viviamo adesso è insomma ripetizione, imitazione. Il fallimento del Postmodernismo che lascia spazio solo a nostalgie. Mi piace molto questa idea della nostalgia. Guarda, ritornando al discorso di prima, potrei concludere dicendo che si diventa artisti quando ci si rende conto che quello che stiamo facendo non lo stiamo facendo noi per primi, ma vogliamo fare a modo nostro qualcosa che è stato fatto da un altro o da altri. Tracciamo una traccia su un’altra traccia.
Sì. È vero. Altrimenti, cosa potrebbe essere il punto cruciale di tutto ciò? Quella che mi stai ponendo è una domanda profondamente legittima in una società selfie-compulsiva. Sei sicura che non riguardi te e la maggior parte delle persone, non è solo per te. Alla fine è chiaro che l’arte oggi è una faccenda come un’altra, con tutte le regole da pescecane di un capitalismo post-crisi rivisitato. Le alternative naufragano così velocemente, come le notizie di ieri. Non sono più i cinque minuti di fama, non sono neanche più i cinque secondi, sono cinque esempi di illusione; tu, tu che pensi a te stesso, tu che fai qualcosa per te stesso, tu che utilizzi una cosa che serve a te stesso e il divenire virale nella convinzione che questo sia davvero accaduto.

L’ultimo sogno impossibile. Dunque cosa resta? Niente e tutto. Il grado zero della verità, della fede che guida le azioni in direzione dei valori, azioni che ridefiniscono il motivo per cui noi agiamo, dove e come siamo dinamici. Io non posso vivere senza questo, senza il motivo, il processo che mi porta più vicino alla verità, perché mi ci è voluto così tanto per decidere responsabilmente che essere un artista non è un vaso di fiori che ti cade sulla testa in una pigra domenica, ma una vocazione che modella ogni cosa. Trasforma la tua vita in una prolungata fase di apnea, come trattenere il fiato sott’acqua, accettando il fatto che tutto questo non è progettato per quei mitici cinque minuti di significativa disillusione perpetua. Vuol dire trattenere il respiro e trovare l’impulso dentro le cose, accettando il fatto che sarai sempre sul filo del rasoio, come un ballerino, cercando il passo perfetto. Come rispondere alle tue domande? C’è una linea molto sottile tra una bugia, un’illusione e la cosiddetta verità. Il privilegio dell’arte di per se è soprattutto l’ultimo, e pertanto il più abusato. Quanti ladri chiamano due macchie di colore la definizione di stupore delle vite umane? Essi lo sanno. È abbastanza facile cadere in trappole semplificative di invenzioni, così come è semplice convincere te stesso, solo per mascherare i tuoi fallimenti. In arte non solo non abbiamo la possibilità di dire apertamente “ehi…và a quel paese, non ho assolutamente idea cosa significhi tutta questa merda che ho fatto venir fuori…”: questo non solo è facoltativo, è un dovere. Dubbi, crisi, depressione, black out… sono tutte parti del procedimento. Queste cose ci definiscono. Definiscono la grandezza. E io, sì, voglio dormire con i giganti, quando scende la notte (tirandogli le dita dei piedi).