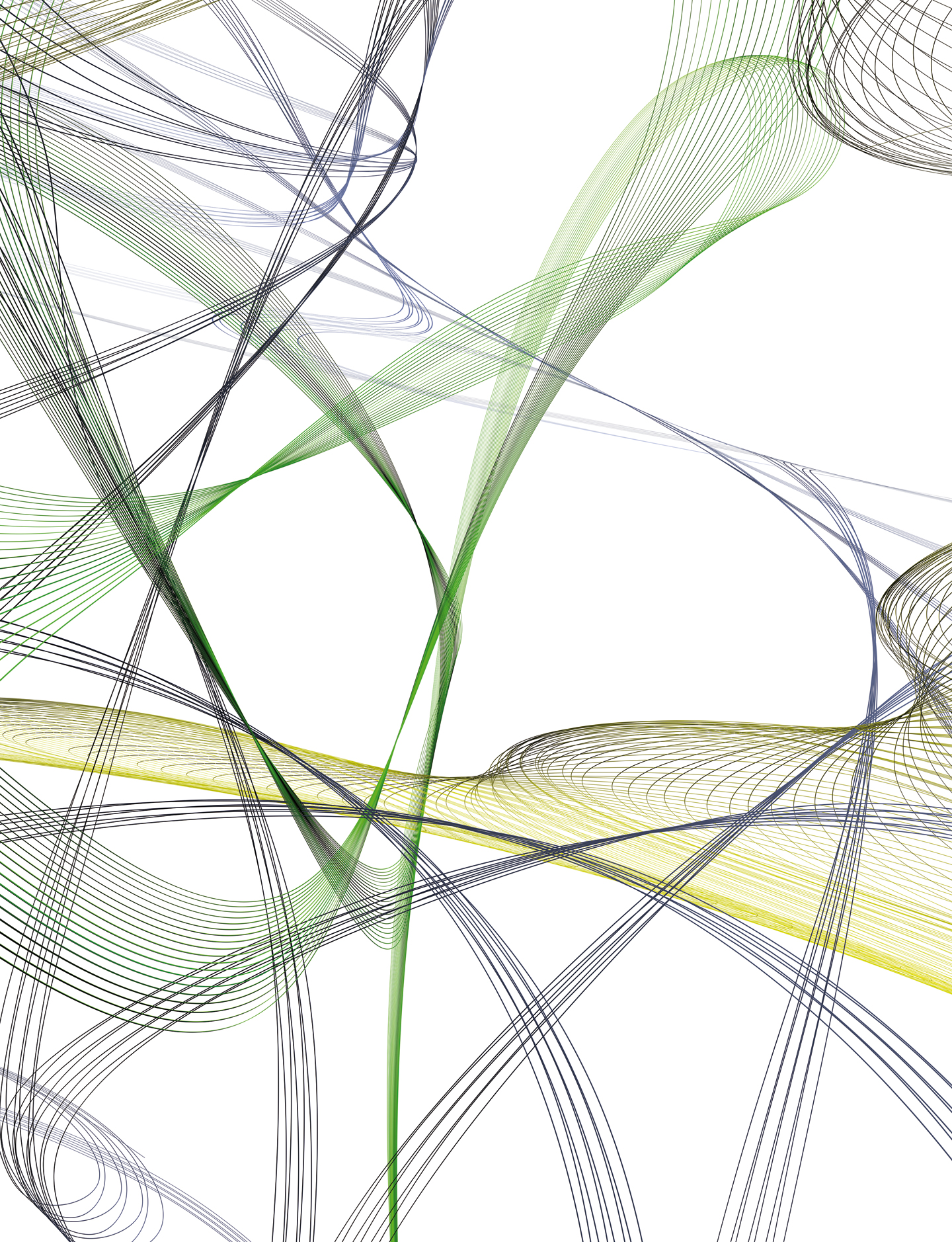Un giorno d’inverno del 1944, in una grande casa nobiliare a Quain, nella campagna francese, una casa che tutti chiamavan Il Castello, la famiglia dei proprietari e i contadini e alcuni amici vennero sorpresi da una retata di nazisti. Quando le truppe tedesche fecero irruzione nella proprietà, puntarono le armi alle schiene e condussero all’aperto tutti. All’aperto sarebbero stati fucilati. All’aperto sarebbero stati inchiodati al muro, e il plotone d’esecuzione avrebbe proceduto. Gli ospiti del padrone del castello erano schiacciati l’uno sull’altro a qualche metro di distanza dalle canne che li stanno per far fuori, alcuni pregano, altri urlano, altri rimangono irretiti in un silenzio fatto d’aria. Altri parlavano, provando a convincere gli assassini, in una lingua che non è la loro, che gli assassini pensavano di conoscere abbastanza da distinguere l’accento di un padrone da quello di un non-padrone. E fu esattamente questa sicurezza, e l’errore che sempre si cela in ogni armata sicurezza, a salvare la vita di Maurice Blanchot, una delle voci più raffinate, potenti, complesse delle lettere francesi del Ventesimo Secolo, che era originario di lì ed era tornato per una breve vacanza, e quel giorno era ospite nel Castello. I soldati si rivolsero a Blanchot credendolo il nobile padrone del posto e iniziarono a gesticolare, vada via, e Blanchot corse come in un lampo, nei boschi, e ogni cosa in questi lampi succede in un lampo. Così Blanchot rimase vivo, costretto a fuggire per sopravvivere, nei boschi che conosceva così bene.
Di questa storia vera Blanchot si è nutrito e dannato per l’intera vita, traendone poi un breve testo narrativo significativamente intitolato L’istant de ma mort. Da quando ho avuto notizia di questa vicenda non ho mai smesso di pensarci, per l’impressionante mole narrativa che contiene e per la luce ammaliante e gelida che profila sull’autore de L’entretien infini, un capolavoro di scrittura letteralmente senza limiti, e a mio parere una delle prime opere d’arte concettuali del Novecento — oltre che un singolare, densissimo libro d’artista, di un artista che non è un artista. Quando ho pensato al formato da dare a questa serie di interviste non ho potuto che rievocare silenziosamente la figura di Blanchot, e questa storia terribile, e l’idea stessa di intervista/conversazione infinita che in ampia misura è stata messa al centro del “discorso” sull’arte negli ultimi vent’anni, dalla morte del grande David Sylvester al tour de force dialogante di Hans-Ulrich Obrist.
Ma come spingere più in là il formato dell’intervista, senza farlo sparire e senza ripetere tracce già troppo fonde? Mi è venuto in soccorso il teatro stesso della beffarda vicenda di menzogna e salvezza di Blanchot — il plotone d’esecuzione. Mi è venuta incontro l’idea che forse si può riunire intorno a un artista significativo un certo numero di voci lontane e vicine al mondo dell’arte, appassionati, ammiratori col fucile dell’ammirazione caricato sulle spalle, pronti a eseguire — execute — con le loro domande l’opera di un artista. Ho immaginato una forma non dissimile, tutti davanti a lui, e lui davanti a loro — e io pronto a mutare forma, da presunto intervistatore a testimone, complice, faccendiere. Ho capito che poteva toccare a me, passando dalla tragedia di quell’aneddoto brutale alla commedia dell’arte contemporanea, cambiare identità all’ultimo, e raccontare le domande e le risposte, come il testimone murato in una conversazione altrui.
“Il mondo dell’arte è stato rivoluzionato completamente negli anni Sessanta, e oggi il mondo dell’arte è più o meno com’era quando è stato rivoluzionato negli anni Sessanta. Balliamo la stessa musica del 1954, in un certo senso, quando è accaduta la rivoluzione del rock’n’roll. È uno strano fenomeno, ma è come se il mondo non si fosse sviluppato, non fosse andato avanti. E nello stesso tempo, tutte le ragioni di cambiamento per cui abbiamo lottato, le ragioni che ci hanno portato a essere artisti, il mutamento sociale, l’educazione per tutti, la fine della violenza tra i sessi, tutto è fallito. E ora viviamo nella spazzatura, tutti. La sola cosa che è realmente successa è che oggi in qualunque angolo del mondo esiste quella che potremmo chiamare una comunità legata all’arte contemporanea. Se non ci fosse stato quel movimento negli anni Sessanta, il cui unico risultato è stato produrre il sistema dell’arte come lo conosciamo oggi, non saremmo nemmeno seduti qui, a fare questa conversazione. Non sarebbe potuta accadere quaranta, quarantacinque anni fa, perché c’erano tutti questi gruppi nazionali, un’idea nazionale dell’arte. Il mondo dell’arte è il primo e unico e solo esempio di globalizzazione che ha funzionato, in qualche modo. Su un raggio più ampio, l’economia globale stessa sembrava poter funzionare per un numero più grande di individui, migliorare la loro vita, ma è andata così solo per pochi anni, poi c’è stata una marcia indietro e tutto è diventato prima suburbano, poi etnico di nuovo.”
Così, con questa radicalità, con questa velocità, parla Lawrence Weiner, inarrestabile nella sua voce tumulata in un baritono croccante perfetto, e quando Lawrence Weiner — l’artista concettuale che in una famosa intervista Andy Warhol ha pubblicamente apostrofato con “è grande”, mentre di tutti gli altri dice sempre “è fantastico” — è arrivato a Torino, nell’ottobre del 2013, ho chiesto a tre artiste, un architetto, un collezionista-imprenditore-scienziato, e una giovane curatrice, di partecipare al plotone di conversazione con lui, gentilmente ospitato dalla galleria Persano. Sono arrivati uno dopo l’altra Ruben Levi, Elisa Sighicelli, Marco Rainò, Lara Favaretto, Greta Matteucci, ed è arrivata anche una domanda in busta chiusa di Sara De Chiara, assente solo con il corpo. Così ho officiato un rito di apertura, ho ringraziato Giorgio Persano che ha allestito una mostra splendida e tutt’altro che facile. Mi sono messo in disparte, a osservare quel che sarebbe successo. Le domande hanno iniziato a muoversi nell’aria. Le risposte si sono allacciate al racconto, tagliano le gambe al testo. Non è un’intervista, ma una fucilazione.
“Io sono un artista, e in quanto artista sono una persona completamente pubblica, non devo nemmeno ricordarmene della mia vita privata, non è un mio problema. Non so se sia una cosa salutare o meno. In realtà non ho vissuto una vita particolarmente eccitante.”

Lo ascolto, trascrivo, e mi viene in mente che davvero ciascuno dei presenti intrattiene (entretiens, facendo un “false friend” con il francese) con Weiner un rapporto peculiare, originale, intenso. Ruben Levi, per esempio, lo ha conosciuto per la prima volta quando è stato in Italia, ospite di suo padre, Corrado Levi, e Weiner se lo ricorda bambino, e l’acqua dei decenni è passata in modo così potente nelle vite di queste due persone che ho davanti, penso mentre le ascolto parlare di Oliver Sacks e di percezione — che non importa tanto quel che si dicono, ma il fatto stesso di parlare, un grande artista che ormai si può permettere di tutto e il figlio di un grande collezionista, il quale si è probabilmente permesso di tutto, e però ha anche lasciato in eredità al futuro un figlio straordinario, completamente multidisciplinare, fisico e imprenditore, collezionista a sua volta e anche generoso supporter di attività artistiche e di pensiero. “Forse la sola cosa che ha tenuto insieme l’epoca della rivoluzione artistica degli anni sessanta e la nascita del sistema dell’arte come lo conosciamo oggi”, aggiunge Weiner, “è proprio la generosità, sono cose accadute per generosità, e ancora adesso, in parte, accadono per generosità. Ma è ovvio che è necessario forzare i sistemi per fare cose interessanti, è importante non accettare i valori del mercato. Pensate a Katherine Bigelow, è un’amica, e abbiamo anche fatto dei lavori insieme. Prendi The Hurt Locker, il film che ha vinto l’Oscar. The Hurt Locker è un film molto molto interessante. Non solo per il dilemma esistenziale che pone a livello di contenuto, il fatto che molte persone in Medio Oriente siano diventate soldati mercenari. Il fatto interessante è che la regista non ha accettato nel suo film la struttura hollywoodiana dell’uso della macchina da presa. Tutto il resto del film è perfettamente Hollywood, ma non l’uso della macchina da presa. La macchina da presa cambia del tutto la mise en scene del film. Tu pensi di essere andato a vedere un film di Hollywood, ma i tuoi occhi non hanno visto un film di Hollywood. Non è una metafora dell’arte. È sull’arte. L’arte cambia la logica di guardare alle cose.”
Marco Rainò, curatore del progetto sugli innovatori nel design chiamato “In Residence”, seduto alla sinistra di questo padre del deserto che ha appena rifiutato un whisky e veste scarpe meravigliose, pone la questione grafica del “font” delle scritte di Weiner, e il suo rapporto con il design “Nel mondo del design ci sono così tante persone che hanno fatto la cosa giusta nel modo sbagliato, e hanno avuto un successo enorme”, lo interrompe Weiner, con il suo tono più convincente, per la prima volta addirittura mellifluo: la voce compie un’altra curva e arriva la cosa più bella della giornata: “l’arte, io credo, è proprio questo, fare la cosa giusta, nel modo sbagliato: ma è difficilissimo, ma io credo che tutta la grande arte sia il risultato di una buona azione fatta nel modo sbagliato, siamo tutti cattivi bambini che non ascoltano i genitori. Ed è la verità. I bambini che disobbediscono non fanno necessariamente cose sbagliate, ma fanno cose che i loro genitori non raccomandano di fare, e se guardi a quello che normalmente raccomandano di fare, puoi non dare ragione ai cattivi bambini?”

Elisa Sighicelli, artista il cui lavoro non sembra mostrare segni figliali rispetto all’opera di Weiner, lo ammira con tutto il potere di cui è capace: lo osserva, prende appunti, sembra felice, e all’improvviso gli fa una domanda sul suo modo di lavorare, su quanto tempo medita intorno a opere come quella installata ora in galleria, così estese e profonde al contempo: “A volte mi ci vogliono anni per concludere un pezzo, a volte due anni, dipende anche dal materiale, e se devo lavorarci in studio o posso portarli fuori dallo studio. Tutto comincia sempre dal materiale. Da ragazzo, anche da adolescente, pensavo ‘quando è finito, è finito’. Ora non la penso più allo stesso modo…”
Al termine dell’incontro con Weiner, che spero in futuro si potrà leggere nella sua interezza, trascritta da Sara De Chiara riga per riga, mi sono reso conto che due persone del gruppo non hanno rivolto neppure una domanda: Greta Matteucci, forse ipnotizzata dalle parole e dalla stranezza di trovarsi lì, e Lara Favaretto. Stiamo uscendo dalla galleria, mi giro, osservo la porta dell’ufficio dove si è svolta l’esecuzione, e comprendo all’improvviso che il ruolo di Blanchot non era destinato a me, bensì a Lara, un’artista la cui opera in fieri è altrettanto concettuale e per certi versi piena di simmetrie possibili con Weiner. Li guardo parlare, da soli, sotto la cornice dello stipite, toccandosi le braccia e guardandosi negli occhi, e vorrei — ma non vorrei — sapere di cosa stanno discutendo. Weiner sembra presente e insieme assente. Lara Favaretto sembra fuggire nei boschi, complice e salvata dall’esecuzione. La cosa giusta nel modo sbagliato — o come ha detto Weiner stesso, “la sola domanda cui vale la pena di rispondere: ‘quanti angeli possono danzare sulla punta di una penna?” Mi piace credere che Blanchot, pieno di vita e di morte e di senso di colpa, correndo nei boschi che conosceva così bene, quel giorno del 1944, si sia chiesto la stessa cosa.