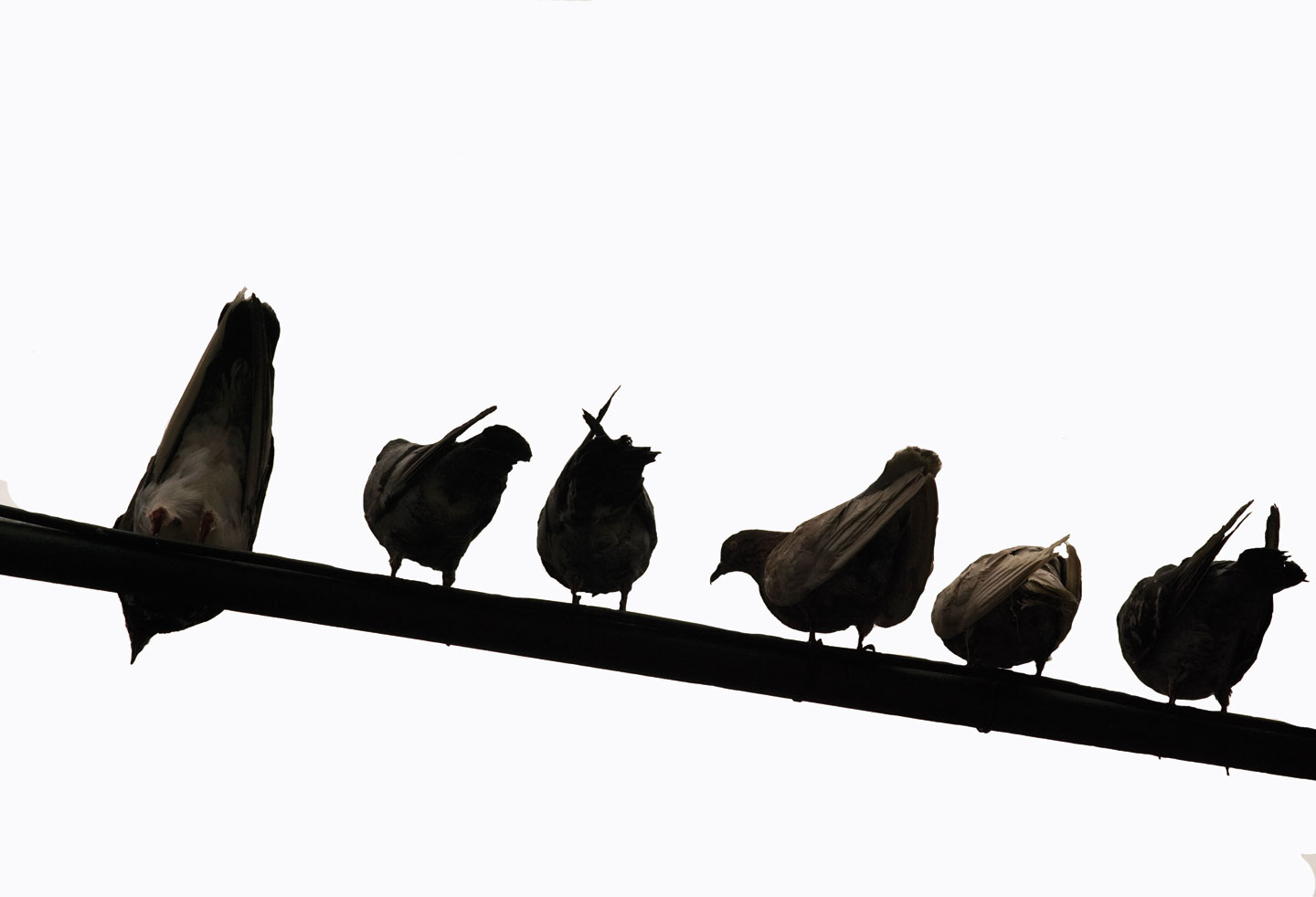Quando Mario Ceroli arriva a Roma ha otto anni: la città avrà una grande importanza per la sua vicenda artistica. Frequenta l’Istituto d’arte, giovanissimo lavora con Leoncillo, Fazzini, Colla. Nel 1956 comincia a lavorare per conto suo, tiene una prima mostra di ceramiche (a sedici anni), poi, alla fine degli anni Cinquanta, comincia a lavorare il legno e già nel 1957 vince il premio della Galleria Nazionale d’Arte Moderna con un pezzo costituito da tronchi e chiodi. “Andavo al vivaio di Roma, il vivaio San Paolo, e prendevo dai giardinieri questi tronchi d’albero, li caricavo e li portavo in studio, poi li spaccavo, li tagliavo. Nel 1960 ho scoperto la possibilità di usare un materiale industriale, come una tavola, un asse di legno… Questa cosa che io sono uno scultore del legno non è affatto vera, perché ho fatto diverse esperienze con i materiali: ho usato il legno, ho fatto ceramiche, ho usato il marmo, ho realizzato cose con il ghiaccio, con l’acqua, ho fatto cose di carta, cose di stoffa. All’inizio ho scelto il legno perché ero molto povero e il legno mi dava la possibilità di realizzare un’idea immediatamente senza l’intervento di collaboratori, che potrebbero essere un fabbro o una tipografia. Il mio lavoro l’ho sempre fatto io, senza interventi esterni” (da un’intervista in Bolaffiarte, n. 16, 1972 in Linee della ricerca, cit., pag. 46-47).
Il legno è, anche nella cultura orientale, uno dei cinque elementi fondamentali, ma è importante per Ceroli aver usato molti altri materiali, perché condivide con la propria generazione un fortissimo spirito di sperimentazione. Secondo Ceroli questa possibilità si svilupperà soprattutto dopo la mostra di Foligno del 1966. Nel 1964 Ceroli espone presso la Galleria La Tartaruga, prima in una collettiva poi in una mostra personale. Gli oggetti della collettiva, di grande nitore plastico, sono più monumentali e realizzati con il legno. Scrive Mario Diacono: “Dal vocabolario, dal logos proprio della strada Ceroli coglie (e li pronuncia cubitalmente, capitalmente) una lettera, un numero, un Sĺ e un NO, l’orologio, il telefono, e scandisce un tempo di legno, di tavole nude e chiodi estroversi, che si dichiarano come iperbole manuale” (Mario Diacono in Catalogo, n. 1, edizioni La Tartaruga, Roma 1964). Nel breve tempo tra la collettiva e la personale (con pezzi come Asso di fiori, Uomo di Leonardo, Adamo ed Eva) il gioco della figurazione si è fatto più ricco, come nota Maurizio Calvesi: “Spesso l’immagine, ritagliata nel legno, ha per sfondo la sagoma vuota, il negativo del ritaglio; o, al contrario, è il pieno che fa da sfondo al vuoto. Il senso del giuoco vuol essere quello pop, semmai, della figurina ritagliata. Il disegno, pur giuocando con gli spessori dei piani avanzati o arretrati, rimane intenzionalmente piatto, proiettivo, semplificativo, con saggi di scorci e abbreviature pur sempre frontali, sintetizzati nel puro contorno” (“Dritto e rovescio”, in Catalogo, n. 2, cit.). Oggi invece appare più interessante notare la presa di distanza dalla Pop Art. Il legno è per Ceroli un materiale primario, disponibile, che presta il suo corpo all’immagine. “È come se tu mangiassi un biscotto” dice l’artista, “c’è sempre un rapporto fisico con il materiale. Non ho mai sfasciato le casse d’imballaggio, semmai ho costruito la Cassa Sistina. Il marmo per esempio è di una tale bellezza, lo devi usare così come te lo danno”. In Ceroli c’è amore per la materia, ma c’è anche rappresentazione teatrale. Nel 1969 a Berlino la Galleria René Block presenta una performance di Ceroli con una balla di carta pressata e in cima una palla di stracci (in una delle foto dell’evento appare Lucio Amelio che faceva da traduttore alle lezioni di Ceroli che insegnava all’Università di Braunschweig). C’è un rapporto performance/scultura che nega il presupposto della staticità.

La sagoma, elemento caratteristico di un certo lavoro degli anni Sessanta, nasce dall’idea di svuotare l’immagine e coglierne il segno essenziale. La sagoma è nel campo figurativo quello che il monocromo è per la superficie astratta: un grado zero, una base, un virtuale punto di partenza. “La sagoma riporta l’uomo alla sua purezza” scrive Maurizio Fagiolo dell’Arco a proposito di Ceroli facendo riferimento al manichino, forse un indiretto omaggio a de Chirico dell’artista che ha dedicato più esplicitamente un’opera ai Mobili nella valle (1965). Ma il riferimento al grande metafisico c’era già in Piazza d’Italia (1964) e questa dedica corrisponde a una scelta precisa. La metodologia solitamente seguita da Ceroli nella scultura, contrariamente alla nostra idea, derivata da quella michelangiolesca che la scultura si faccia “per via di togliere”, è fatta “a mettere”: “Brancusi toglieva, Fazzini anche, mentre a me nelle prime cose fatte con il legno piaceva aggiungere, e da un’asse di legno, da una sagoma, sovrapporre spessore. Così si ottiene un movimento in chiaroscuro diverso e si racconta meglio” (intervista a Mario Ceroli di Laura Cherubini in Flash Art n.173, marzo 1993, pag. 41).

Molto importante per Ceroli è il rapporto con lo spazio, con l’ambiente, di cui si comincia a sentire l’esigenza. Nel 1966 esegue Cassa Sistina, uno spazio inventato dall’artista che contiene tutti gli oggetti: è l’idea di una casa per i lavori che troverà permanenza nell’opera dell’artista (Casa del Nettuno, Bologna 1988). “La scultura è nel ritagliare, nell’aggregare, nel sovrapporre, nel connettere, nel sommare. In questa sostanza universale le immagini si esprimono attraverso il puro contorno e l’aggettare della materia” (Giorgio De Marchis, “Ceroli costruisce una casa”, in Catalogo n. 3, cit.). Le figure di Ceroli si replicano, invadono lo spazio, ma l’ambiente presuppone sempre il punto di vista di uno spettatore. Entra in gioco il valore della serialità, sottolineato da Calvesi che scrive: “Ceroli si propone temi (La Cina, La fila), nei quali la serialità risulta non già come un mezzo di sollecitazione e moltiplicazione dell’immagine, ma coincide con il tema stesso, con l’idea stessa da rappresentare” (“Le idee sono di tutti”, in Ceroli, Catalogo della mostra presso la Galleria La Tartaruga, Roma 1966). La serialità è dunque un valore intrinseco, strutturale, dell’immagine che racchiude in sé la possibilità di iterazione. Forse anche per questo Ceroli “comincia a sagomare gli spazi per la vita” (Fagiolo), si avvicina all’architettura, inizia a lavorare non più per la casa, ma per la città.

In Balcone (1966) la figura umana appare, come sempre in Ceroli, life size. Le sagome sono articolate attraverso cerniere snodabili. Maurizio Fagiolo ha parlato di archi-scultura a livello iconografico poiché ogni opera è un pezzo urbano dal punto di vista linguistico per il rapporto architettonico con i personaggi, la progettualità, il senso degli incastri, la ripetizione modulare. La ringhiera è già un brano di architettura e il balcone è già un affaccio su quella scena urbana che è sempre stata aspirazione per Ceroli e alla quale l’artista è approdato in realizzazioni più recenti come quelle per la Chiesa di Tor Bella Monaca a Roma (1987) o il Teatro a Porto Rotondo (1989). “A Porto Rotondo ho fatto la chiesa, poi molto più avanti ho fatto il campanile, il sagrato, e mi sono rimesso a lavorare come un bambino”. Il rapporto della figura con la struttura, particolarmente evidente in questa opera, corrisponde all’idea che misura del costruire è l’uomo.


A quel punto si distacca dalle gallerie perché “il mio lavoro fa fatica a starci dentro”. Il rapporto con lo spazio è forte e importante. “Ho sempre mirato a fare interventi che coinvolgessero spazi pubblici, il mio godimento sarebbe fare un giardino, delle piazze… e oggi mi riesce… I quadri dietro il divano li detesto!”. Nel 1966 l’opera capitale Cassa Sistina gli vale il Premio Gollin con una borsa di studio per New York, città in cui resta circa tre anni. Torna perché pensa che il lavoro abbia bisogno di un “suo” luogo. Nel 1967 a Spoleto realizza la Punta del mondo: una piramide di ghiaccio alta 10 metri alla cui sommità è posta una grande palla di carbon coke che si muove come un pendolo di fuoco. “È stata lì, sotto la cupola di Buckminster Fuller, per tutto il periodo del Festival, quasi un mese, perché le colonne di ghiaccio si solidificavano le une con le altre resistendo di più. A Milano da Cardazzo feci la Vasca delle ninfee, una sorta di stagno con il ghiaccio dentro, mentre le ninfee erano di legno e galleggiavano. Una cosa che nessuno ha mai raccontato del mio lavoro e che ne costituisce la base è questa: è come se io avessi avuto incarico dai materiali di rappresentarli sul pianeta terra: io in fondo sono stato un tramite, ho raccolto materiali che sono molto vicini agli uomini. Penso che uno dei materiali sia proprio il legno, l’albero, che è la vita, assomiglia molto all’uomo”. La similitudine riguarda proprio la struttura fisica, l’albero infatti ha una posizione eretta, la sua chioma corrisponde alla testa. “Ci sono molte cose che l’albero ha trasmesso all’essere umano per essere concepito. L’albero è quello che ha suggerito i materiali. L’essere umano alla base è composto di colori, per questo ho usato anche le terre colorate, perché ognuna ha un elemento corrispondente nel corpo umano: il sangue, ecc. Mi sento un rappresentante del pianeta dei materiali, questo si legge nell’insieme del lavoro: nelle terre colorate, nella carta, nella palla di stracci, nel carbone, nella paglia, nei rami… Loro stessi, a parer mio, hanno suggerito come e dove essere collocati”. Ogni materiale ha voluto il suo teatro secondo la propria identità. Notiamo che a Graz Ceroli realizza con la parola “Identità” una scritta poi bruciata all’esterno del museo. “Mi piaceva l’idea perché il legno bruciato dura di più. La parte infissa nel fango delle palafitte che sostengono Venezia è bruciata, perché così è meno attaccabile”. In questo modo, in un folgorante paradosso il fuoco, che dovrebbe consumare, fissa e conserva ciò che resiste dell’identità dell’uomo. Nel 1968 l’uso del ghiaccio torna al Teatro delle mostre (attraversando una serie di porte si arriva a una parete di ghiaccio destinata a sciogliersi), la sequenza di eventi che fa calare il sipario sulla prima fase della Tartaruga di Plinio De Martiis, un avvenimento mitico che cambia il modo di fare arte e di esporre. Lo stesso lavoro per il teatro prende il posto di mostre tanto grandi da non poter essere ospitate in gallerie. “Il teatro l’ho usato come galleria” dice l’artista, che non realizza mai la scenografia, ma porta in scena il suo lavoro, come farà con il Progetto per la pace e per la guerra del 1969, le bianche bandiere riapparse nel 1970 nel film di Patroni Griffi Addio fratello crudele (e più tardi, nel 1993, alla Biennale di Venezia). Più che come scenografo lavora come interprete del testo teatrale intervenendo sullo spazio e realizza Riccardo III con Ronconi, Orgia con Pasolini, Trovatore con Patroni Griffi, Norma con Bolognini e ancora con lui la Tosca nel 1990. “Ero amico di Carmelo Bene, una persona fantastica. Era un cantastorie che incantava. Voleva rifare il Pinocchio con me”.

Il lavoro di Mario Ceroli è così vitale perché il fatto è che ogni volta Ceroli ridisegna la vita. Resta non esposta la splendida serie dei banner monocromi del 1972. Un anno d’amore è un soffitto fatto di 365 quadrati più uno per il titolo. Come nel 1963 aveva sperimentato la lamiera ondulata e ne-l 1964 le materie colorate, dal 1984 inizia la sperimentazione sul vetro. Gli anni Ottanta segnano comunque la ricerca sul tema del “tuttotondo”, tuttavia neanche in questo caso la scultura si fa mimetica, piuttosto dialettica nei confronti dell’ambiente. Per i lavori più recenti Crispolti parla di scenicità intrinseca al corpo dell’immagine, e lo stesso autore nota che la scala è uno dei luoghi ricorrenti dell’immaginario di Ceroli proprio per la sua percorribilità scenica. Con opere realizzate tra il 1990 e il 1991, come Uccello di fuoco, Il vento, Fantasma, Ceroli sembra dare corpo all’incorporeo, dare rappresentanza anche a queste materie impalpabili e ai limiti dell’invisibilità. Parallelamente un materiale come il vetro diventerà sempre più importante. La serie delle “Talebane”, nei primissimi anni del nuovo secolo, sembra essere l’epilogo ultimo della vicenda della sagoma, un’avventura iniziata sotto il segno dell’ironia. È stato ancora Crispolti a notare che l’aspetto ludico-ironico del lavoro di Ceroli si è manifestato nella serializzazione della sagoma.
Tutto prelude a un ampliamento sempre più vasto. “Gli artisti, secondo me, debbono ribaltare la situazione e lavorare per la comunità, diventare utili, l’intervento dell’arte e della cultura deve entrare nei quartieri, nelle strade perché nelle case non serve” (intervista a Mario Ceroli di Laura Cherubini in Flash Art, cit.). Quello che si può con sicurezza affermare è che Ceroli ha avvertito con grande anticipo sui tempi l’esigenza di lavorare su grande scala, nell’orizzonte della scena urbana, per tutti.