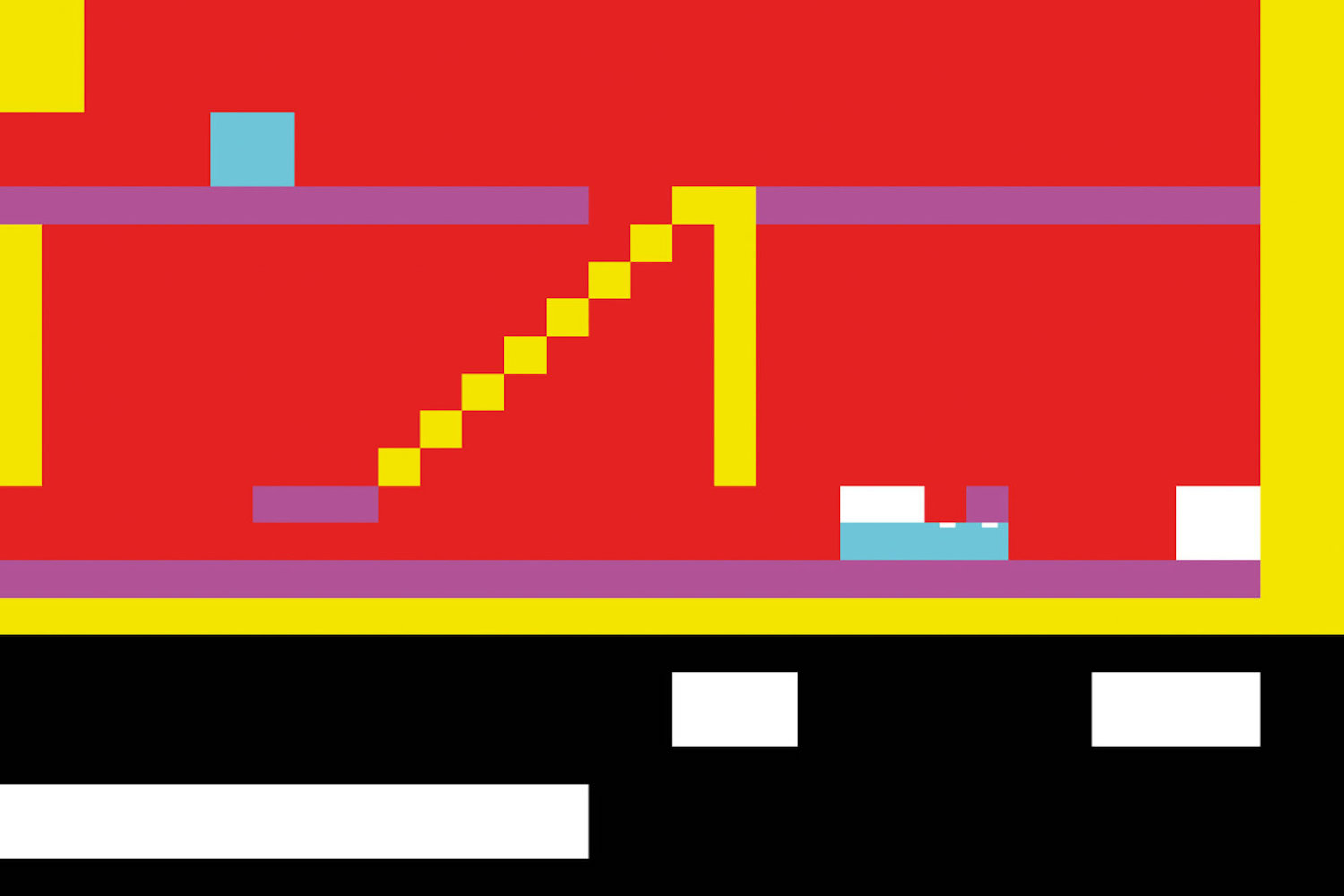Il Senza Titolo a Rivoli è stato per molto tempo l’unica opera di Marisa Merz acquisita da un museo pubblico, e per diversi anni l’ho avuto sotto gli occhi quasi tutti i giorni, e quasi sempre mi colpiva una sua caratteristica. L’opera è di dimensioni ragguardevoli, cosa rara nel lavoro dell’artista, ma ciò che ne faceva ai miei occhi un’opera significativa era la modalità con cui era costruita, diciamo le “condizioni della sua messa in forma”. Essa è infatti costituita da una grande superficie di cartoncino su cui l’artista ha delineato un ritratto con i suoi consueti tratti grafici fitti, vere tessiture che sembrano sfaldarsi in lunghe linee tremule, mentre chiazze cromatiche gialle e bluastre si distendono liberamente, cioè indipendentemente dalla figura, su un fondo grigio.
Questo dipinto è collocato dentro una scatola di legno, e sopra la scatola, a proteggere il disegno, è appoggiata una lastra di vetro. Questi tre elementi che “stanno per” il quadro e per la sua cornice, che li evocano senza esserlo, sono a loro volta appoggiati su un alto e stretto tavolino, che richiama il mobile di arredo, se non fosse per i materiali di cui è fatto. Quest’ultimo elemento è realizzato in ferro, il piano d’appoggio è retto da montanti identici a quelli usati per le scaffalature di tipo industriale. Naturalmente, l’opera è costruita da tutti questi elementi insieme, il ritratto dipinto, per quanto di grandi dimensioni, non ne è che una parte. Si direbbe anzi che la sua posizione comunque centrata venga enfatizzata dai materiali, tutti non canonici, che la contornano proprio per essere messa in questione, forse addirittura derisa.
La caratteristica che colpisce in quest’opera è precisamente la mancanza di vincoli, di nessi costruttivi stabili, definitivi: tutto è invece provvisorio, tutto è semplicemente appoggiato, accostato, o montato, come i montanti appunto del “mobile”, che potrebbe essere ogni volta rifatto.
Questo Senza Titolo risale al 1985 ma risente pienamente del clima di radicale ricerca nel quale il lavoro di Marisa Merz si è generato, l’epoca dell’Arte Povera ai primordi, quando uno dei postulati dell’opera d’arte era proprio la rinuncia alla sua definizione perentoria e univoca, cioè al suo assetto stabile, definitivo. Nel 1968, i quattro segmenti curvilinei in fili di nylon lavorato a maglia che formano il cerchio O sulla terra vengono lasciati sulla spiaggia di Amalfi, e l’opera consiste propriamente in questo disfarsi, questo destrutturarsi grazie a un moto naturale, altro dalla volontà del soggetto.
Il soggetto al centro: proprio questo veniva rifiutato allora, e se molti artisti hanno varcato una simile frontiera per poi pietosamente ripiegare, per Marisa Merz da allora il movimento è sempre stato quello di avanzare. Non basta: se i molti o i quasi tutti all’epoca ponevano l’opera in un divenire morfologico che ne ridiscuteva in toto i postulati, Marisa Merz da quelle premesse estreme non si è mai allontanata, a differenza degli stessi molti che hanno poi ri-costruito, ri-definito, ri-chiuso il cerchio che con lei poteva liberamente fluttuare.
Strano che nessuno fra gli esegeti dell’artista abbia mai messo in risalto questa scelta di coerente radicalità. L’attenzione si è piuttosto rivolta al rapporto arte-vita, mercè alcune dichiarazioni dell’artista, poche fra le pochissime mai rilasciate, che risolvevano il “caso” Marisa Merz nel connubio accertato e poeticamente abitato tra la sua produzione artistica e la sua vita quotidiana, coniugale, familiare. Anzi, si è trattato quasi sempre di risolvere il “caso Marisa”, tante volte l’artista è stata chiamata solo con il nome proprio, come fosse un’amica a cui confidare pensieri privati, intuizioni nate da una frequentazione intima, invece che una delle più visionarie artiste d’Europa su cui occorre imbastire un discorso critico, scientificamente probante e rispettoso.
Dunque, l’opera di Marisa Merz è sempre stata “nomadica”, nel senso, direi letterale, che si origina a partire da un contesto e si adatta poi ad abitare i contesti più diversi. Per fare questo, per farlo fino in fondo, occorre che il corpo dell’opera si faccia minuto, leggero, trasportabile, che sia composito, fatto di tante cose, di tanti elementi, ma non troppi quantitativamente, altrimenti il trasporto diventa faticoso e complicato (anche del filo di rame lavorato a maglia, con cui l’artista crea reticoli immateriali che si espandono nello spazio per via di minimi riflessi di luce, si potrebbe pensare che le maglie possono essere disfatte, come si fa con la lana, e il filo raccolto di nuovo in gomitoli…). La molteplicità dovrà essere piuttosto qualitativa, e sufficiente perché gli elementi che compongono l’opera, anche se non numerosissimi, prendano e diano senso in quanto possono creare relazioni, fra loro stessi e fra questi e lo spazio che li ospita. Pensare a quale totale mancanza di prosopopea governi questa attitudine, e aleggi fra queste opere, che per questo diventano sempre più attuali a fronte della volontà di potenza espressa oggi tramite tanta diffusa ingordigia tecnologica.
Coerenza e forza di questa artista: le opere di Marisa Merz sono spessissimo di piccole dimensioni, ma possono assumere una grande forza, una simbolica forza centrifuga: la piccola fontana di cera, in forma di quadrato, collocata a terra, al piano terreno del Fredericianum, isolata dal contesto di quella Documenta particolarmente vasta, sembrava promanare sufficiente energia per imporsi a tutte le altre numerosissime opere esposte a Kassel, nel 1992.

La prima mostra museale e retrospettiva dedicata all’artista, quella organizzata dal Centre Pompidou, dava un esempio lampante di cosa significhi per un’opera d’arte la definizione di provvisorio. Ogni sala, ogni parete, ogni angolo mostrava il possibile “arrangement” delle opere (come dice il mio amico Ange Leccia, arrangement esprime la provvisorietà di un insieme, a differenza della parola “installazione” che tende ad assumerne un significato più strutturato) che entravano tutte a far parte di complesse costellazioni, senza che nessuna delle loro regole linguistiche e compositive determinasse a priori un tale risultato. Il contesto, o forse addirittura il caso, aveva determinato quelle vicinanze, quegli incontri, e creato nuove sintesi di senso all’interno di un universo già formato, e da molto, ma mai cristallizzato, mai depositato, mai fondato una volta per tutte. E in ogni angolo, a ogni parete, un senso di provvisorietà fortissimo: un dipinto appoggiato alla parete, a terra, come se stesse per partire, accompagna un disegno appeso, mentre di fronte una bassa base metallica fa da minimo piedistallo per una piccola scultura; una larga e bassa base quadrata raccoglie undici sculture al centro della sala, mentre un insieme di quattro piccole teste su alti piedistalli metallici sta raggruppato in un angolo, e un altro lavoro di piccole dimensioni a loro accanto viene collocato a terra, come fosse stato lasciato lì, casualmente.
Eppure nulla è mai casuale in questi arrangement, sembra anzi che la sapienza compositiva dell’artista emerga tanto più lampante in quanto viene ogni volta sfidata, messa alla prova di nuovi ambienti espositivi, di nuove esigenze installative. Il Senza Titolo del 1993, la piccola testa rosseggiante su alta base metallica esposta da Christian Stein in quell’anno, che vediamo ben riprodotta sul catalogo della personale a Villa delle Rose, sembra creata per stare di fronte al muro dove il gioco diagonale dei fili di rame incontra, in alto a destra, il piccolo disegno su tela; tutto l’insieme sembra esistere per dar vita a questa relazione e a nessun’altra.
Quella che articola nella sistemazione sempre variata delle opere è un’arte dell’ostensione che non fa tanto pensare alla casa, anche se forte è questo richiamo nelle primissime opere, quanto a uno spazio adibito alle ostensioni, dove sono utilizzati oggetti anche comuni ma investiti di uno speciale valore trascendente: si tratta dello spazio sacro, degli altari che fanno da soglia tra l’umano e il divino, luogo fisico di uno scambio puramente simbolico. Opere come il Senza Titolo composto da una piccola vasca da bagno piena e contornata da lastre di paraffina, rami secchi e carte appallottolate fa pensare proprio a questo, a oggetti e materie comuni sacralizzati, a una sospensione, nello spazio e nel tempo, che trascende la quotidianità (alla stessa stregua delle tazze che, piene di sale, ne trasudano) ed evoca un’altra dimensione.
Una simile sensazione, un simile rapimento estatico, viene espresso dalle opere da quando sono intervenute le piccole teste cui Marisa Merz lavora dal 1982, in argilla non cotta, in cera o in gesso, tutte precedute da una scultura realizzata nel 1975. Comincia quel “turbamento dell’identità” di cui ha parlato Tommaso Trini, motivato dal non voler scendere sul terreno delle definizioni, e perciò dallo stare nello stadio della prefigura che consente all’opera di porsi, alla fine, come fosse senza tempo.
Nella maggior parte dei casi esse vengono esposte su basi metalliche (in un caso su legno egresso), di solito alte e conformate come gli alti treppiedi che ricordano l’atelier, la struttura intorno a cui lo scultore opera, tenendo la materia da manipolare appunto appoggiata in alto. Vengono in mente figure classiche, Rodin, Brancusi (una delle teste esposte al Pompidou recava come sottotitolo Omaggio a Brancusi), e sono realizzate con uno stile barbarico, per continuare con le citazioni da Trini. Blocchi di materia appena arrotondati recano tratti somatici sommari, occhi globosi o orbite, estroflessioni che indicano i nasi, ottenuti con gesti elementari, minimi, delle mani. Per lo più, le facce non ci guardano, rivolgono lo sguardo verso l’alto, al museo di Winterthur erano esposte in fila, e guardavano la parete. Spesso sono colorate, con stesure liquide, o con inserti preziosi di foglie d’oro, o anche con colate di cera che introducono sommovimenti metrici e cromatici. Non appartengono al nostro mondo e non fanno niente per nasconderlo, testimoniano di quell’altrove per la cui evocazione si allestiscono gli altari. Il loro aspetto rimanda a epoche arcaiche, a culti barbarici appunto, eppure sono nostre contemporanee per la grazia che da esse emana. La grazia è una delle forze di Marisa Merz, un carattere gentile che attraversa tutta la sua opera e che l’artista ha sempre saputo coniugare con la radicalità, con l’estremismo di certe scelte, soprattutto con la sua appartenenza, dopo tutto, alla genealogia dell’antigrazioso, il retaggio indelebile delle avanguardie, a cui resta legata. Sembra ed è un paradosso, che però si scioglie in realtà, quando capita di vedere un piccolo blocco di argilla appena arrotondato, provvisto di una piccola cresta liscia, inserito dentro un contenitore stretto, fatto di due pezzi di metallo avvitati insieme alla bell’e meglio: sopra questo accoppiamento poco giudizioso di materiali svetta un fiore, e questa è la grazia, che improvvisamente rende bello ciò che sembrava amorfo (che a noi sembra tale, ho detto che l’artista va sempre avanti…).

Direi che la ricerca di identità, se così si può definirla, di Marisa Merz si fonda propriamente su questo connubio ossimorico, da cui deriva la sua potenza visionaria. Penso ai dipinti, come quello di Rivoli, ma penso soprattutto ai disegni, su carta e soprattutto su tela, tanto più conturbanti in quanto coniugati in piccole dimensioni. Ce ne sono alcuni, esposti da Christian Stein a Milano nel 2002, su lastre di ferro, in cui i ritratti sono definiti da velocissimi tratti minuti, e le tecniche, dal pastello all’incisione sulla materia, cosi varie che si possono solo definire “miste”. Ma quelli più noti e caratteristici sono realizzati a matita o pastello, privi di colore o con avare accensioni cromatiche. Il tratto è di una levità straordinaria, ma nello stesso tempo ha forza, la forza necessaria per costruire la figura tramite intrichi di linee che sembrano interminabili. Curve, linee che si curvano per definire gli occhi, le orecchie, che si assiepano e si diradano lasciando come dei varchi, delle aperture, dislocate liberamente, indipendentemente dalla resa realistica della figura, che risulta costruita con la più estrema, forse ironica libertà. Le figure appartengono a un universo visivo imprevedibile: a volte ricordano l’eleganza dei Simbolisti, sembrano proprio imparentate, e profondamente, con quell’universo di enigmi, altre volte sembrano avventurarsi nei territori del grottesco (così come in alcuni dipinti il trascinamento verso la visionarietà imparenta le immagini alle caricature).
A volte il gesto stende dei veli, neri, sulla superficie, e la figura ne esce quasi come in negativo, zona bianca, vuoto profilo che ordina l’assedio circostante, lo costringe a darsi un nome, a fare significato. I tratti curvilinei costituiscono la retorica di base che dà vita a queste apparizioni, ma spesso si confrontano con schermature quadrangolari, segmenti rettilinei verticali o orizzontali, che complicano la percezione della figura, il lavoro dell’occhio, per riconoscerla nell’intrico, ed evocano una spazialità complessa, sovrapposta alla bidimensione e atta a destrutturarla.
Rudi Fuchs ha scritto una cosa molto importante a proposito di questi lavori: essi testimoniano del lavoro di un segno inarrestabile che sembra voler crescere su se stesso piuttosto che fermarsi, piuttosto infiorettare la superficie di ghirigori che smettere di fare figura. Marisa Merz crea figure costruite sull’ossimoro perché il suo intento guarda a due opposte direzioni: fare emergere l’identità — la rappresentazione del sé come problema, cioè a dire fuori da ogni auto-compiacimento gratificante — ma rifiutare per essa ogni definizione univoca. L’identità è un’ipotesi non si sa ancora se positiva o negativa, se è qualcosa da raggiungere o di cui liberarsi, e forse in assonanza con Gilles Deleuze l’artista ci ricorda che alle identità fisse è preferibile il divenire, il porsi in divenire, la volontà di farlo. Fuchs impiega il termine di infinitezza nel senso che il tratto di Marisa Merz sembra non finire mai, non ha inizio né fine visibili, tende all’infinito. Nello stesso tempo, quel termine ci fa riflettere sul fatto che l’opera, il disegno, ci si mostra anche nel suo stato di non-finito, come in una teoria di episodi inconclusi.
In questo caso i disegni, o forse l’intera opera di Marisa Merz, ci offrono davvero dei ritratti, non di lei ma di noi o di lei in quanto parte viva della comunità che il suo lavoro tematizza, il ritratto cioè di un soggetto calato nella sua infinitezza, nel senso di biologicamente, spiritualmente, culturalmente non-finito, e come tutti i viventi desideroso di infinito.