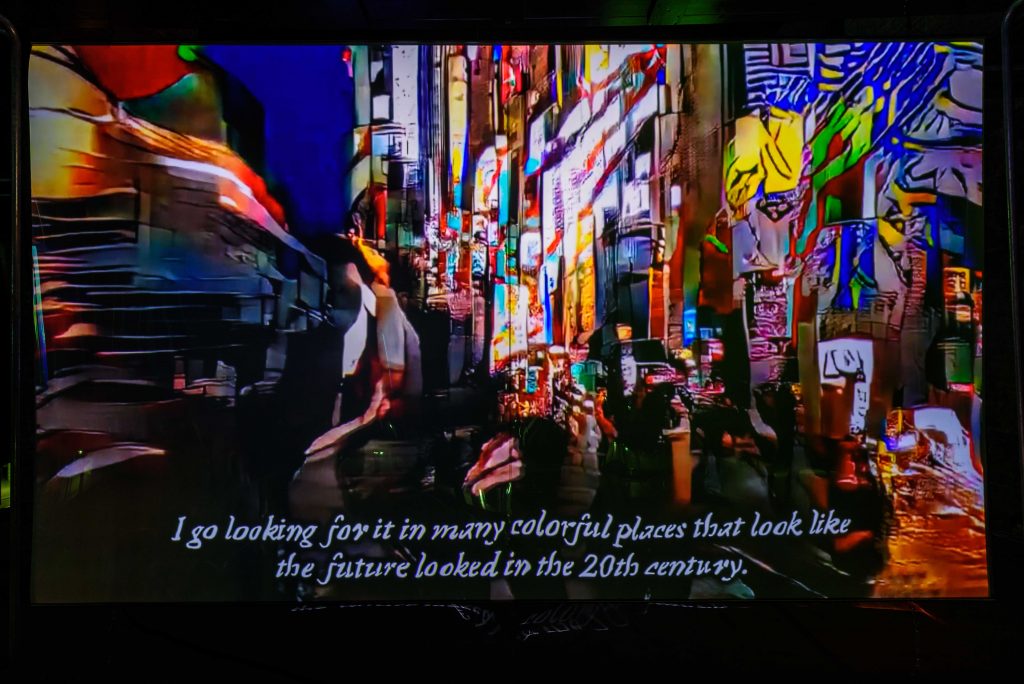Fotografia di Andrej Vasilenko.
Come si fa a scrivere una recensione per un’esposizione come la Biennale di Venezia, che comprende una grande mostra internazionale affiancata da una serie di proposte nazionali in diversi padiglioni, alcuni fortemente radicati e altri che scompaiono e riappaiono dalla mappa espositiva in funzione della geopolitica attuale?
È sempre una grande sfida. E, in un momento in cui il mondo è ancora una volta in crisi, appare come una sfida ancora più grande. Ogni volta che provo a recensire una piattaforma espositiva per la quale sono stati profusi tanti sforzi, da centinaia di partecipanti diversi, mi sento come paralizzata. Come muoversi per avvicinarsi a questa congerie culturale e artistica?
Che possano esserci diverse interpretazioni della stessa mostra sembra più che altro una questione di prospettiva – non necessariamente personale, amorfa o esclusivamente basata sul proprio gusto, sugli interessi professionali o sull’estetica – ma basata sul privilegio, sulla geografia, sulla cultura e forse sull’educazione. Alcune persone sono legate da un senso di vulnerabilità condivisa, unita a preoccupazione e carenze; altre si riparano sotto un ombrello di noia esistenziale, decadenza e abbondanza. Questi accorpamenti spontanei (che stavolta mi appaiono più evidenti che in qualsiasi altra edizione) sono palesati nei vari approcci artistici della biennale stessa, più ancora nei padiglioni – nel modo in cui si pongono in relazione tra loro “interlocalmente” – che nell’esposizione globale di Ralph Rugoff, che dà l’impressione di una performance di internazionalismo messa in scena dai “mercati dell’arte” di New York, Londra, Los Angeles, Berlino e così via.
Ora più che mai si ha la sensazione che il luogo di imbarco, quando ci si dirige a Venezia, in aereo o in treno, sia abbastanza rilevante per la successiva comprensione della biennale. Questa diversità di punti di partenza genera molteplici modi di vedere, comprendere e commemorare, compromettendo così le asimmetrie nella storia dell’arte e dell’esposizione. Nel determinare il significato storico di ogni edizione della biennale dovremmo valorizzare queste diverse prospettive alla pari, in quanto si completano a vicenda.
Tenendo presente questo (se siete arrivati fin qui) tenete anche a mente questo testo, che di per sé non è affatto completo (ma cosa, nella vita, lo è?).

Ho preso un aereo da Atene per Venezia il 7 maggio. La distanza è breve, un volo di poco meno di due ore, eppure il viaggio è stato piuttosto teso. Sono arrivata all’aeroporto internazionale di Atene e non vedevo l’ora di ritrovarmi con gli amici e visitare insieme la biennale, per poi scoprire che il volo era in overbooking. È stato difficile da accettare, considerando che avevo prenotato il biglietto sei mesi prima. Ho cercato di convincere il personale di terra che, in quanto professionista nell’arte, per me viaggiare era una “questione di vita o di morte”. Non avevo idea di quanto stesse accadendo. Tutti sembravano calmi e rassicuranti, come se fosse tutto normale. Fino al gate non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione. Pochi minuti prima dell’imbarco dei passeggeri, un funzionario dell’aeroporto ha provato a tranquillizzarmi: “Vede tutta questa gente?”, mi ha detto indicando la coda (formata da molte persone che conoscevo) “almeno dieci di loro non saliranno sull’aereo, perché saranno beccati con passaporti falsi. Purtroppo oggi è quasi la norma per i voli in partenza dalla Grecia. La compagnia lo sa, ed è per questo che accetta prenotazioni in eccesso”. Mi si è gelato il sangue. Mi è bastato un attimo per avere il quadro completo della situazione: la vivace folla di viaggiatori e amanti dell’arte è diventata, per una frazione di secondo, una fila piena di sospettati, ma ho subito scacciato questo pensiero involontario. La storia si è conclusa tragicamente (una tragedia quotidiana per alcuni, una vera questione di vita o di morte per gli altri). Dalla coda sono state eliminate diciassette persone, tra cui una famiglia con bambini molto piccoli. La speranza si è dissolta in agonia, le risate in lacrime nascoste, la dignità in umiliazione, il tutto in pochi minuti. Tutte le persone coinvolte sembravano scosse, anche i poliziotti (per quanto non sembrassero sorpresi). Solo la compagnia aerea aveva ricavato il meglio della situazione, avendo venduto più posti di quanti l’aereo ne potesse di fatto contenere. Cinico ma vero. Siamo arrivati in tarda serata. Sarebbe stato meraviglioso se tutti fossero arrivati come previsto. A quell’ora l’aeroporto di Venezia era quasi deserto.
La mattina dopo ho iniziato il mio tour partendo dall’Arsenale. Dopo quanto accaduto il giorno prima, Barca Nostra di Christoph Büchel (2018-2019), il pezzo più discusso di questa edizione, è stato difficile da digerire. L’opera, un autentico relitto di un peschereccio a bordo del quale nella notte del 18 aprile 2015 sono morte mille persone, non riesce a rappresentare né un ricordo della tragedia umana né un monumento alla migrazione contemporanea; è attraccata, completamente fuori contesto, accanto al caffè della biennale. Quello che mi ha scioccata maggiormente non è stata la volgarità dell’intervento, bensì il modo in cui si fondeva perfettamente allo spettacolo dell’arte contemporanea totalmente mercificata. Trasmetteva un cinismo non diverso da quello della suddetta compagnia aerea. Ordinaria amministrazione.

Non lontano da lì, il padiglione cileno ha controbilanciato la mia delusione e mi ha invogliata a continuare il percorso. La cosa più forte dell’intero progetto espositivo di Voluspa Jarpa è stata The Emancipating Opera (2019), un video in cui si sentono cantare in coro voci cosiddette “egemoniche” e “subalterne”. La vista inquietante dei pastori, che appaiono nelle vaste valli di presunti paesaggi cileni, intenti a narrare la propria cultura in toni operistici coloniali-europei, ha superato un altro progetto lirico: Sun & Sea (Marina) (2019) di Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė e Lina Lapelytė, al padiglione lituano, che ha ricevuto il Leone d’Oro. Splendidamente prodotta in ogni dettaglio, l’opera ha beneficiato delle interazioni con la comunità locale (come è stato esageratamente sottolineato in ogni occasione), eppure questo fattore ha costituito un problema. Cosa vuol dire, oggi a Venezia, vedere un gruppo di persone (tutti bianchi) che cantano ad alta voce le loro preoccupazioni per la distruzione dell’ambiente mentre se ne stanno in vacanza sulla spiaggia? Urla che la specie umana sta affondando nelle sue condotte biasimevoli. Un altro inno al cinismo è il progetto di Laure Prouvost per il padiglione francese, Deep See Blue surround You / Vois Ce Bleu Profond Te Fondre (2019), in cui un gruppo di hipster itineranti documenta un viaggio dalla Francia a Venezia, intrapreso per produrre e acquisire costosi manufatti in vetro di Murano, un’attività destinata a commentare il disastro ambientale. Perché? Solo perché possono… a differenza di tante altre persone oggi.
Un altro pezzo forte si trova nel padiglione albanese. Un nuovo e brillante video del giovane artista Driant Zeneli, giustamente intitolato Maybe the Cosmos is Not so Extraordinary (2019), indaga i codici del fallimento, dell’utopia e dei sogni, presentandoli tutti contemporaneamente come potenziali veicoli di cambiamento. Immagino quanto sarebbe stata diversa l’intera biennale se fosse stata impostata nell’ottica del titolo dell’opera di Zeneli, invece della maledizione cinese posticcia “che tu possa vivere in tempi interessanti”. E se avessi presentato alle persone fermate all’aeroporto di Atene con i documenti falsi la loro situazione come il risultato di un “periodo interessante” – invece che pericoloso (in linea con la lettura di questa frase a doppio legame) così interpretata dallo stesso Rugoff in un’intervista –?
La mostra principale dell’Arsenale offre senz’altro alcune opere d’arte forti, tra cui un paesaggio sonoro di Tarek Atoui, le nebulose fotografie di Stan Douglas e il nuotare distopico di Hito Steyerl su un presente e urgente monito per il futuro. Eppure la mancanza di contesto, di dialogo sostanziale e di affinità relazionali sensibili — così come l’uso apparentemente non troppo meditato del compensato per le strutture di supporto e divisori dello spazio, che hanno creato un inutile volume di rumore — non ha reso giustizia a esse. Gironzolando su e giù lungo l’Arsenale non sono riuscita ad allontanare quella sensazione di essere già entrata nelle sale di Art Basel (che inaugura a poca distanza da questa esposizione), e mi sono ritrovata a prendere appunti invece di cogliere la possibilità di rivisitare le opere in una più appropriata dimensione “espositiva”. Mi sono sentita meno in colpa per i miei pensieri quando un altro amico curatore, che stava annegando nel tedio, ha scherzosamente proposto di svignarsela per continuare a discutere nella sala VIP.
Lungo la via dall’Arsenale ai Giardini, una sosta al Padiglione di Cipro – che quest’anno ha celebrato il cinquantesimo anniversario della sua prima partecipazione ufficiale alla Biennale di Venezia come Stato indipendente – mi ha fatto ripensare all’idea di Rugoff sulla natura delle mega-mostre. Opere forti del tardo Chistoforos Savva (1924-1968) che non avevo mai visto prima, mostrano la necessità di rivisitare e ripristinare la legittimità dei modernismi in luoghi postcoloniali rispetto al canone occidentale. Eppure in questa edizione Rugoff ha voluto evitare, sbagliando, la coesistenza di differenti alternative storiche; il direttore ha dichiarato in una prima intervista che, a differenza di documenta 14 che esponeva molti artisti morti, avrebbe trattato esclusivamente il presente. Come se il momento presente non fosse in gran parte informato dalle assenze e dalle presenze del passato. Come se non fosse, finalmente, arrivato il tempo della riparazione.
L’Esposizione Internazionale nel padiglione principale dei Giardini ha raddoppiato la mia delusione e ha esaurito la mia speranza che quella di quest’anno sarebbe stata buona o almeno “interessante”. La raccolta di una manciata di opere di evidente valore, avrebbe dovuto essere di immenso aiuto, eppure la mancanza di intelligenza nella collocazione e di rilevanza qui è apparsa ancora più tragica. Persino i fastidiosi supporti in compensato dell’Arsenale avrebbero potuto contribuire a una maggiore unità di risultato. La mostra si presenta come un Gesamtkunstwerk in cui opere significative e sofisticate – come Walled Unwalled (2018) di Lawrence Abu Hamdan, che presenta una serie di casi legali le cui prove acustiche sono state raccolte spiando attraverso i muri, e Muro Ciudad Juárez di Teresa Margolles (2010), un vero e proprio muro che fa riferimento alla violenza tra droga e guerra, trasferito a Venezia dal Messico – si annullano a vicenda, poiché sono poste in contiguità, in un rapporto uno-a-uno (muro + violenza accanto al muro + violenza).
Un po’ più in alto, nell’ampio spazio centrale, una sequenza di dipinti di Julie Mehretu, Henry Taylor e George Condo, così come una nuova scultura in marmo di Jimmie Durham confinata in un angolo, sembrava lo spazio espositivo di una collezione privata. Forse con l’intento di emulare il successo di documenta 14, che ha invitato gli artisti prima a visitare e poi a esporre le loro opere in due topografie “europee” (Atene e Kassel), Rugoff ha invitato gli artisti a esporre le proprie opere sia nei Giardini sia all’Arsenale. Eppure la preoccupazione, qui, sembrava molto più spaziale che concettuale o sociopolitica.
All’esterno, nei giardini, dove prevaleva la danza, tutto appariva più luminoso. Sulla danza come espressione di oppressione, così come sulla disparità razziale e di genere, si concentrano almeno tre padiglioni: il brasiliano, lo svizzero e il coreano. Bárbara Wagner e Benjamin de Burca (Brasile), siren eun young jung e Hwayeon Nam (due delle tre artiste della splendida mostra del padiglione coreano) e il duo Pauline Boudry/Renate Lorenz (Svizzera) impiegano rispettivamente, collaborazione (con ballerine nere di strada – gender fluidity); ricerca approfondita (di performance tradizionali coreane, che sono state emarginate con la modernità); resistenza (alle attuali politiche governative attraverso la coreografia del sentimento negativo).
Il rituale è stato portato nel padiglione greco dove, durante i giorni di apertura, l’artista Panos Charalambous ha eseguito un’estatica danza senza tempo e ha sconfitto la gioia su un pavimento fatto di bicchieri. All’interno dello stesso spazio, i film di Eva Stefani danno spazio esclusivamente agli uomini per raccontare la loro quotidianità fallita, mentre Zafos Xagoraris fa luce su un periodo oscuro della storia greca come i travagliati anni della guerra civile, attraverso la presentazione di materiale d’archivio riguardante l’affitto del padiglione nel 1948 a Peggy Guggenheim, in un momento in cui gli intellettuali greci costretti erano costretti ai campi di concentramento. Il mascheramento della facciata del padiglione, affinché apparisse come nel 1948, ha funzionato in modo piuttosto efficace e mi ha spinto a prestare maggiore attenzione al padiglione del Venezuela – un capolavoro architettonico di Scarpa –, quest’anno chiuso e abbandonato. Disgraziatamente questo gesto involontario ha rappresentato una delle dichiarazioni più potenti di questa edizione!

Qual è il ruolo dell’arte, alla fine dei conti? Per chi è fatta? Per amore di essa o per una società più ampia? Così come le risposte a queste domande non dovrebbero essere binarie, allo stesso modo non dovrebbero neanche generare “doppi vincoli”. Anche se noi, in quanto membri del mondo dell’arte, fingiamo collettivamente che non lo siano, lo sono, e molto. È ovvio che qualsiasi forma di esercizio artistico e intellettuale – ricerca, creazione, produzione – comporta dilemmi intrinseci e richieste contrastanti. La chiave è nel modo in cui vengono imposti e in chi (o cosa) impone queste richieste al “soggetto”. La complessità solleva domande e fa spazio a idee e voci autenticamente diverse, ma può anche essere la forma più efficace di comando, in quanto affronta tutti i diversi scenari eliminando quindi critiche e resistenze. Questa norma può prevedere molte eccezioni, purtroppo sinora troppo poche.
Il momento che ho preferito di questa biennale si è svolto nel padiglione del Canada. L’opera che ho trovato mi ha rincuorata, riportandomi al dibattito su ciò che nella vita ha ancora un vero significato. La prima società di produzione canadese Inuit, fondata da Zacharias Kunuk, Paul Apak Angilirq e Norman Cohn a Igloolik, Nunavut, presenta un film online accessibile anche alle comunità Inuit remote attraverso una rete di server locali. A un certo punto del film un funzionario governativo canadese offre a uno dei personaggi principali, un anziano nella comunità Inuit, la possibilità di avere un reddito mensile a patto di trasferirsi in città. L’anziano Inuit risponde con una domanda: “A cosa servono i soldi?”
Tra cinismo, oscurità egoistica, retorica sterile e soluzioni false questo è il momento per cercare soluzioni diverse. Il prossimo passo dovrebbe essere la fecondazione incrociata. Basta non lasciare che una parte della popolazione faccia il lavoro sporco di salvare il pianeta per tutti.