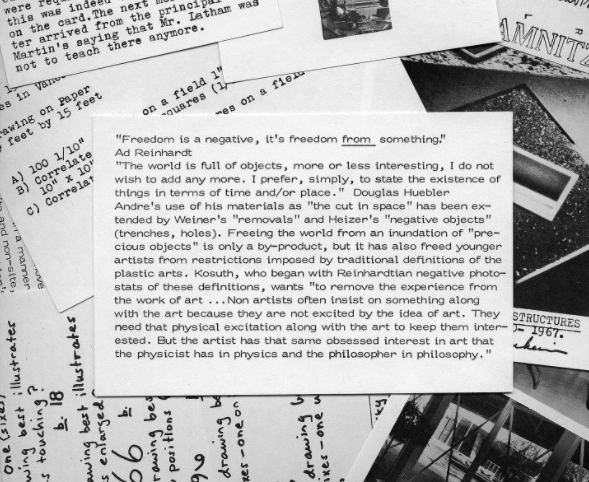Un famoso testo di Francis Fukuyama dal significativo titolo La fine della storia, che ha regalato all’autore una certa notorietà internazionale, sosteneva che, con la fine del socialismo reale conseguente alla caduta del muro di Berlino, l’organizzazione sociale ed economica globale avesse ormai preso una direzione ineluttabile, quella dell’affermazione definitiva del capitalismo come paradigma dei paesi industriali avanzati e come modello per quelli emergenti e in via di sviluppo, segnando così la fine dell’evoluzione socioculturale dell’umanità e offrendo un modello normativo che ogni società e cultura non sufficientemente “sviluppata” avrebbe dovuto abbracciare nel proprio interesse. Per quanto il voler sostenere che l’evoluzione socioculturale umana possa avere fine sia bizzarro in sé, nel momento in cui Fukuyama pubblicava il suo saggio — e cioè nel 1992, a pochi anni dalla caduta del Muro, riprendendo e ampliando un suo precedente articolo del 1989 praticamente coevo all’evento stesso — si poteva in effetti avere la sensazione che, di fronte allo spettacolare fallimento di un sistema che aveva condizionato, attraverso la logorante dialettica della Guerra Fredda, l’intera seconda parte del Novecento, e alla conseguente e trionfante legittimazione del suo antagonista, il capitalismo appunto, non fosse possibile neanche soltanto immaginare una forma alternativa di regolazione di società complesse e globali come quelle attuali. Eppure, mai idea è stata più fuorviante: se infatti il capitalismo aveva dimostrato “sul campo” e inequivocabilmente la sua superiorità rispetto al socialismo reale, ciò non voleva dire che il capitalismo fosse, in sé, capace di auto-regolarsi in modo efficiente e soprattutto sostenibile. I decenni che sono trascorsi da quel momento di euforia ideologica ci hanno insegnato molte, amare lezioni. Pur nella sua ricchezza di varianti socio-culturali, il capitalismo ha evidenziato nel tempo limiti profondi, alcuni dei quali difficili da prevedere: per esempio, la sua azione profonda sulla psiche delle persone, che, come mostrato dallo psicologo Oliver James nel suo Il capitalista egoista (Codice edizioni, Torino 2009), investe tutte le sfere della vita — non soltanto, come sarebbe lecito aspettarsi, quella lavorativa, ma anche quella affettiva, quella relazionale, finendo di fatto per condizionare pesantemente lo sviluppo della personalità. Questa azione ha a che fare soprattutto — e ciò è davvero paradossale per un modello di organizzazione sociale fondato su principi di natura in primo luogo economica — con la distruzione del concetto di valore: nell’orizzonte psico-culturale del capitalismo prevale infatti il pensiero strumentale che svuota progressivamente di senso la motivazione intrinseca, il fare qualcosa perché ha un significato in sé, per sostituirlo con la motivazione strumentale, che porta a fare qualcosa soltanto se e in quanto ci permette di ottenere qualcos’altro, che a sua volta sarà strumentale a qualcos’altro ancora, e così via, annullando di fatto ogni possibilità di dare a un oggetto o a un’esperienza un valore proprio. Nella logica strumentale, si è sempre portati a chiedersi “cosa c’è sotto” qualunque scelta o comportamento, da quale tornaconto tragga origine. E in questi casi è inutile rispondere che interessa il valore di un gesto o l’adesione a un principio: l’effetto che si ottiene è quello di essere guardati con diffidenza, perché una risposta del genere, agli occhi del ragionamento strumentale, non può essere che una prova dell’effettiva esistenza di un calcolo dissimulato, di una convenienza troppo oscura per essere confessabile. Il risultato di tutto ciò, naturalmente, è il deserto mentale e affettivo: l’impossibilità di dare un valore intrinseco ai significati e alle relazioni con gli altri crea una vera e propria anoressia emozionale che viene “curata” con varie forme, spesso devastanti, di consumo compulsivo delle più varie specie. Oggi ci è chiaro che il capitalismo non può essere la fine della Storia, e non a caso sta emergendo rapidamente un nuovo modello di organizzazione socio-economica basato sul coordinamento sociale e sulla condivisione che, guarda caso, si regge proprio sull’attribuire valore al riconoscimento che gli altri ci concedono di fronte a scelte che beneficiano un gruppo più ampio — ed è proprio per essere stata una pioniera di questa razionalità sociale del “fare insieme” che Elinor Ostrom ha ricevuto, prima donna nella storia, il Premio Nobel per l’Economia nel 2009.

Alighiero Boetti ci ha ampiamente preceduto in questo lungo e travagliato percorso di consapevolezza, mettendo in primo luogo in discussione l’assurda pretesa di centralità politica e culturale che l’Occidente avanzava come conseguenza naturale della tesi del primato del capitalismo. Con il suo gesto radicale, la scelta di Kabul, vale a dire il margine del margine, una frontiera mentalmente remota, un luogo talmente esotico da non poter essere nemmeno trendy come l’India tanto amata dalle popstar del tempo, Boetti rovescia il capitalismo globale della prima fase sulle sue fondamenta, lo mette letteralmente a testa in giù. Ne anticipa la mutazione profonda e inevitabile, quella della delocalizzazione della produzione, dello sradicamento del rapporto con lo spazio e con le persone che lo abitano, ma allo stesso tempo lo rovescia poeticamente nella costruzione di una relazione che si fonda proprio sulla pratica del fare, sulla manualità più arcaica che unisce persone provenienti da storie e luoghi lontanissimi tra loro. In Afghanistan Boetti fa davvero l’imprenditore, apre la sua factory, gestisce il suo albergo. Ma si tratta di gesti privi di valore programmatico, non c’è niente da dimostrare. Sono atti di creazione di possibilità, modi di organizzare la vita piuttosto che di farsela organizzare dal mercato. Boetti non ha tempo da perdere mettendosi a fare soldi.
E cosa è importante, allora? La risposta è facile. Boetti si richiama continuamente al gioco, cioè alla pratica che più radicalmente nega la strumentalità. Il gioco trae il suo senso dalle sue regole e, nella sua forma più appagante, non produce nessun’altra implicazione che non sia il prendervi parte. Ed è allora proprio per questo che, in un’epoca dominata dal pensiero strumentale, si tende ingenuamente a pensare che l’esperienza del gioco sia costituzionalmente legata al mondo dell’infanzia, che gli adulti possano dirsi tali proprio perché sono usciti dall’epoca dei giochi, e finalmente “fanno sul serio”. Ma chiunque abbia giocato una sola volta in vita sua sa quanto ci sia di sciocco in questo modo di esprimersi, che tradisce un pensiero altrettanto povero: nella vita non esiste nulla di più serio del gioco, nulla che richieda una dedizione più totale. Ed è proprio questa pratica della dedizione che si manifesta costantemente nel metodo di Boetti, nel suo procedere per azioni che chiedono tanto, tantissimo tempo e tante, tantissime energie. Ancora una volta, un rovesciamento poetico della logica dell’efficienza capitalistica che trae il suo stesso fondamento dal risparmiare il più possibile tempo ed energie per raggiungere uno scopo. La logica strumentale, peraltro, perverte anche l’efficienza, che diventa riduzione indiscriminata dei costi e dissimulazione della perdita della qualità dei prodotti — per cui in ultima analisi le risorse che potevano essere impiegate per fare un buon prodotto finiscono per essere destinate a convincere i consumatori a comprarlo comunque, buono o cattivo che sia, utile o inutile, benefico e tossico.

Con qualche decennio di anticipo su di noi, Boetti aveva capito benissimo che il vedere il tempo e le proprie stesse energie come vincoli da ottimizzare piuttosto che come opportunità indispensabili di creazione di significato implica una straordinaria immaturità psicologica ed affettiva, e con generosità ha provato a rimediare, proponendosi, con sobrietà e discrezione, di mettere al mondo il mondo, di accompagnarlo in una fase adulta forzando il blocco della rimozione più perniciosa: quella di fraintendere i propri stessi segni evidenti di immaturità come il loro contrario, come una manifestazione di autonomia e di capacità di governare la propria vita. Boetti decostruisce la “realtà” del capitalismo senza alcuna supponenza intellettuale, esce dallo spazio fisico dell’Occidente e allo stesso tempo esce da se stesso con una tale semplicità e naturalezza da poter essere capito solo a decenni di distanza, quando ormai è tutto lì, davanti ai nostri occhi.
Boetti ci ha offerto in dono un dispositivo potente, che se opportunamente applicato può aiutarci a evadere dalla trappola che ci siamo costruiti da soli. Nel frattempo, non siamo più i padroni dell’economia globale. Altre storie, altre culture stanno guadagnando spazio, e contrariamente a quanto pensavano tanti maître à penser occidentali, sembrano non avere particolare intenzione di prenderci a modello, di camminare rispettosamente sulle nostre orme, di conquistarsi da noi la patente di bravi allievi promossi dal rango di paese sottosviluppato o emergente a quello di paese sviluppato — cioè assimilato alle regole del capitalismo fatte da noi.
Mettere al mondo il mondo. Mettersi, letteralmente, nelle mani degli altri. Far parlare, letteralmente, le mani. Lasciare libera l’opera di auto-generarsi, sottraendosi al controllo della propria soggettività. Dare un’anima alla serialità. Abbracciare il tempo. Fare della geopolitica oggetto di contemplazione. Fare della catalogazione un esercizio di responsabilità. Annullarsi nella progressione. È arrivato il tempo di Boetti. Sapremo accorgercene in tempo?