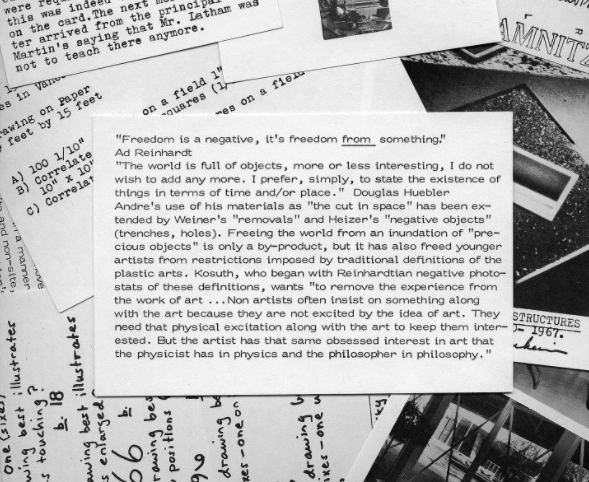“Ciao Vettor, sono Patrizia, allora confermiamo per domani?”
“Cara, certo, come stai? Ma sono a Napoli, la facciamo qui l’intervista?”
“È difficile, ma dai a questo punto ci vediamo quando torni: ma quando torni?”
“Non lo so, qui sto bene. Ma mi piacerebbe molto sottopormi all’intervista. Quando torno ti chiamo.”
Sono partita ripromettendomi che la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata richiamare Vettor. L’ho risentito in un sogno, mi ripeteva la solita frase: “Appena arrivi chiamami che vengo ad aprirti il cancello”. Il cancello della sua casa-studio affacciata sul Cimitero degli Inglesi, zona Piramide, era aperto, e ad aspettarmi c’era un insolito gatto dagli occhi cerulei e malinconici che mi fissava immobile come una sfinge.
Questa cronaca di un’intervista annunciata ha assunto un tono drammatico una certa mattina di piena estate, un senso postumo declinato da quella sua ultima performance estrema dell’altrove, nella quale si è permesso il lusso di legare abilmente il destino ai lacci con i quali appendeva le sue sculture al soffitto. Da quel momento gli spazi bianchi tra le domande hanno assunto il peso tragico dell’assenza. La morte dà la misura alla vita, “Se fossimo immortali saremmo immorali” diceva Pasolini, mentre per Pessoa “Morire è solo non essere visto”. Per Morin invece “Il segreto dell’adolescenza è che vivere significa rischiare la morte, che il furore di vivere è l’impossibilità di vivere”. Questo Vettor lo sapeva bene, era uno che aveva a che fare tutti i giorni con i capricci del suo implacabile e imbronciato eterno adolescente-bambino interiore. Vettor, artista complesso ed enigmatico dell’incertezza e del dubbio filosofico, ci ha messo sotto scacco con la sua domanda radicale. Uno che ha sempre preferito gli interrogativi aperti alla chiusura delle risposte, anche se lo divertiva molto “sottoporsi” al gioco del piccolo psicanalista nel ruolo di paziente d’eccezione, in un setting di circostanza a tre, io, lui e Giancarlo (Politi), quando gli chiedevamo di raccontarci sogni a occhi aperti, incubi ricorrenti, strategie di resistenza personale e creativa rispetto al sistema, il suo punto di vista sulla realtà delle correnti migratorie come agenti trasformatori dell’identità occidentale, con eventuali ricadute sulla valutazione estetica di un’opera, una prospettiva che ultimamente lo intrigava non poco. Parlavamo di come vivesse il sesso e il denaro, la vita e la morte, del suo legame con De Dominicis e Carmelo Bene, da cosa o da chi il suo beneamato angelo lo proteggesse. Probabilmente a quest’ultima avrebbe risposto da “me stesso”, ma questa volta non ha funzionato, o forse sì, secondo la sua logica. Una logica precisa e radicale da artista totale, che è stata il suo filo di Arianna nel territorio borderline della soglia linguistica e filosofica spinta fino al baratro, meta del viaggio a tappe tra dramma e parodia nei punti nevralgici della storia e della geografia dell’arte, al cospetto dei suoi fratelli subliminali e degli amici elettivi in uno zapping sconcertante. Progettando luoghi contemplativi e onirici, eremi abitati da presenze occulte e familiari, erranti ed eretiche, dal Museo globale e personale dell’inconscio collettivo, a quello della Catastrofe fino al Manicomio Rosacroce a Serre di Rapolano, crea un paesaggio day after, una delirante cartografia ballardiana all’insegna dell’ibridazione. Una narrazione in cui, a partire dal “costante tormentone autobiografico”, convergono personale e universale, passato e futuro, terribilità del sacro e sublimazioni intrecciate a un eros infarcito di thanatos, spleen e feticismo. L’universo di Vettor è una galassia aliena, un buco nero popolato di vergini e femme fatale, sfingi e marionette, spose e celibi, simulacri e ossessioni, all’insegna di catastrofi ed epifanie, esoterismo e alchimia, totem e tabù da violare, tra verità e mistificazione punteggiato da isole dei morti e dimore surreali abitate da metamorfosi in vitro di androgini divisi e ricomposti, come in uno spiazzante labirinto di specchi. Un complesso sistema mutante e interattivo da leggersi come un ipertesto dove i dubbi e le nevrosi individuali si ampliano in termini epocali e universali. Nel viaggio abissale di sola andata, si è accompagnato costantemente (per assicurarsi comunque la possibilità del ritorno) a Mimma, poetessa e autrice, moglie e compagna proiettiva e protettiva, doppio artistico a cui è legato, dagli esordi, tramite un perfetto sodalizio sentimentale ed estetico, a cominciare proprio da Lo Scorrevole, inquietante perfomance del 1972 in cui una donna nuda era sospesa a un ingranaggio, come una sorta di macchina celibe duchampiana, “tesa e attenta sulla punta dei piedi per evitare di cadere impiccata nel gioco della macchina, nella messa in scena del ‘Teatro della paralisi’” come scriveva Achille Bonito Oliva, acutissimo e creativo interprete della sua poetica, nonché assiduo compagno di strada.

Vettor e Mimma: un legame a doppio filo che si dipana fino a quella mattina di piena estate proseguendo potenzialmente all’infinito come spesso dichiaravano. Hanno interpretato efficacemente il ruolo della coppia simbiotica e dark della scena artistica contemporanea, da veri o presunti ultimi romantici. A questo proposito, Vettor mi precisava con tutta la sua lucida follia che “in realtà noi viviamo sempre nel romanticismo, perché ciò che rende romantica la vita è il tempo sfuggente, la coscienza della morte: il passato è un qualcosa che si autodistrugge, per cui tutto ciò che abbiamo è l’istante presente come una specie di fuga all’infinito. La condizione romantica ha a che fare con una serie di stati psicologici che riguardano la condizione dell’artista che non è una professione né un mestiere di lusso o enfatico, quanto una dimensione dove tra esistenza e progetto del mondo non c’è differenza. Io sono e basta, non c’è divisione tra l’uomo e l’artista. Parlo di una capacità visionaria, vedi Patrizia, io credo negli spiriti reincarnati, vivo per percezioni, per magnetismo animale, come Beuys in fondo (…). Praticare l’invisibile richiede una particolare percezione che è di tutti i grandi artisti, per questo esistono le iniziazioni, perché attraverso un apprendistato si riesce a fare il salto sullo spazio della morte, sulla bara”. La morte di un artista sollecita implacabilmente la domanda sulla sua opera mancata; in questo caso penso che la risposta la fornisca Borges, uno degli autori più amati da entrambi (con Beuys, Duchamp, Klein, Khnopff, Böcklin, Freud, Jung, Wittgenstein, Nietzsche, Heidegger, Durand, Dalì e Moreau, Mallarmé, Bataille, Proust, i filosofi greci) con una poesia, Undending Gift: “Un pittore ci promise un quadro. Adesso, nel New England so che è morto. Ho sentito, come altre volte, la tristezza di capire che siamo come un sogno. Ho pensato all’uomo e al quadro perduti (soltanto gli dei possono promettere perché sono immortali). Ho pensato al luogo prestabilito che la tela non occuperà. Poi ho pensato: se la tela fosse lì, diverrebbe con il tempo quella cosa in più, una cosa, una delle vanità o abitudini della mia casa, adesso è illimitata, incessante, capace di qualunque forma e di qualunque colore e non legata a nessuno. Essa esiste in qualche modo. Vivrà e crescerà come una musica e rimarrà con me fino alla fine. Grazie”. Ma conclude Borges, “Anche gli uomini possono promettere perché nella promessa c’è qualcosa di immortale”: guardandola in filigrana l’opera di Vettor assume le sembianze della tela di ragno, metafora perfetta di un’architettura fatale e imponderabile, enigmatica e ironica, alla luce dell’illuminazione orientale e del sincretismo culturale, con le ombre della consapevolezza della crisi di un Occidente al tramonto, tessuta con il filo dell’eterno ritorno. Potenzialmente infinita.
Un’opera come un organismo unico che sopravvive inglobando il suo autore in quel “qualcosa di immortale”, come la tela di Borges. La promessa, per quanto mi riguarda, l’ha mantenuta: un’opera su tavola double face, dove su un lato campeggia la scritta “Nekia memorie dall’aldilà”, accanto a una piramide essenziale su fondo nero e rosso, mentre dall’altro lato una figura leggera di luce che danza su un fondo blu, il suo colore preferito. La morte in certi casi è una liberazione, ed è proprio dopo la morte di un grande artista “che si tirano le fila misteriose che stabiliscono la sua immortalità”, scriveva Susan Sontag a proposito del capolavoro di Machado De Assis, Memorie dall’aldilà, unico esempio di biografia immaginaria che Vettor non poteva non conoscere, condividendone il senso ironico, affettuoso e tagliente del postumo. Un qualcosa che lo lega a due artisti come Maurizio Cattelan e De Dominicis, con il quale aveva un profondo sodalizio e con cui condivideva, oltre ai temi trascendenti e al pensiero controcorrente di impronta dadaista, la passione per la filosofia e l’architettura, il gusto della domanda come nella memorabile performance “condivisa” del 1971 Che cosa c’entra la morte?, dove De Dominicis indossava la maschera grottesca di impresario delle pompe funebri. Tutto il lavoro di Vettor si può leggere come una ricerca artistica postuma espressa in prima persona, con un dichiarato distacco, seducente disincanto e radicale scetticismo, una vena di misantropia e una costante aura melanconica, sottilmente ipocondriaca. A tratti, paranoia e collera implacabile come quella espressa dal suo ultimo lavoro, che cela nell’energia provocatoria e sarcasticamente delirante la silenziosa disperazione di una consapevolezza spinta all’estremo che può ribaltarsi in una prospettiva paradossalmente comica come antidoto alla cronaca assurda dell’umanità e alla pantomima politica. Affermando la fede cieca e assoluta verso l’arte come unica forma praticabile di libertà e anarchia, Vettor autore rizomatico, aperto a un molteplice senza soluzione di continuità come nei cicli carmici, è l’esponente di una generazione e ancora più precisamente di una casta di irregolari, della generazione degli anni Sessanta-Settanta con De Dominicis, Cintoli, Lo Savio, Manzoni. Anni vissuti alla luce di un costante rimando speculare tra le acquisizioni estetiche ed esistenziali e quelle di un contesto a sua volta alle prese con contenuti di perdita nell’idea ricorrente di fine dell’arte e del sistema, dell’autore e del soggetto, tutti paradossalmente digeriti e metabolizzati dall’arte e dal sistema stesso. Opponendo alla poetica affascinante dei materiali dell’Arte Povera la nuda logica della presentazione tautologica, Vettor Cavaliere dell’Apocalisse ha cavalcato il concetto di morte dell’arte nella spinta ad attraversare e superarne la nozione tradizionale, scavando un profondo solco per il futuro, lasciando un’eredità forte per le ultime generazioni. Dall’intreccio tra ricerca estetica ed esistenziale, con tutte le contraddizioni in termini di una simile scelta, si può restare soffocati. Soffocati da un eccesso, una febbrilità che può in certi casi bruciare fino all’annientamento, da cui non si esce se non con il silenzio dell’assenza. Nell’assenza di luogo dove il simulacro dell’arte nella vita e viceversa si consuma al cospetto delle spoglie della Storia, l’esistenza dell’autore assume un senso mitico e romantico estremo, in quel sostare su una soglia duchampiana, un confine slittante vissuto come continua ricerca di infinito. Una lama di rasoio, la corda tesa del dubbio, un limen fluido che coniuga gli opposti, e oltrepassa ruoli, generi e linguaggi sfidando le ideologie nella progettazione di uno spazio borderline, uno spazio dell’immaginario in tutta la sua estensione. Lo spazio della follia come stato originario e non alterato, e dell’irrazionale che Vettor teorizza attraverso originali incursioni nei territori della psicanalisi, è uno dei punti cruciali della sua ricerca, che l’artista, in virtù di un talento naturale e a fronte di grandi capacita pneumatiche, sperimenta senza restarne inghiottito. Viaggiando nell’invisibile con senso del rischio e consapevole della violenza del sacro, profanando gli eterni nodi gordiani e le grandi rimozioni dell’umanità, Vettor pensava che “L’arte potesse ancora contribuire a salvare il destino del mondo, cioè a impedire che l’essere affondi ulteriormente e ineluttabilmente, può avere una funzione di salvagente; il cosmo è infinito e può darsi ci sia una possibilità di salvezza anche se io ho sempre detto che l’arte non salverà il mondo. Forse salverà le donne, alcune donne…”. Speriamo di far parte della schiera delle elette, angeli e demoni, sante e puttane, sfingi e pin-up, sorelle incestuose e spose mistiche, prima fra tutte il suo alter ego femminile, Mimma, la sua “gattona carmica” e lui a sua detta il “suo topolino”, reincarnatosi in quel gatto nero dagli occhi cerulei che mi fissava nel sogno. L’ultimo tiro mancino di Vettor per rendersi inafferrabile, sfatando l’ultimo dei tabù. La tessitura perfetta di arte e vita disegnata dalla sua opera declinata su un eterno ritorno traducibile in una straordinaria fantasia di immortalità, la sua tela infinita, non si è conclusa per uno che ha confessato di avere “vissuto molteplici vite, almeno centocinquantatré”, da “artista bambino, fannullone e paranoico di Melanie Klein”.

Ciao Vettor, artista malinconico e anomalo, “singolare e plurale, più unico che raro, insondabile e confuso, con un io molto ingombrante e catastrofico, incomprensibile, poco visibile agli altri” che ha confessato che di vite ne ha già vissute molte, “almeno centocinquantatré”.