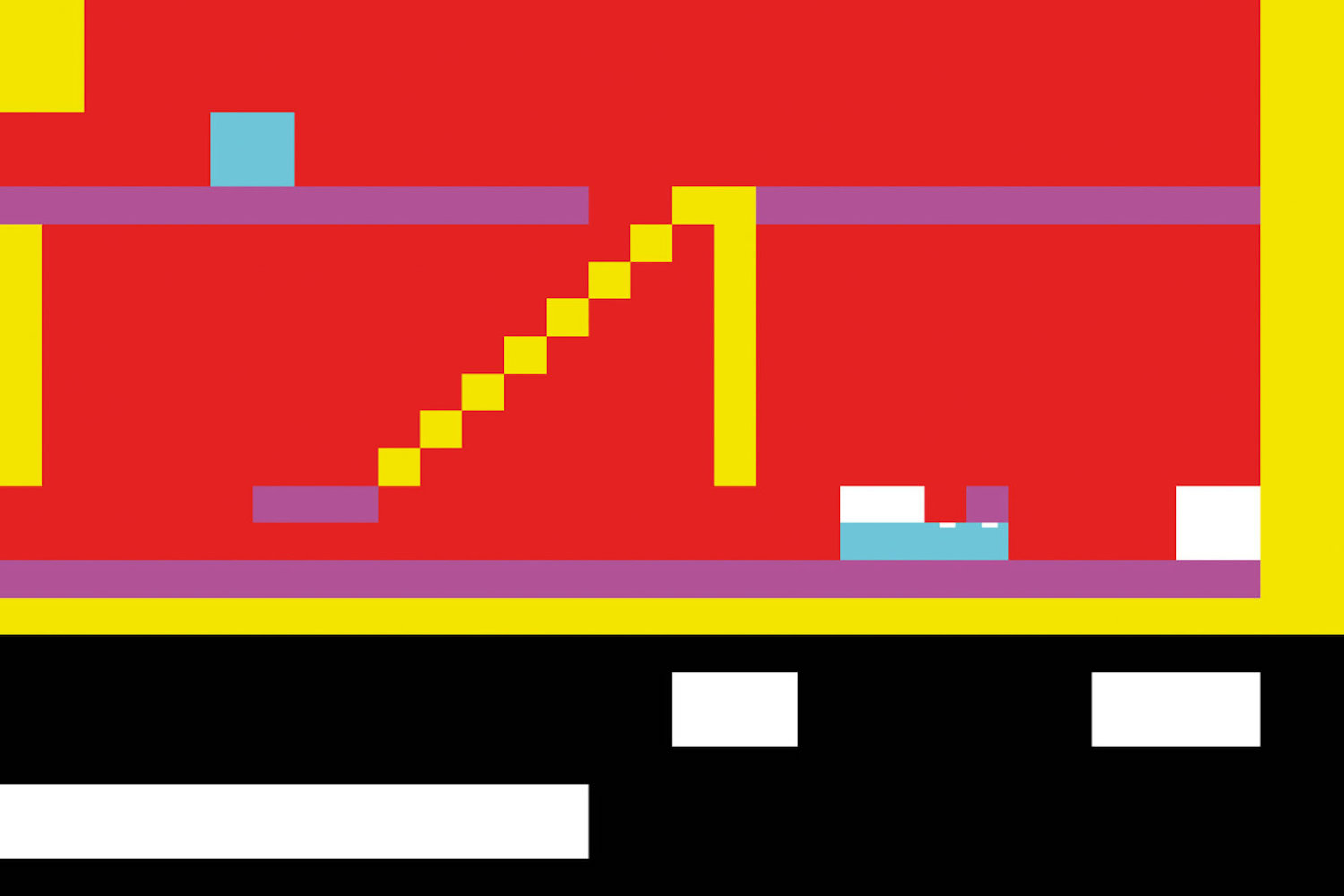Massimiliano Gioni: Il tuo lavoro è sempre aggressivo, quasi “sbattuto in faccia”. Lo ritieni ostile?
Monica Bonvicini: Non trovo il mio lavoro particolarmente aggressivo e credo che questo sia un aspetto che è stato eccessivamente enfatizzato. Negli anni, mi sono stati offerti spazi in gallerie o istituzioni, o perfino opere di altri artisti, da distruggere… non ho ancora accettato nessuna di queste offerte. Non sono interessata al concetto di distruzione/rovina da parco dei divertimenti. L’atto di distruzione è spesso visto come violento, ma a volte è necessario. Non distruggo per sentirmi meglio: non faccio arte al posto di yoga o terapia. Daniel Buren ha detto: “Uso il mio lavoro in senso generale, cerco di usarlo come un’attrezzo o come un’arma” e non penso che il suo lavoro sia mai stato recepito come particolarmente aggressivo. Mi piacciono molto alcune opere degli anni Settanta, pure molto dirette, come alcune performance di Valie Export o Allan Sekula, installazioni di Matta-Clark, Michael Asher, lavori di Lee Lozano, Lawrence Weiner o Adrian Piper… potrei andare avanti.
MG: Che tipo di lavori ti piacciono?
MB: Mi piacciono lavori senza trucchi, mistero, miti, senza sublimazione. Mi piace l’arte in cui l’idea e la sua traduzione in un’opera siano tutt’uno. Mi piace l’affermazione “what you see is what you get”, che intende una conoscenza a priori e un’esperienza nel vedere e nel recepire arte. Per intenderci, non sono una fan del wonderbra.
MG: Che scopo ha l’arte? Che scopo ha la tua arte?
MB: Per me l’arte, quando è buona, è come lo squillo di una sveglia. In questo senso, sono contenta che tutti i lavori “chilling” degli anni Novanta siano finiti. Che scopo abbia la mia arte non è una domanda a cui io posso rispondere. Non posso dare manuali d’istruzione a riguardo. Il mio approccio all’arte ha molto a che fare con l’arte stessa. Riguarda il domandarsi cosa sia l’arte, il sistema dell’arte e il relativo ruolo dell’artista al suo interno. Penso che l’arte possa elaborare così tante cose a un livello diverso rispetto alla letteratura, alla politica o a qualsiasi altra cosa. Allo stesso tempo il “non detto, il non parlato” dell’arte non è un campo di confusione o di ossessione personale; c’è un linguaggio molto specifico in arte, c’è una Storia e un sapere a cui riferirsi.
MG: Hai menzionato la Storia e la cultura, e c’è spesso un riferimento all’arte minimale nel tuo lavoro, o usi un vocabolario preso da movimenti artistici precedenti. Pensi che il tuo lavoro sia come un parassita sui lavori precedenti. Lo giudichi come un’appropriazione?
MB: La questione del riferimento storico è molto importante per me e si riflette in molti dei miei lavori. Trovo sia necessario relazionarsi a ciò che è accaduto prima, perché è il passato che ha reso le cose come sono ora. Il passato permette una profonda lettura e comprensione di situazioni contemporanee e delle loro implicazioni, che è essenziale in questi tempi di amnesia culturale e politica. Penso che la Storia dell’Arte sia semplicemente parte del vocabolario di ogni artista. Non molti dei miei lavori si rifanno al Minimalismo: Bedtimesquare e Minimal Romantik sono sicuramente associati a esso: sono consciamente un commento su specifici lavori di Carl Andre e Sol LeWitt, provando a cambiarli, aggiungendo un po’ di humour “per smussarne gli angoli”… le sculture in mattoni 7:30 h assomigliano a opere minimali degli anni Settanta, ma di fatto sono le prove pratiche finali per gli apprendisti muratori in Germania. Don’t Miss a Sec è fondamentalmente un commento sui padiglioni di Dan Graham e sull’idea di trasparenza nel Modernismo — abbastanza cinico. La videoinstallazione Take One Square or Two tratta la diversità nella produzione artistica di artiste e artisti alla fine degli anni Sessanta, inizio anni Settanta, ed è ispirata dalle performance di quel periodo di Valie Export e Bruce Nauman, la prima lavorava per la strada, il secondo in uno studio… Il rapporto con la Storia dell’Arte non è mai stato facile per le artiste donne. A cosa ci si può relazionare? A una Storia che ha in gran parte ignorato il loro lavoro? Di tanto in tanto ho il bisogno di dire qualcosa al riguardo.
MG: A cosa tu o il tuo lavoro siete contro?
MB: Non mi piacciono il pathos, i lavori didattici, l’ornamento e il formalismo, la ripetizione, la pigrizia nel pensare.

MG: Diresti che il tuo lavoro è femminista? L’arte ha un genere?
MB: No, l’arte non ha genere. Non si mette il rossetto o agita un pene. Quelli che la fanno, che ne scrivono, che la vedono, la comprano e la vendono hanno un genere. Ho iniziato a lavorare con la tematica del genere negli anni Novanta. I miei lavori che rielaborano la costruzione dell’identità sessuale attraverso l’architettura sono stati definiti femministi. In un secondo tempo mi sono più interessata ad approfondire l’identità femminile e a criticare quella maschile. Mi ricordo che negli anni Novanta ero quasi seccata da chi mi chiedeva se fossi femminista perché davo per scontato che ogni donna lo fosse dopo le battaglie degli anni Settanta. Credevo anche che, visto il successo della teoria del genere, sarebbe stato più semplice parlare e trovare un pubblico per certi argomenti; purtroppo mi sono sbagliata. Ho un approccio femminista riguardo a molte questioni. Nei miei lavori parlo dell’impossibilità di definire un genere nell’architettura delle identità sociali, culturali, economiche e politiche, e in tutto ciò metto in discussione qualsiasi stereotipo. Penso sia superato parlare di arte femminista oggi, dopo l’“invasione della teoria del genere”, ma soprattutto adesso, in un momento così conservatore, è ancora molto importante. È impossibile pensare all’Arte Concettuale, all’Art & Language o alla performance senza considerare le artiste che con i loro lavori hanno fondamentalmente influenzato tali discipline. Sono d’accordo con lo psicanalista Umberto Galimberti quando dice che le più grandi rivoluzioni nella Storia hanno qualcosa a che fare con l’emancipazione delle donne. Comunque, tutti possono mettersi il rossetto, e agitare un pene è una cosa facile da organizzare…
MG: Come hai appena detto, il legame tra l’architettura e il genere è uno dei temi cruciali che affiora in molti dei tuoi lavori, da Wallfuckin’n (1995) a Take one Square or Two (2001), Destroy She Said (1999), Eternmale (2000), I Believe in the Skin of Things as in That of Women (1999) o in molti tuoi disegni e graffiti. Come sei arrivata a odiare l’architettura? E te ne importa ancora?
MB: Quando ero studente all’Accademia di Berlino, ho cominciato ad annoiarmi di leggere di arte e ho iniziato a interessarmi di letteratura sull’architettura, per via della filosofia e stranamente a causa del libro All the things I know but of which I am not at the moment thinking di Robert Barry. Il linguaggio è sempre stato un tema centrale per me. Il primo multiplo che ho fatto nel ’93 era una citazione di Thomas Bernhard sulla necessità di un uomo di camminare 15 o 20 passi indisturbato in una direzione di una stanza… Leggere saggi o interviste con Tschumi o Eisenman, Loos, Site e altri è stato molto divertente e ha influenzato il mio modo di pensare, subito dopo ho iniziato a leggere di genere e di architettura. Se si lavora con la scultura o in maniera installativa è quasi impossibile non considerare l’architettura, in effetti la mia formazione intellettuale è stata concettualmente influenzata dal Minimalismo che ha definito l’idea di scultura come architettura. Non ho mai fatto un lavoro su un edificio particolare, non sono interessata a criticare uno specifico architetto, e se, perché è qualcuno (ed è quasi sempre un lui) che ha rappresentato, influenzato, in maniera esemplare la cultura e il modo di fare/pensare l’architettura in un certo periodo. La maggior parte degli architetti erano/sono anche scrittori versatili e scrivono quasi su tutto. Io sono interessata all’architettura tout court. Uno può, se vuole, evitare la gente, ma con l’architettura si ha sempre da fare… In questo senso forse la odio, come limitazione di spazio con cui si ha sempre da fare. Tutti hanno bisogno di un tetto, qualche parete, a volte alcune porte… Non esiste memoria, identità senza architettura: è qualcosa di talmente indispensabile ed elementare, che può allo stesso tempo svilupparsi in forme virtuose di tutti i tipi (e non sto solo parlando del lato materiale/costruttivo dell’architettura). Il sistema dell’architettura è uno specchio di quello dell’arte: solo più grande, più ricco e più complesso, non solo nelle sue implicazioni politiche.
MG: Ho la sensazione che il tuo lavoro sia passato da un riferimento più preciso all’architettura a una riflessione più subdola o complessa sul desiderio, che è un altro elemento ricorrente nel tuo lavoro, come in Stonewall, Black, Blind Shot (WallSucker) e in molti dei recenti disegni in bianco e nero con riferimenti alla rivolta. Uno dei tuoi lavori è intitolato semplicemente Desire. Quindi vorrei chiederti una cosa molto semplice o forse perfino stupida: perché il desiderio è così importante?
MB: La “madre dell’arte” (l’architettura) è impregnata di desiderio… Il primo lavoro con evidenti riferimenti estetici S/M è Fetishism of Commodity (dal ben noto saggio di Marx), che ha preso spunto da ciò che definisco il “feticismo materiale” nei lavori di Mies van der Rohe. L’opera Desire è una scultura su larga scala fatta di alluminio e lettere in acciaio inossidabile lucidato che riflettono ciò che succede di fronte: il desiderio non è mai in uno stato di immobilità. Anche Turning Walls è una scultura che si confronta con un “desiderio” architettonico dal carattere più popolare: la creatività casalinga del design di strada americano espresso nella creazione di cancelli, ringhiere, ecc. “‘Il desiderio’ di architettura è ‘inciso nella pietra’ ma così è la violenza che porta alla sua soddisfazione” scrive N. Leach. Il lavoro Built for Crime si riferisce anche a questo: non c’è rivoluzione senza architettura e non c’è rivoluzione senza desiderio. Il desiderio è uno stato d’essere, non è un problema. Nei recenti disegni e dipinti in bianco e nero su larga scala, ho unito immagini di edifici a citazioni relative al concetto di rivolta di Anaïs Nin, Julia Kristeva e Anne Sexton. Nessuna rivolta senza desiderio. E niente di tutto questo senza il femminismo.

MG: Sei una sadica? O una masochista? Nei confronti degli spettatori intendo…
MB: Verso gli spettatori forse un po’ sadica: perché chiedo, esigo una reazione. Sono una sadica soft, se vuoi. Nel senso che cerco la discussione, non la devozione.
MG: Cosa ti piace di più, il cuoio o il cemento?
MB: Entrambi: il cuoio per camminarci dentro, il cemento per camminarci sopra.
MG: Come inizi un’opera?
MB: Di solito ho un’idea relativa a un tema. Inizio facendo dei disegni, collage, usando, ad esempio, piantine, fotografie degli spazi in cui sarà esposto il lavoro, immagini che ho trovato, testi che ho letto… In effetti credo di lavorare con i “cuts” di W. S. Borroughs. Di solito ho un’idea chiara di come sarà il lavoro: la sua dimensione, i materiali e così via. La parte più difficile è iniziare qualcosa di nuovo. Il processo è sempre difficile: come scegliere in che direzione andare, quale parola scegliere.
MG: La mostra “Not for You” che hai realizzato la scorsa estate come secondo progetto di “West of Rome Inc.” era probabilmente la più impegnativa che hai messo assieme. Come è stato lavorare a questo progetto?
MB: Lavorare per la mostra a Pasadena è stato molto interessante soprattutto per il tipo di spazio che avevo a disposizione e per il suo volume: non proprio modesto. Ho ricoperto l’intera superficie con l’installazione Plastered. La gallerista Emi Fontana ha fatto un ottimo lavoro nel trovare uno spazio perfetto per i miei lavori. Una mostra gigantesca in un centro commerciale, in un negozio vuoto, eccitante. Trovare una mostra di questo tipo in un posto così è stata una sorpresa per molta gente. L’attività commerciale era fallita, il negozio vuoto, ma le sue insegne erano ancora appese sulla facciata dell’edificio: le ho fatte accendere di sera durante il periodo della mostra. La frase illuminata “Organized Living” si legava perfettamente con Desire, Stonewall e i quattro disegni con citazioni sul vetro infrangibile in mostra nelle vetrine del negozio. Il concetto di “West of Rome” è trovare posti mai usati prima per mostre nei quali l’artista può ottenere dei risultati che non sarebbero mai possibili in una galleria o in un museo. Il principio di “West of Rome” è quello di mettere sotto i riflettori alcuni luoghi all’interno del tessuto urbano. L’idea mi piace molto anche perché penso che tutte le istituzioni d’arte, musei, collezioni, accademie dovrebbero essere costruite e buttate giù ogni cinque anni…